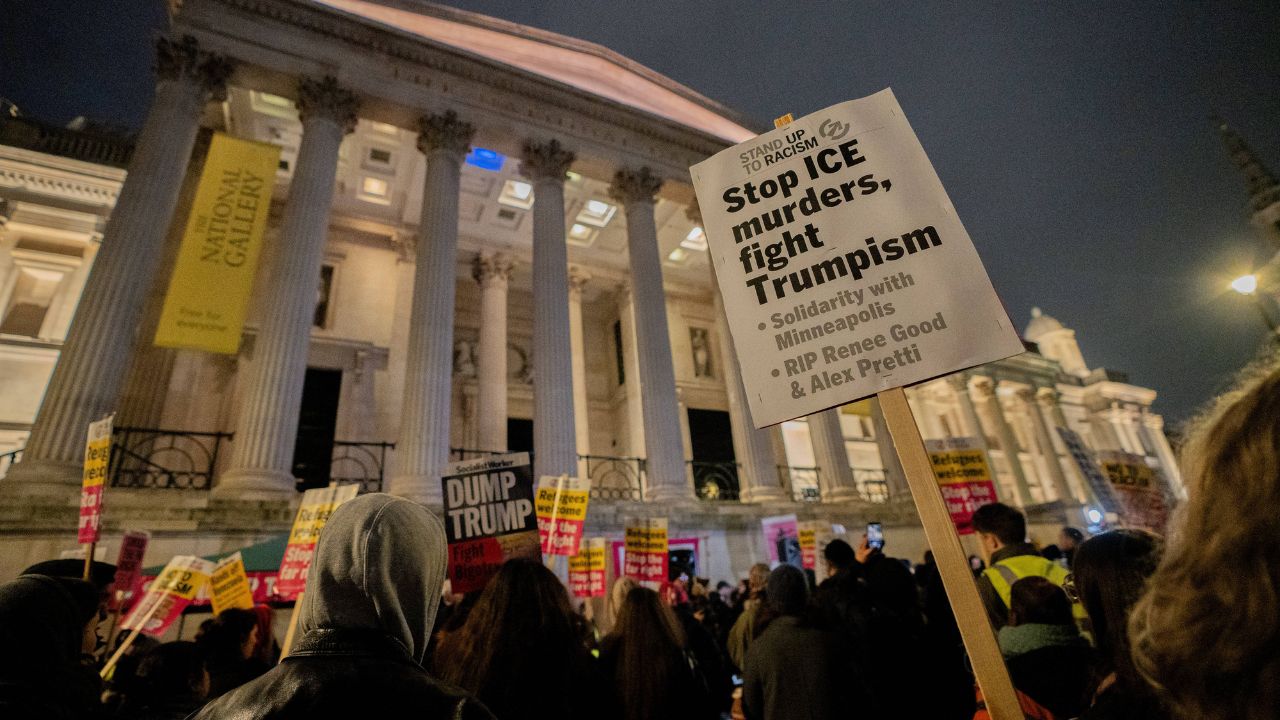La fotografia dell’Italia scattata dalle statistiche del ministero dell’Interno per il 2024 è nitida e, per certi versi, inquietante. I reati tornano a salire, la micro-criminalità rialza la testa e il tessuto sociale, già provato da anni di shock economici e tensioni internazionali, mostra segni evidenti di fragilità. I numeri non lasciano spazio a interpretazioni: 2,38 milioni di reati denunciati alle autorità, l’1,7% in più rispetto al 2023, e un incremento del 3,4% rispetto all’ultimo anno pre-Covid. È il quarto aumento consecutivo, il secondo oltre i livelli del 2019.
Milano guida la classifica nazionale per denunce ogni 100mila abitanti, seguita da Firenze e Roma. Tre città simbolo, tre poli attrattivi che ogni giorno accolgono turisti, studenti, pendolari, ma che oggi fanno i conti con l’altra faccia della vivacità urbana: quella degli scippi nei pressi delle stazioni, delle case violate, delle rapine improvvise. È in queste metropoli che si concentra il 23,5% degli illeciti segnalati.
Le forze dell’ordine sottolineano che, sui grandi numeri, pesa la presenza di city user e visitatori, soprattutto nei centri turistici. Ma resta un dato strutturale: ciò che sembrava un picco transitorio nel post-pandemia è diventato tendenza stabile. La linea della criminalità ha cambiato pendenza e il calo costante registrato fino al 2019 appare oggi un ricordo lontano.
«Tralasciando il calo anomalo del 2020, ora assistiamo a una risalita fisiologica», ha spiegato Marco Dugato, ricercatore dell’osservatorio Transcrime dell’Università Cattolica. Una normalizzazione, certo, ma che trova carburante in difficoltà economiche diffuse, in nuove marginalità e nelle tensioni globali che si riflettono sulle città.
Nel dettaglio, i furti restano il cuore della micro-criminalità italiana: rappresentano il 44% delle denunce e crescono del 3%. Aumentano quelli in abitazione (+4,9%), i furti d’auto (+2,3%), gli scippi (+1,7%) e i borseggi (+0,6%). Sono dati che riportano in primo piano il quotidiano, l’insicurezza che si insinua nei pianerottoli, nelle metropolitane, nei quartieri dove un portone che non si chiude o un lampione spento diventa preludio di timori reali. E se su un periodo lungo i furti restano inferiori ai livelli di dieci anni fa, l’inversione del trend suggerisce prudenza.
A preoccupare è anche il ritorno vigoroso delle rapine (+1,8%) e dei reati legati agli stupefacenti (+3,9%). Le violenze sessuali crescono del 7,5%, un dato che, oltre all’aumento degli episodi, riflette anche una maggiore propensione alla denuncia, frutto di consapevolezza e sensibilizzazione. In controtendenza truffe informatiche, contrabbando e incendi: dopo anni di crescita, gli attacchi digitali si riducono del 6,5%, un segnale che potrebbe indicare più capacità di difesa da parte dei cittadini e maggiori controlli.
Ma è tra i più giovani che l’allarme vira verso l’urgenza. I minori denunciati, fermati o arrestati nel 2024 sono stati 38.247: il 30% in più rispetto al 2019, il dato più alto dell’ultimo decennio. Un fenomeno che colpisce soprattutto il Nord, con Treviso in testa: quasi un minorenne denunciato su dieci sul totale delle persone finite in procura. Nelle grandi città, dalle rapine ai danneggiamenti, fino agli episodi collegati allo spaccio, la frattura sociale post-pandemia si trasforma in atti concreti, in baby gang che marchiano piazze e centri commerciali, in un disagio che non trova anticorpi.
Il sindaco di Treviso ha parlato apertamente di «episodi legati allo spaccio e di risposta immediata delle forze dell’ordine», lamentando però un sistema sanzionatorio percepito come inefficace, dove fogli di via e Daspo spesso non fanno paura. È una linea condivisa da molti amministratori: repressione e controllo, certo, ma accanto a essi la richiesta di politiche educative strutturate, perché la sicurezza non si gioca solo nei posti di blocco ma anche nelle scuole, nei quartieri, nelle periferie lasciate troppo a lungo indietro.
L’Italia che emerge dai dati è dunque un Paese attraversato da correnti diverse. Da un lato, un apparato di sicurezza che continua a intercettare, monitorare e reprimere; dall’altro, una rete sociale che mostra lacerazioni profonde. Le città crescono, attirano, mescolano, ma faticano a restare comunità coese. Così, mentre le tabelle statistiche tracciano numeri e percentuali, dietro la matematica emergono storie di tossicodipendenza, di vulnerabilità economica, di famiglie fragili, di ragazzi che bruciano tappe, e di cittadini che tornano a chiudere due volte la porta la sera.
Non c’è panico, ma una consapevolezza diffusa: la curva si muove, e serve tenerla d’occhio. La sicurezza torna tema centrale, non come grido ideologico ma come esigenza concreta di chi vive la strada ogni giorno. Le città sono il barometro del Paese, e oggi, ancora una volta, segnalano pressione in aumento.