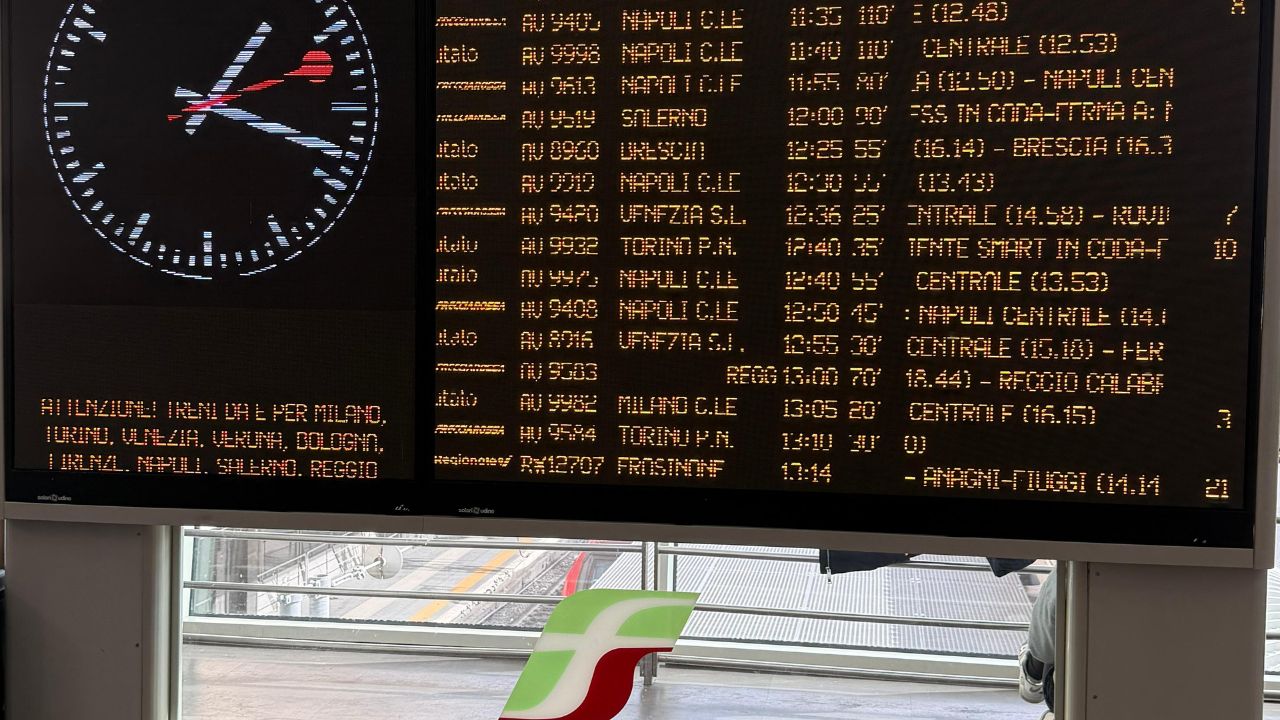Ci sono uomini che parlano troppo, uomini che non parlano mai, e poi c’è un uomo che parla quando gli altri tacciono e questo oggi è Nicola Gratteri, non per santità civile, non per superiorità morale, non per vocazione profetica ma per assenza, per il vuoto che lo circonda, per il silenzio che avvolge un intero ordine dello Stato mentre si prepara un referendum che interviene sull’architettura costituzionale della giustizia italiana e non si sente una voce collettiva, non un documento forte, non una presa di posizione corale che spieghi ai cittadini cosa significa davvero intervenire sull’equilibrio tra i poteri, cosa comporta modificare il CSM, cosa implica ridisegnare un potere che la Costituzione definisce autonomo e indipendente; c’è un uomo che parla e attorno a lui un deserto. Le sue parole sulla Calabria sono state prese a pezzi, amputate, isolate dal contesto come si isola una frase per farla sembrare veleno, è stato fatto circolare il frammento più duro, quello più utile allo scandalo, quello capace di produrre indignazione immediata, ed è stata costruita una narrazione semplice, quasi infantile: Gratteri contro i calabresi, Gratteri che insulta la sua terra, Gratteri che divide. Ma la realtà non è infantile, è tragica, stratificata, imperfetta. Non è una difesa cieca la mia.
Gratteri ha sbagliato nel tempo nella sua sovraesposizione mediatica, è diventato volto televisivo, magistrato simbolo, presenza costante nei talk show, molti lo percepiscono come “l’unico magistrato d’Italia” ed è un errore pericoloso perché la magistratura non può ridursi a un volto, probabilmente c’è stata anche una quota di ego, una disponibilità eccessiva alla luce dei riflettori, ma l’errore di tono non giustifica la manipolazione del contenuto e soprattutto non giustifica l’accanimento. È ingeneroso trattarlo come un irresponsabile, è un uomo che vive sotto scorta da trent’anni, che conosce la Calabria non dai salotti ma dalle carte giudiziarie, dai nomi, dalle parentele, dalle reti invisibili del potere grigio, si può dissentire dalle sue parole, si può ritenerle eccessive, si può criticarne la forma, ma fingere che non conosca ciò di cui parla è intellettualmente disonesto e ai calabresi, con rispetto ma senza ipocrisia, va detto che mettere la testa sotto la sabbia non è mai stato un atto d’amore verso la propria terra, le zone grigie esistono, i compromessi esistono, i silenzi esistono e non si cancellano negandoli. Le reazioni hanno superato la soglia della critica e sono entrate nella delegittimazione: il ministro Carlo Nordio che evoca test psico-attitudinali per i magistrati, Matteo Salvini che in più occasioni parla di toghe politicizzate, Giorgia Meloni che richiama la necessità di riequilibrare un potere percepito come ostile, una narrazione che torna ciclicamente a evocare le “toghe rosse” come categoria simbolica, quasi un corpo ideologico contrapposto alla volontà popolare.
Non è un episodio isolato. È un linguaggio che si inserisce in una tradizione politica precisa. Questo conflitto non nasce oggi. Ha radici profonde, affonda nella stagione in cui Silvio Berlusconi trasformò lo scontro con la magistratura in paradigma politico permanente, presentando le inchieste non come esercizio della giurisdizione ma come attacco politico. Da allora, in forme diverse e con intensità variabile, l’idea di una magistratura come controparte ideologica ha attraversato il discorso pubblico italiano. E qui il piano cambia, perché una cosa è dissentire da un magistrato e un’altra è insinuare che non sia idoneo, una cosa è proporre una riforma e un’altra è accompagnarla con l’idea di dover raddrizzare un potere deviato. Quando dall’ esecutivo si evocano verifiche psicologiche per un magistrato in carica non siamo più nella dialettica democratica ma nel territorio simbolico del sospetto istituzionale, non è un atto giuridico ma è un messaggio e i messaggi in democrazia contano quanto le leggi. Quando ogni problema del Paese, dalla sicurezza all’immigrazione fino ai ritardi amministrativi, viene ricondotto alla responsabilità di una magistratura che blocca, ostacola, interferisce, non si sta discutendo una singola decisione ma si sta costruendo un racconto in cui il controllore diventa il problema. E qui si misura la tenuta di una democrazia: nel momento in cui chi è sottoposto alla legge pretende di valutare l’equilibrio di chi la applica, nel momento in cui chi è controllato rivendica il diritto di misurare l’idoneità del controllore, l’equilibrio si sposta, non per una norma ma per una cultura.
Prima di parlare di vergogna per la Calabria, Roberto Occhiuto dovrebbe interrogarsi sulle scelte politiche che hanno inciso sulla credibilità delle istituzioni regionali, dimissioni strategiche, candidature blindate, rielezioni certe non sono dettagli tecnici ma scelte che pesano sulla qualità democratica e la dignità di una terra non si difende con un comunicato o un post sui social ma con decisioni coerenti, i calabresi non sono soltanto vittime di narrazioni esterne ma cittadini ed elettori, parte attiva degli equilibri che si consolidano, il silenzio non è sempre innocenza, talvolta è complicità. E tuttavia la domanda più scomoda e dolorosa riguarda la magistratura stessa: dove sono gli altri, perché in un momento così delicato, in cui si discute di riforma costituzionale non c’è una voce collettiva forte, perché si lascia che la battaglia la conducano altri o un uomo solo, la magistratura non può ridursi a delegare la propria voce a un volto e non può aspettarsi che siano altri a difenderne l’autonomia mentre essa tace, il silenzio può essere prudenza, rigore e rispetto istituzionale ma può diventare abdicazione. Il punto non è Gratteri, non è il suo carattere, non è la sua esposizione mediatica, il punto è l’equilibrio tra i poteri dello Stato, una democrazia costituzionale vive di conflitto regolato e non di delegittimazione, il Governo può riformare, il Parlamento può modificare, la magistratura può dissentire ma nessun potere dovrebbe rappresentare l’altro come strutturalmente deviato, perché non è l’uomo a far paura ma l’idea che un potere possa essere raddrizzato come si raddrizza un ramo storto, e quando il potere comincia a parlare dell’equilibrio mentale di chi lo controlla, quando il controllato pretende di misurare l’idoneità del controllore, non sta più discutendo una riforma, sta segnando un confine, e le Costituzioni non crollano in un giorno, si consumano lentamente nel linguaggio, quando smettiamo di chiamare limite ciò che è limite e cominciamo a chiamarlo ostacolo.
Francesco Vilotta