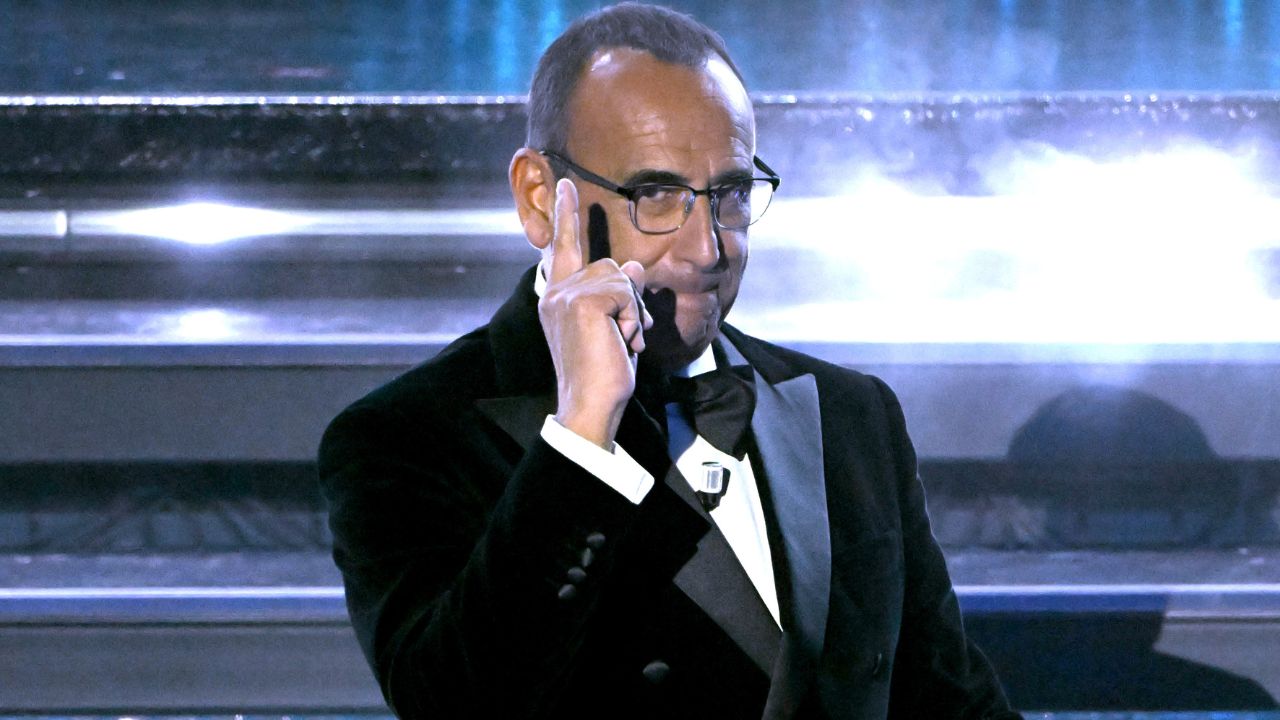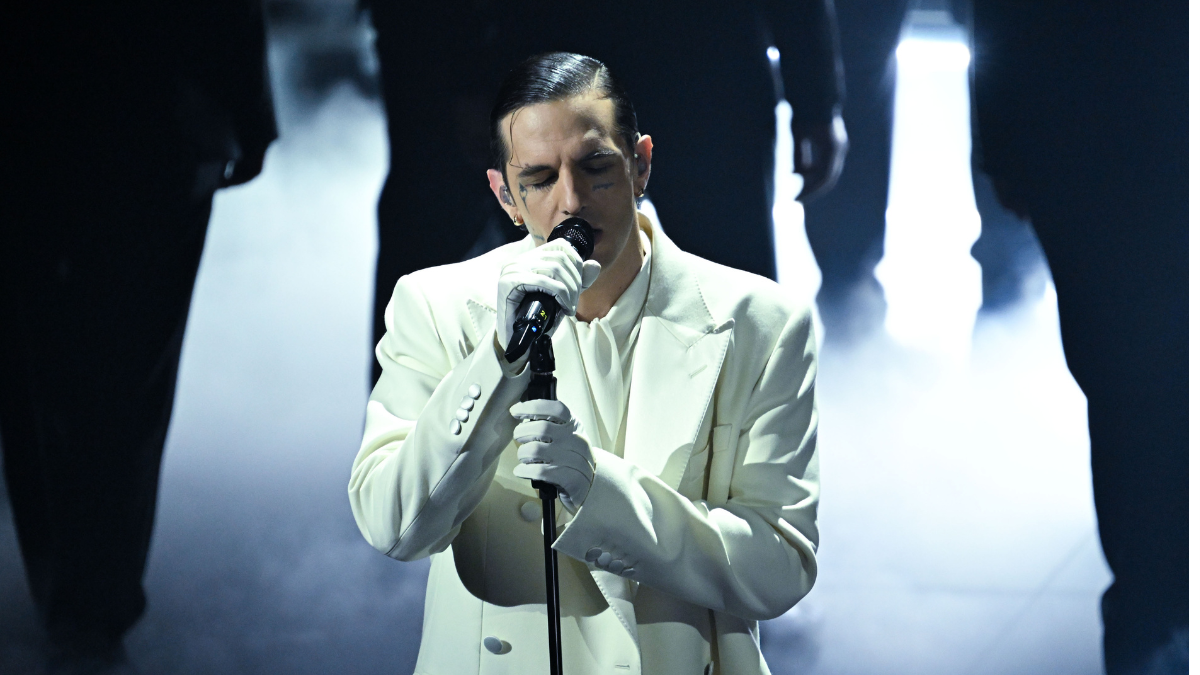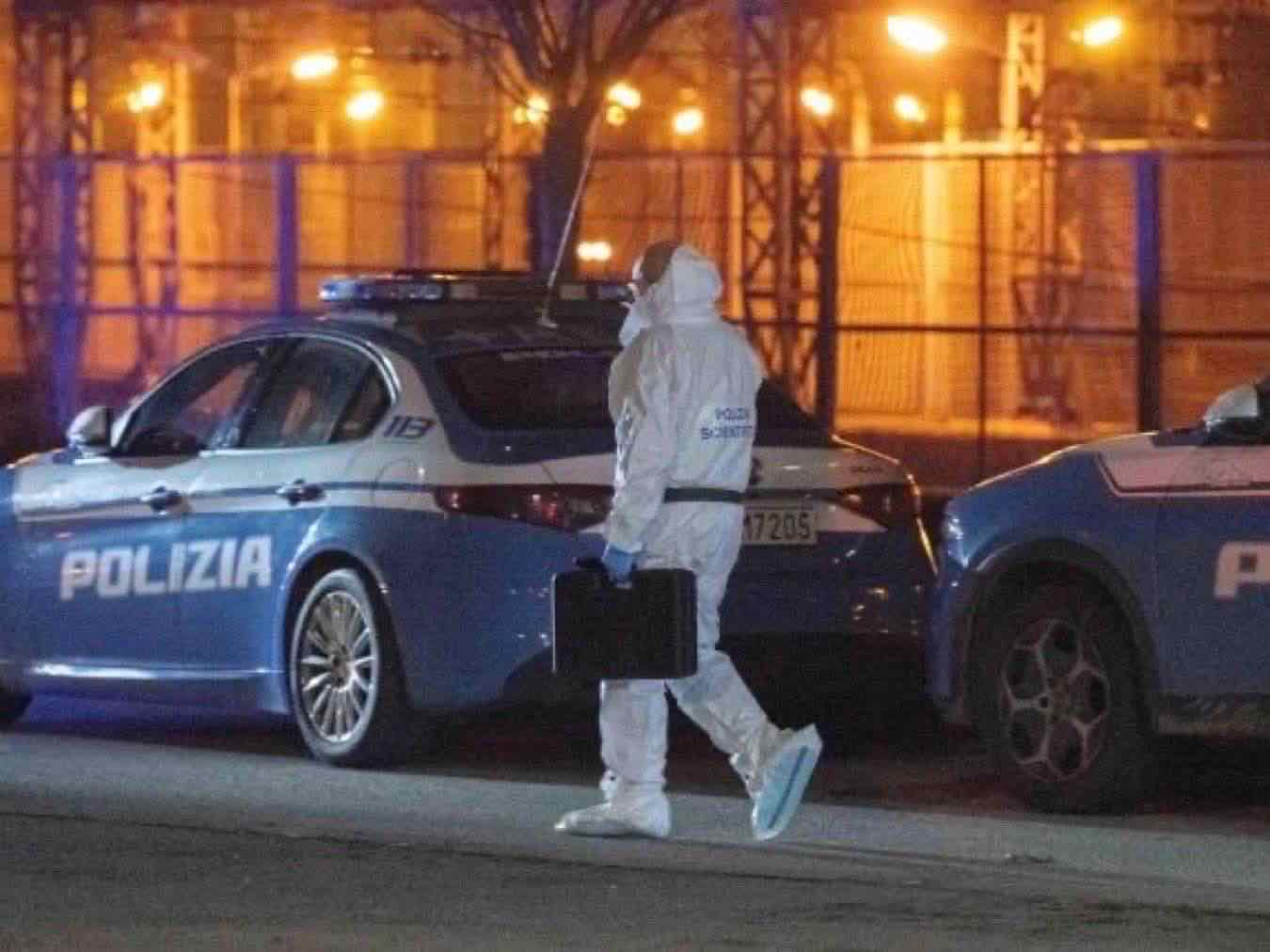Ci sono momenti in cui la storia smette di essere cronaca e torna a essere coscienza. Le piazze di queste settimane — da Roma a Londra, da Parigi a Buenos Aires — sono questo: un grido collettivo che si alza per Gaza, ma che in realtà parla a tutto l’umano.
Si chiama sumud, in arabo: resistenza, ostinazione dell’essere. È la stessa parola che dà nome alla Flottiglia per la libertà, partita dal Mediterraneo con uomini e donne venuti da ogni parte del mondo, civili che portano aiuti e verità là dove le bombe hanno cancellato i nomi. In quelle mani che sollevano cartelli, in quei corpi che sfilano per le strade, c’è un gesto antico e semplice: dire no alla disumanità.
Non è solo una protesta: è una presa di coscienza civile, etica, morale e politica. Perché quello che accade a Gaza non è una guerra. Una guerra, per definizione, presuppone due eserciti. Qui invece c’è un esercito e un popolo disarmato, e la sproporzione è tale da cancellare ogni ambiguità. È genocidio, parola che molti temono, ma che è l’unica capace di nominare ciò che vediamo: la distruzione sistematica di un popolo, di una speranza, di un’idea stessa di umanità.
Eppure, se questa mobilitazione saprà allargare lo sguardo — se collegherà il destino di Gaza a quello delle nostre periferie, ai tagli, alle diseguaglianze, alla miseria prodotta da decenni di politiche di austerità — allora qualcosa, forse, potrà cambiare davvero. Perché la giustizia, quando comincia a muoversi, non conosce confini.
La verità taciuta
Ma la verità — quella intera, scomoda, sporca — va detta. Questa tragedia non nasce oggi. È una ferita che sanguina da decenni, ignorata dai notiziari, dai governi, da chi avrebbe dovuto vigilare. Nessuno, o quasi negli anni passati, ha voluto leggere i rapporti di Amnesty International, quelli di Save the Children sulla Palestina, le denunce sulle uccisioni dei bambini, sulle detenzioni, sulle terre espropriate, sull’uso sistematico della tortura nelle carceri israeliane. Tutto questo accadeva già ieri, molto prima del 2025. Solo che allora faceva comodo non vedere. Ecco perché i nostri governi hanno così paura di quella parola — genocidio. Perché riconoscerla significherebbe ammettere la propria complicità. Davanti a un genocidio, non ci si può più girare dall’altra parte: si deve agire. E l’Occidente, l’Italia compresa, non vuole farlo. Oggi il pretesto si chiama Hamas. Nessuno nega le atrocità commesse, nessuno le giustifica.
Ma è necessario capire — capire, non assolvere — che l’estremismo nasce sempre dove l’uomo non ha più speranza. Quando un popolo è derubato della propria terra, dei propri figli, della libertà di respirare, cresce la disperazione, e con essa la rabbia, la radicalizzazione, il fanatismo. Hamas non è la causa: è l’effetto di un’ingiustizia protratta nel tempo. E dietro la condanna di facciata si cela un’altra barbarie: la censura da parte del Governo e di certi organi di informazione. I morti si contano, ma non si raccontano. I corpi torturati non vengono restituiti alle famiglie, perché quei corpi parlano, gridano ciò che Israele non vuole far vedere.
Le domande che non vogliamo ascoltare
E allora, davanti a questo silenzio, le domande si impongono. Come può una società civile come Israele, che si proclama democratica, arrivare a tali punte di disumanità? Come può la comunità internazionale restare ferma, muta, complice? Come possono i politici italiani — dai palazzi romani ai consigli regionali e comunali — piegarsi al silenzio o, peggio, giustificare? È paura di perdere voti? O solo l’ennesimo calcolo di opportunismo? Se vogliamo capire, dobbiamo tornare alle cause reali. Quando si scambia l’effetto per la causa — Hamas per la radice del male — allora sì, ci stanno buttando fumo negli occhi.
L’ombra del Grande Israele
Oggi 138 Paesi su 193 riconoscono lo Stato di Palestina. L’Italia no. Perché non può, o perché non vuole? Forse perché ha smesso da tempo di essere sovrana, se mai lo è stata. Perché la sua voce è quella di chi obbedisce a un ordine più grande, scritto altrove. Dietro le quinte della politica mondiale, Israele e Iran si sono spartiti il mondo arabo come due potenze imperiali. Con Israele stanno l’Egitto, la Giordania, l’Arabia Saudita, gli Emirati, il Bahrain: monarchie che si aggrappano all’ombrello israeliano come bambini spaventati, perché il loro nemico comune si chiama Iran.
Ma “stare con Israele” cosa significa, davvero? Significa stare sotto protezione, accettare di vivere all’ombra della sua potenza nucleare. Tutto nasce da lontano, dalla ritirata americana. Nei primi dieci anni di questo secolo, dopo i disastri in Iraq e in Afghanistan, gli Stati Uniti decisero di arretrare. Avevano devastato quei territori in nome della libertà, lasciando dietro di sé sabbia e sangue. Avevano garantito se stessi, non la pace: avevano trasformato la democrazia in una brand identity esportabile. Poi, sazi della propria arroganza e forti dello sfruttamento e dell’indipendenza energetica raggiunta, si ritirarono. O meglio, simularono una ritirata. Perché i soldati forse andarono via, ma il potere restò. E nel vuoto lasciato dagli americani, i loro protetti si scoprirono nudi, smarriti, fragili. Fu allora che arrivò la proposta più cinica del secolo: “Lasciatevi proteggere da Israele.”
Gli Accordi di Abramo: la pace degli interessi
Nel 2020 nascono così gli Accordi di Abramo, firmati da Israele, Stati Uniti, Emirati Arabi Uniti, Bahrein, poi Marocco e Sudan. Un trattato che parla di pace ma odora di scambio: riconoscimento diplomatico in cambio di vantaggi economici e militari. Il nome di Abramo, patriarca comune a ebrei, cristiani e musulmani, suona come una beffa. Perché, dietro la parola “pace”, si nasconde un nuovo ordine regionale fondato sul controllo e sulla paura. Israele ottiene legittimità, gli Stati Uniti estendono la loro influenza, e la Palestina — ancora una volta — viene tradita. Gli Accordi di Abramo non sono un ponte, ma un muro lucidato di retorica: la saldatura definitiva fra potere, denaro e religione. Un modo per contenere l’Iran, spartirsi il Medio Oriente e consegnare la causa palestinese al margine della storia.
Sunniti e sciiti: la frattura millenaria che oggi si chiama potere
Per capire davvero, occorre liberarsi dai luoghi comuni religiosi. La divisione tra sunniti e sciiti, nata nel 632 d.C dopo la morte di Maometto, non è più teologica ma politica. I sunniti — la maggioranza — guidano le monarchie del Golfo; gli sciiti — la minoranza — trovano nell’Iran la loro protezione. All’origine non c’erano dogmi, ma successioni dinastiche, tribù rivali, identità in lotta per la guida spirituale e temporale. Col tempo, le differenze si sono cristallizzate, e oggi la fede è diventata geopolitica: due Islam che si guardano in cagnesco per procura. I sunniti di Arabia Saudita ed Egitto da una parte, gli sciiti di Iran, Iraq, Libano e Siria dall’altra. Nel mezzo, popoli interi che non scelgono, ma subiscono. Persino i persiani, convertiti a forza all’Islam nel nostro alto medioevo, abbracciarono lo sciismo come gesto di opposizione. Oggi, lo schema è lo stesso: minoranza contro maggioranza, protetta da un impero che ha fatto della resistenza il suo marchio. Da qui l’attuale scacchiera: Israele e Iran si dividono i fronti, i palestinesi restano le vittime e Gaza è il campo di battaglia. Agnelli sacrificali di un equilibrio costruito sul sangue.
Israele e Iran: due ombre speculari
Israele, protetto dall’Occidente, armato dall’America, difeso dall’idea di sé. È il Paese più protetto al mondo, in proporzione al suo territorio. La sua esistenza è considerata “interesse vitale” per gli Stati Uniti e per buona parte dell’Occidente. Sotto l’ombrello strategico americano riceve 3,8 miliardi di dollari l’anno in aiuti militari. Condivide con Washington sistemi d’arma, caccia F35, tecnologie nucleari, difese missilistiche come l’“Iron Dome”. Un attacco a Tel Aviv equivale a una provocazione verso gli Stati Uniti e verso tutto l’Occidente. Per questo il governo Meloni si accoda, giustifica, tace. Per questo si condannano i rappresentanti italiani della Flottiglia, ma non si muove un dito davanti ai fermi e al blocco navale in acque internazionali. Israele si muove sotto un triplo ombrello: militare (USA), politico (Occidente), ideologico (Shoah e democrazia). L’Iran, invece, è protetto dall’Est, circondato da milizie, difeso dalla paura. Un impero circondato ma non isolato, sostenuto da Russia e Cina: la prima lo difende nei consessi internazionali e nei cieli siriani; la seconda ne compra il petrolio e ne costruisce le infrastrutture. È la loro pedina per indebolire l’egemonia americana. L’Iran non ha basi NATO né alleanze formali, ma possiede qualcosa di più pericoloso: la rete delle milizie sciite. Hezbollah in Libano, gli Houthi in Yemen, le brigate irachene, gli alauiti in Siria, Hamas e la Jihad Islamica a Gaza. Una difesa per saturazione: se colpisci Teheran, esplode mezzo Medio Oriente. La sua forza non è nei trattati ma nella deterrenza, nella minaccia, nel mito di essere “l’ultimo baluardo dei popoli oppressi”.
L’ultima frontiera: restare umani
Dentro questa ragnatela di potenze e alleanze, qualcosa però si muove. La Flottiglia della libertà e le manifestazioni e gli scioperi di questi giorni rappresentano una crepa nella logica del dominio. Sono una minaccia — sì — ma non alla sicurezza: alla menzogna. Perché solo la conoscenza, solo la consapevolezza, possono riscrivere la storia. C’è un momento, nella vita dei popoli, in cui la geopolitica cede il passo all’etica. E quel momento è adesso. Perché non si può restare neutrali di fronte a chi muore disarmato. Non si può parlare di pace, se non si riconosce l’ingiustizia. Non si può costruire futuro, se non si difende la verità. Per questo oggi, più che mai, non bisogna fermarsi. Non basta indignarsi: bisogna continuare a camminare, a gridare, a scrivere, a resistere. Siamo davanti a un crocevia della storia, e ognuno di noi deve scegliere da che parte stare. Da quella dei dominatori o da quella degli uomini. E forse, quando la tempesta passerà, quando il Mediterraneo tornerà a essere un confine d’acqua e non di sangue, capiremo che la vera rivoluzione è restare umani.
Francesco Vilotta