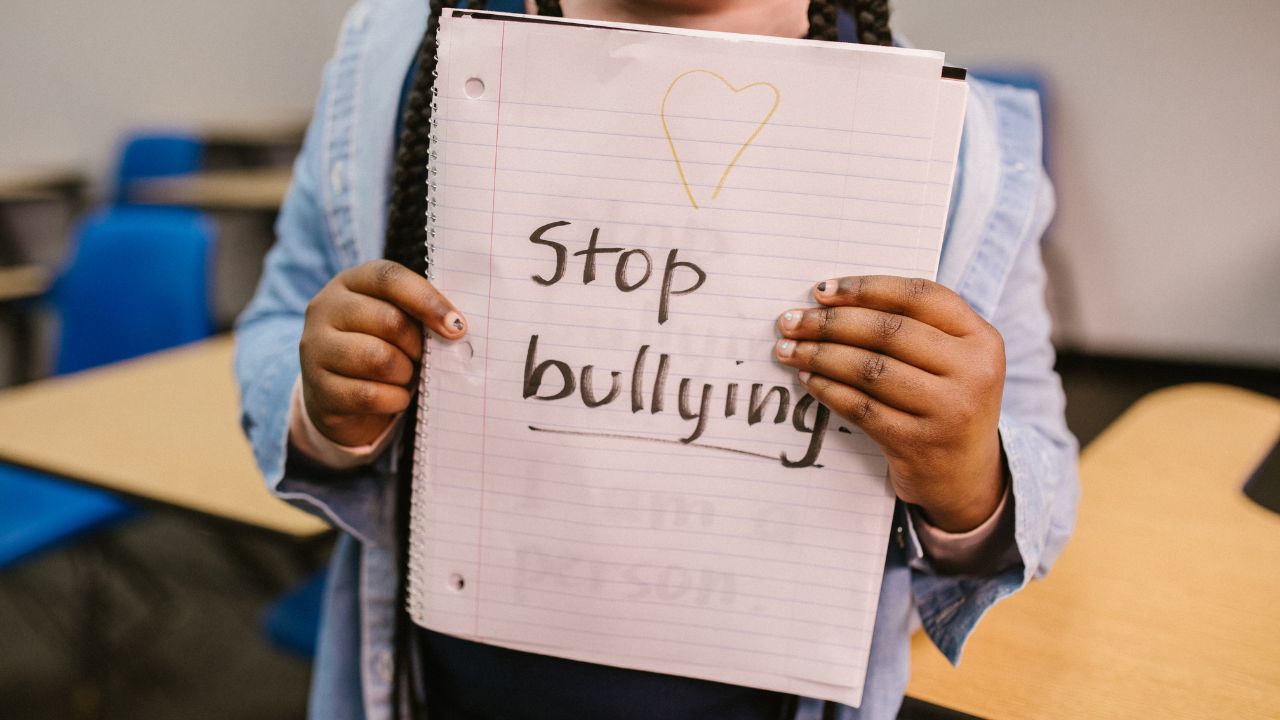Ogni epoca di smarrimento collettivo conosce il ritorno, implacabile e insinuante, di una promessa d’ordine: la voce suadente e, per certi versi tranquillizzante, del totalitarismo delle destre, che si ergono a custodi del buon senso e dell’identità, mentre sotto la patina del rigore morale e dell’efficienza amministrativa celano il bisogno profondo, e pericoloso, dell’obbedienza. È un meccanismo antico quanto la paura stessa. Laddove vacilla la fiducia nel domani, laddove la complessità del mondo eccede la capacità di comprensione dell’individuo, l’uomo si rifugia nella forma rigida, nel principio autoritario, nella certezza di una gerarchia che lo sollevi dall’angoscia della libertà.
La crisi del 1929 rappresentò l’archetipo di tale dinamica: un collasso economico che divenne collasso morale, una crisi di pane e di spirito da cui germinarono, come funghi velenosi, i totalitarismi del Novecento. Il fascismo in Italia e il nazionalsocialismo (Nazismo) in Germania si nutrirono di quella disperazione diffusa che chiedeva non più giustizia, ma ordine; non più pluralismo, ma unità; non più libertà, ma una parvenza di stabilità. Le masse, schiacciate dall’incertezza, scambiarono la disciplina per salvezza, l’obbedienza per patria, la violenza per rigore. Così la paura generò consenso, e il consenso, a sua volta, legittimò la barbarie.
Eppure, la storia — che pare sempre ammonire, e sempre invano — non cessa di ripetersi. Dopo il 2020, in un mondo smarrito tra pandemia, isolamento, crisi economica e sfiducia generalizzata nelle istituzioni, l’Occidente ha conosciuto una nuova e sottile tentazione autoritaria. L’insicurezza collettiva ha trovato, ancora una volta, la sua voce nei discorsi di chi promette ordine e disciplina, nei programmi politici che invocano il ritorno alle radici, la difesa delle “tradizioni”, la tutela di una supposta moralità collettiva. La paura del futuro ha generato nostalgia del passato: e la nostalgia, si sa, è la più pericolosa delle illusioni politiche.
Negli ultimi anni, dunque, le destre hanno trovato terreno fertile per espandersi globalmente. In un clima di insicurezza generalizzato, molti paesi si trovano ad essere governati dalle destre. È il caso dell’Ungheria, con il partito Fidesz guidato da Viktor Orbán: nazional-conservatore, euroscettico e con accentuati richiami al popolo, alla nazione e alla morale tradizionale. La Slovacchia, l’America di Trump, la Polonia, l’Italia.
Le destre contemporanee si proclamano paladine della volontà popolare, ma in realtà la interpretano come un mandato assoluto, una delega senza restituzione. Dicono di voler “governare in nome del popolo”, ma in realtà governano sul popolo, e non per esso. È un linguaggio mellifluo, rivestito di legalità e di religione civile, che promette sicurezza e protezione ma, passo dopo passo, erode la sostanza stessa della libertà. La gente, in fondo, non ama i disordini: preferisce la regola alla discussione, il silenzio alla discordia, la calma piatta dell’obbedienza al rischio vertiginoso del pensiero.
E così accade che la libertà si spenga non con un colpo di Stato, ma con un applauso.
Ogni legge, ogni conquista civile, ogni diritto che oggi consideriamo inviolabile è in realtà fragile, esposto al vento delle mutazioni storiche e delle paure collettive. Il fatto che una norma esista non significa che essa sia eterna; che un diritto sia sancito non implica che esso sia immune dalla revoca. La storia recente insegna che in un clima totalitario la legge non è più scudo, ma arma; non più garanzia, ma minaccia.
L’illusione di vivere in una democrazia compiuta ci ha resi ciechi di fronte alla reversibilità del progresso. Ciò che è stato conquistato può essere ritirato, e ciò che sembrava irreversibile può divenire negoziabile. Lo si è visto nei tentativi di limitare il diritto all’aborto, di ridiscutere il divorzio, di rimettere in questione i diritti delle minoranze o di piegare la giustizia alla morale religiosa. Dietro la retorica della protezione e della “difesa dei valori” si nasconde l’antico desiderio di controllo, la pulsione a normare la vita, il corpo, la parola.
Una donna, oggi, dovrebbe sentirsi offesa. Offesa non soltanto da chi vorrebbe negarle l’autodeterminazione, ma da chi tenta di convincerla che la libertà sia una concessione e non un diritto. Dovrebbe sentirsi oltraggiata da chi, in nome della tradizione, la ricondurrebbe al ruolo di simbolo e non di individuo; da chi, parlando di “natura”, intende solo giustificare la sottomissione.
Ogni volta che l’incertezza si fa clima, il potere tende la mano, e l’uomo, smarrito, la afferra. Ma quella mano, una volta stretta, non lascia più andare. È così che il totalitarismo si rigenera: non nei colpi di forza, ma nella rassegnazione quotidiana; non nei proclami, ma nelle abitudini; non nella violenza manifesta, ma nella progressiva anestesia della coscienza civile.
La libertà, come la democrazia, non è un dato, ma un atto: un esercizio fragile, faticoso, quotidiano. E se la storia ha un insegnamento da offrirci, è che ogni diritto, anche il più sacro, anche il più antico, esiste solo finché qualcuno ha il coraggio di difenderlo. Il silenzio dell’indifferenza è il suo peggior nemico, e la paura del disordine il suo più sottile sepolcro. Quando la libertà diventa scomoda, è allora che inizia a morire.
Ernesto Mastroianni