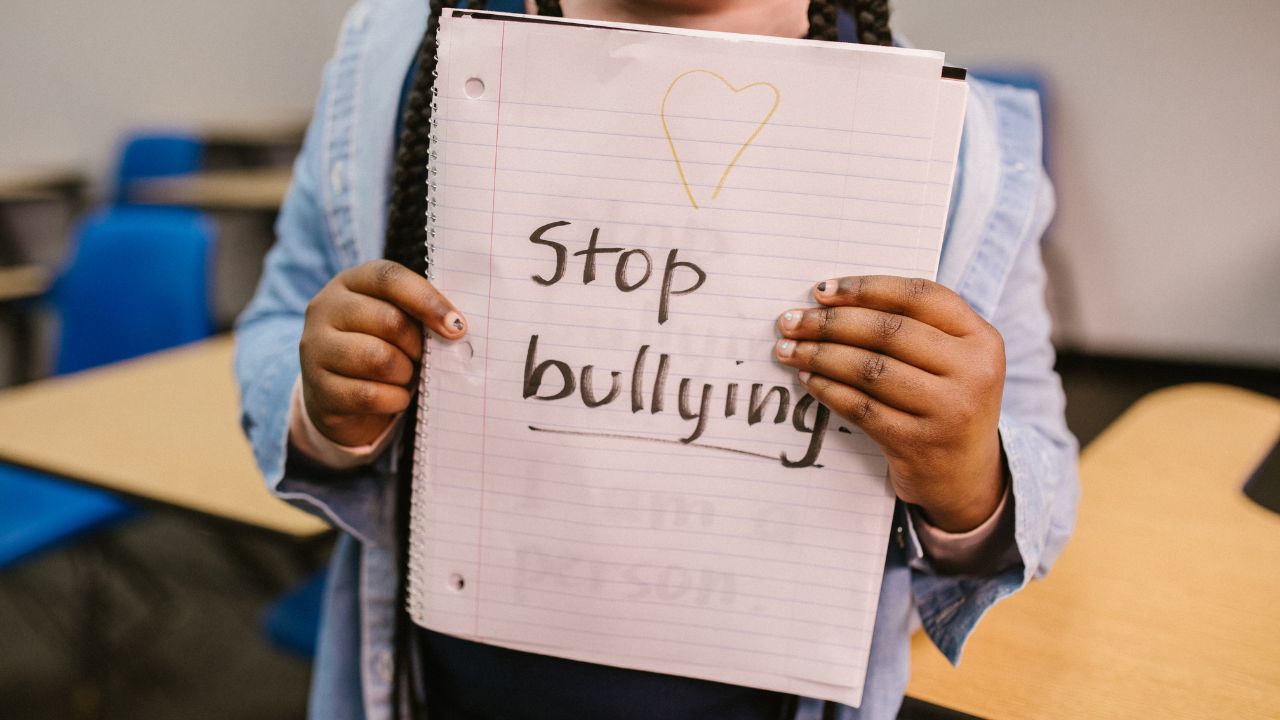«Sarà il ponte a campata unica più lungo al mondo. Una infrastruttura del genere è un acceleratore di sviluppo». Matteo Salvini lo ripete davanti a taccuini e telecamere, trasformando una giornata di carte bollate in un evento politico e simbolico. Per il vicepremier e ministro delle Infrastrutture il ponte sullo Stretto di Messina non è più solo una promessa da campagna elettorale o un fantasma da prima pagina: «Non è un punto di arrivo ma di partenza, dopo due anni e mezzo di lavoro costante. Non si era mai arrivati al finanziamento definitivo».
Il governo vuole consegnare al Paese non solo un’opera ingegneristica, ma una dichiarazione di fiducia nel futuro. I numeri messi in campo sono imponenti: 120 mila unità lavoro l’anno, 36.700 posti stabili, un contributo al Pil di 23,1 miliardi e 10,3 miliardi di entrate fiscali solo nella fase di cantiere. A regime, il valore attuale netto economico sarà positivo per 1,8 miliardi di euro, con minori tempi e costi di trasporto, maggiore efficienza logistica, incremento dei flussi turistici e riduzione delle emissioni.
Salvini non nasconde la soddisfazione: «Il ponte sarà parte della soluzione ai problemi del Mezzogiorno. Non solo per le merci e i treni veloci, ma per creare lavoro e dare speranza ai giovani di Sicilia e Calabria. Oggi un ingegnere neolaureato qui deve scegliere dove emigrare. Con questo investimento, offriamo un futuro a casa loro».
Il progetto, presentato come un gioiello di ingegneria, prevede una campata di 3.300 metri e circa 40 chilometri di raccordi stradali e ferroviari, in gran parte in galleria, per collegare l’opera alle principali autostrade e linee ad alta capacità di Calabria e Sicilia. Ma non sarà solo un ponte: è prevista anche una “metropolitana dello Stretto”, tre fermate sul fronte messinese per studenti, pendolari e turisti, destinata a diventare una spina dorsale di mobilità locale.
L’impatto dell’opera sarà nazionale. La prima regione per numero di imprese coinvolte sarà la Lombardia, seguita da Veneto, Emilia-Romagna e Lazio. Sul fronte della formazione e dell’occupazione, invece, il baricentro resterà al Sud. Salvini insiste su questo punto: «Investiamo in Sicilia e Calabria più del doppio del costo del ponte, con interventi sulle infrastrutture idriche e sulla mobilità locale. È un piano complessivo di rilancio del Mezzogiorno».
Il cronoprogramma è già scandito: dopo la bollinatura della Corte dei Conti, l’obiettivo è partire con i cantieri tra settembre e ottobre. «L’estate finisce il 21 settembre», scherza il ministro, mentre i tecnici lavorano sulle ultime verifiche. L’attraversamento è previsto tra il 2032 e il 2033. «Un biennio simbolico», lo definisce Salvini, «perché in quegli stessi anni i romani prenderanno la metro a piazza Venezia per arrivare all’Olimpico e da Torino si potrà raggiungere Lione. Sarà la stagione in cui l’Italia dimostrerà di saper fare le grandi opere».
Al di là della politica, il ponte ha un ruolo decisivo nella strategia europea dei trasporti. Senza un collegamento stabile, l’alta velocità in Sicilia resta monca. Oggi le ferrovie dell’isola sono lente e inaffidabili, ma sono già in corso lavori da nove miliardi di euro per collegare Palermo, Catania e Messina con linee fino a 200 km/h. Il ponte completerebbe il corridoio Helsinki-Palermo, inserito nella Rete Transeuropea dei Trasporti (Ten-T), destinata a unire la Scandinavia alla Sicilia entro il 2050.
Non solo merci e passeggeri: dopo la guerra in Ucraina, l’Unione Europea valuta i corridoi anche in chiave militare. Servono a spostare rapidamente non solo container e persone, ma anche mezzi blindati e truppe in caso di necessità. In questo quadro, la Sicilia diventerebbe un nodo strategico per Mediterraneo, Nato e Ue, rafforzando il ruolo di porti come Augusta e Gioia Tauro e proiettando l’Italia al centro delle grandi rotte commerciali e difensive.
La storia del ponte, intanto, racconta due secoli di sogni e rinvii. Dal primo progetto di Ferdinando II di Borbone nel 1840 ai tentativi post-unitari, fino alla frenata imposta dal terremoto del 1908. Poi sono arrivati i traghetti, le navi a vapore, e una lunga scia di dibattiti, studi di fattibilità, progetti accantonati e polemiche infinite. Per decenni lo Stretto è rimasto un simbolo di immobilismo italiano: l’opera più chiacchierata del mondo senza nemmeno una pietra posata.
Oggi, però, la tecnologia e l’ingegneria hanno cambiato le regole. Si costruiscono ponti in aree sismiche e ventose in Giappone, in California, in Cina. Sistemi antisismici, monitoraggi digitali e materiali di nuova generazione rendono possibile ciò che un tempo era solo un azzardo. Per il governo, il ponte non è più un’utopia: è la prova che il Paese può osare.
Salvini lo dice senza giri di parole: «Non si tratta solo di un’infrastruttura per il Sud. È un investimento nazionale, un’eredità per le prossime generazioni. Rafforzerà la competitività dell’Italia, unirà le sue regioni, moltiplicherà le opportunità economiche e proietterà il Paese al centro delle rotte europee e mediterranee».
Mentre in Italia si discute di rischi ambientali e di opposizioni locali, il resto del mondo guarda al progetto come a un’impresa ingegneristica straordinaria. Sui media internazionali si parla di campate record e di sfide tecnologiche. Per il governo, invece, il ponte sullo Stretto è già il simbolo di un’Italia che vuole rialzare la testa e tornare a correre.