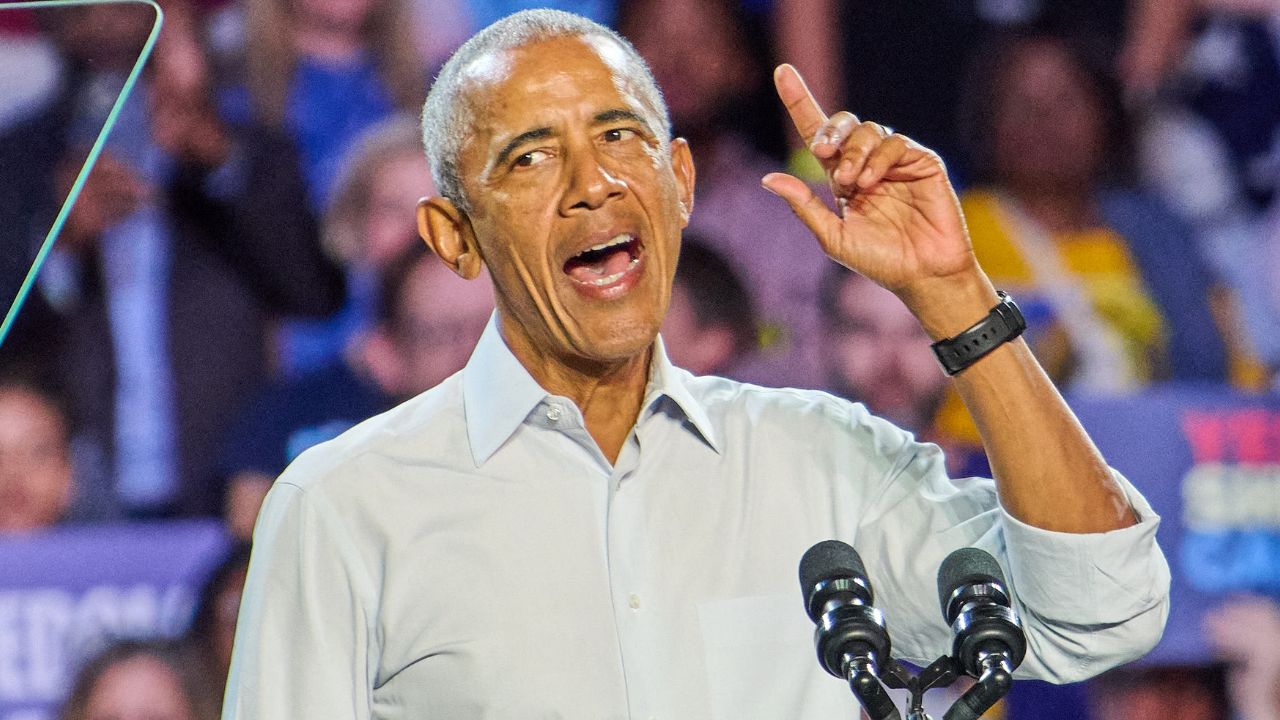C’è chi la dà per morta e chi la considera solo in coma, ma una certezza resta: la televisione italiana non parla più al suo pubblico.
I dati elaborati dallo Studio Frasi raccontano una fuga silenziosa ma costante, che nel 2025 ha raggiunto proporzioni difficili da ignorare. Nel confronto con il 2024, gli ascolti medi giornalieri sono calati del 7,7%, quelli della prima serata del 7%. In un solo anno, più di un milione di telespettatori ha spento la tv lineare, e non per accendere un’altra.
A peggiorare la situazione è il fatto che le piattaforme digitali non stanno raccogliendo il testimone. «Per ogni milione di spettatori persi dalla tv – spiega Francesco Siliato, analista dello Studio Frasi – le piattaforme guadagnano appena ventimila utenti non abbonati. Troppo pochi per parlare di un vero travaso». Non è dunque un cambio di canale, ma una disaffezione. La televisione non rappresenta più, come un tempo, il “sentiment” del Paese. E il problema riguarda tanto la Rai quanto le reti private.
Il pubblico, spiega Siliato, “non si riconosce” né nei linguaggi né nelle scelte editoriali. «È come vendere pannolini per l’incontinenza ai diciottenni», sintetizza. Da un lato programmi nuovi, progettati senza tener conto dei bisogni reali degli spettatori; dall’altro titoli “storici” che sopravvivono solo grazie alla forza dell’abitudine. Giovanni Floris, Fabio Fazio e pochi altri reggono ancora l’urto, ma con format che non si evolvono più, diventando rassicuranti rifugi piuttosto che esperimenti culturali.
A farne le spese è soprattutto l’informazione. I telegiornali registrano flessioni significative, con un progressivo spostamento del pubblico verso la rete, dove si moltiplicano i canali alternativi e le voci “contro” i media tradizionali. È la controinformazione a intercettare oggi la curiosità, spesso con metodi discutibili ma con linguaggi più immediati. «Gli utenti convinti dell’inattendibilità dei media mainstream – spiega ancora Siliato – si sono spostati online, seguendo divulgatori che non rispondono alle logiche giornalistiche ma a quelle dell’engagement».
La crisi della tv generalista, però, non è solo di contenuti. È anche di forma. Giovanni Benincasa, autore storico della Rai, lo dice con franchezza: «Oggi è difficile proporre programmi nuovi. Il mercato offre quasi solo la possibilità di adattare format stranieri, e spesso lo fa male. Servono editori che abbiano il coraggio di rischiare». Un tempo la televisione italiana produceva idee; oggi importa pacchetti. Eppure, aggiunge Benincasa, “non sempre serve un’idea nuova”: la forza dell’usato sicuro è ancora enorme.
L’esempio è quello de La Ruota della Fortuna, un format degli anni Ottanta tornato a dominare la stagione con ascolti altissimi. In questo paradosso si nasconde la chiave del presente: nulla è più inedito dell’edito. Gli italiani, disorientati da un’offerta bulimica, cercano certezze. E gli show di intrattenimento restano i punti cardinali del piccolo schermo. Gerry Scotti e Stefano De Martino – due generazioni e due linguaggi diversi – condividono un medesimo destino: portare a casa ogni sera quasi il 40% di share, pari a circa nove milioni di spettatori.
Lo stesso non si può dire dell’informazione. Le edizioni serali dei telegiornali principali hanno perso in media 600mila telespettatori rispetto all’anno precedente. Anche le trasmissioni di approfondimento politico registrano un calo costante. La spiegazione è duplice: saturazione e polarizzazione. L’elettorato – e dunque il pubblico – si frammenta, mentre la comunicazione politica si è spostata su social e piattaforme dove il linguaggio è diretto, non mediato e spesso brutale.
In questo scenario, l’unico contenuto che continua a unire è l’evento. Sport, Sanremo, concerti e reality di grande richiamo restano le ancore della tv generalista. «La televisione si regge ormai su tre gambe – dice Andrea Vianello, ex direttore di Rai 3 – sport, spettacolo e memoria. Ma se vogliamo immaginare un futuro, servono esperimenti, e non solo su RaiPlay. Ogni tanto, anche in prima serata, una scommessa può pagare».
La questione, in fondo, non è solo di numeri. È culturale. Chi lavora oggi nella televisione lineare sa che la concorrenza non è più un’altra rete, ma un universo digitale. I social e le piattaforme streaming sono al tempo stesso concorrenti e serbatoi di pubblico. Da lì arrivano le nuove forme di racconto, gli autori di domani, e soprattutto i giovani che la tv non riesce più a trattenere.
Il futuro potrebbe essere ibrido, multipiattaforma. Programmi come Belve lo dimostrano: nascono in tv ma sopravvivono online, moltiplicando la loro vita grazie ai social. È la direzione che molti a viale Mazzini considerano inevitabile: produrre contenuti “a utilità ripetuta”, non legati alla diretta, capaci di restare freschi anche a distanza di giorni.
La televisione non è morta, ma ha smarrito il suo specchio. E finché non tornerà a riflettere la realtà quotidiana del Paese – quella fatta di linguaggi, umori, conflitti e ironia – continuerà a perdere terreno. Il bicchiere, però, resta mezzo pieno: c’è ancora un pubblico che guarda, commenta, partecipa. Il problema è che, per trovarlo, serve cambiare canale.