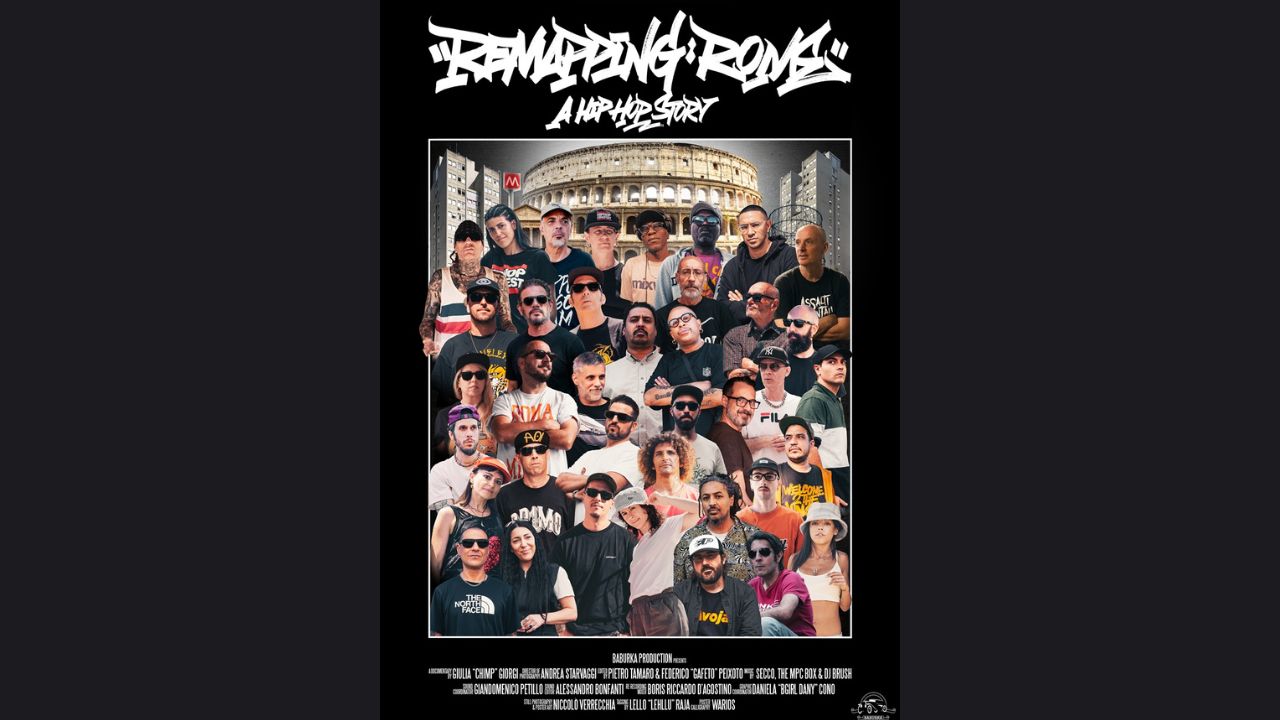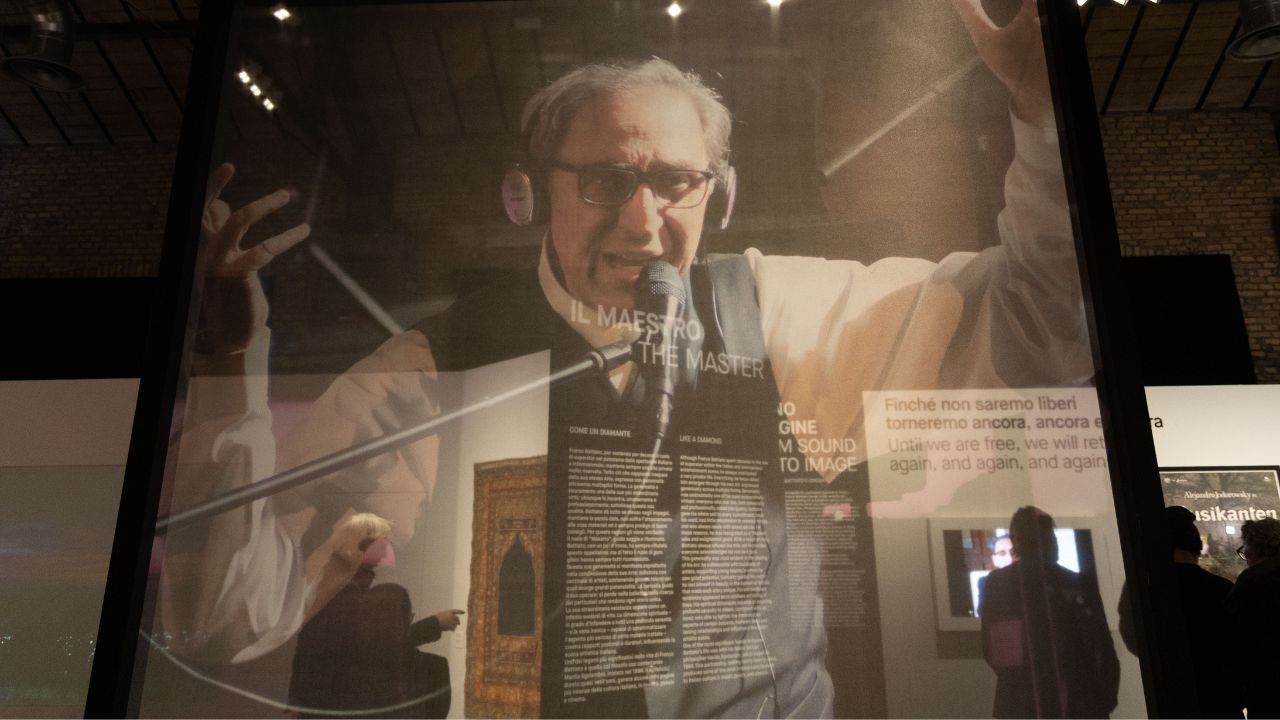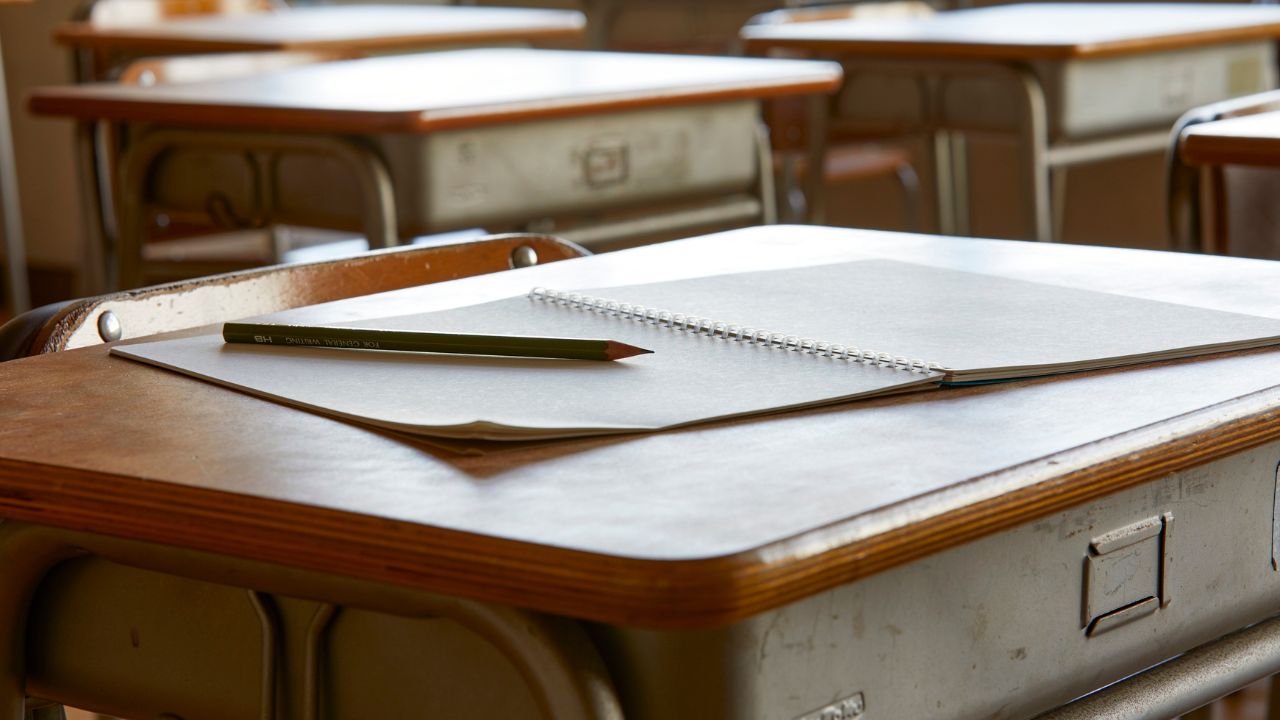di Antonio Tursi
In una carta geografica di fine Settecento, in quel lembo tra terra e mare nel sud della Cina, qual è il delta del Fiume delle Perle, è evidenziata Macao. Hong Kong vedrà accendersi le sue luci solo a metà Ottocento. Non poteva comparire perciò sugli atlanti precedenti. Eppure non è solo il caso ad aver determinato il nostro arrivo ad Hong Kong da Macao. Tra le due città c’è un legame, quasi la continuazione di una storia o, meglio, di una missione.
Macao ha rappresentato, dal 1557, il punto di contatto più antico tra la moderna Europa e la tradizionale Cina. La penisola di Macao e le isole di Taipa e Coloane furono concesse dall’imperatore Ming Jiajing ai portoghesi, per ricompensarli delle loro attività in difesa delle rotte marittime dai pirati che imperversavano nel Mare cinese meridionale, soprattutto tra quelle che erano conosciute come Islas de los Ladrones. I portoghesi sfruttarono questa occasione per impiantare un ulteriore punto di sosta e di approvvigionamento nelle loro imprese commerciali. Macao è così diventata porto di approdo per l’intera civiltà occidentale, finestra per l’evangelizzazione dei popoli dell’estremo Oriente, apertura da cui far fluire la scienza moderna verso quelle lande. Matteo Ricci partì da qui per giungere a Pechino. Ma come l’impero lusitano anche Macao ha iniziato presto a sonnecchiare. Dopo la prima guerra dell’oppio, l’impero britannico si stabilì ad Hong Kong. Ed il differenziale di presenza e di prestigio tra i due imperi si manifestò subito in un differenziale di sviluppo tra le due città. L’uomo bianco con il suo fardello incontrava ormai le “creature giallo-tigre” ad Hong Kong.
Macao, poco presidiata dai portoghesi, si rivelò nel tempo una città specializzata, “la sede principale dei pirati, dei giocatori d’azzardo, dei fumatori d’oppio, e, oltre a tutto, l’asilo di tutti i delinquenti d’Oriente, da Sourabaya a Harbin”, come la descrive Aleko Lilius, un esploratore e cronista le cui avventure tra i malviventi dai denti d’oro non si sono svolte nella prima età moderna ma nella prima metà dello scorso secolo. E questa tendenza alla specializzazione è tuttora assai marcata e molto sfruttata: Macao è, per Hong Kong e per la Cina tutta, la città dei casinò. Non più “i dodici sudici covi dall’odore acuto dell’oppio”, i casinò sono ormai impiantati in levigate strutture architettoniche che citano sin dal nome esotici contesti (il Londoner, il Parisian e il Venetian) o che guardano al futuro avveniristico (il Morpheus di Zaha Hadid o l’MGM Cotai dello studio americano Kohn Pedersen Fox). Casinò che producono notevoli introiti nelle casse della città e nelle tasche dei macaensi.
Il nostro cronista del Novecento, costretto a fuggire dai pirati cinesi che aveva frequentato durante la sua permanenza e che lo braccavano tra le vie e i ricoveri di Macao, sale su un battello a vapore e attraversa quel piccolo raggio di oceano che separa le due città coloniali per mettersi in salvo a Hong Kong e poi da lì rientrare negli Stati uniti. I sampan, le giunche, i vaporetti o più recentemente i veloci aliscafi hanno sempre consentito di arrivare all’isola di Hong Kong (solo una parte della omonima città-colonia) dal mare, entrando nel porto di Vittoria, rimanendo sempre ammirati dai palazzi via via cresciuti in altezza e dalle lussureggianti verdi colline sullo sfondo. Ormai il mare non è più l’unica via d’accesso al Porto Profumato (significato dei due caratteri che costituiscono il nome della città, in omaggio al legno aromatico dell’Aquilaria sinensis). Si arriva da Macao anche direttamente in auto o in pullman: un ponte di 55 km unisce, dal 2018, i punti nevralgici di queste due città coloniali ora divenute regioni ad amministrazione speciale della Repubblica popolare cinese. Isole artificiali, lunghe campate (la maggiore è di circa 30 km), tunnel sottomarini, costruiscono l’insieme dell’infrastruttura denominata HZM Bridge (dove la Z sta per Zhuhai, la città della Cina mainland posta anch’essa sull’estuario del Fiume delle Perle). Un esempio di sfida tecnica ed economica che la Cina, ormai tornata in possesso sia di Hong Kong che di Macao, ha affrontato senza tentennamenti: anche a livello simbolico, il percorso curvilineo e ondulatorio del ponte ricorda il dragone così caro alla sua millenaria tradizione. Una zona, da tempo dinamica e importante dal punto di vista economico, è stata ulteriormente integrata e rafforzata da una tale mastodontica infrastruttura. Un link che offre plasticamente un’immagine del presente politico dove il percorso storico da Macao a Hong Kong è riabbracciato e rilanciato dalla futuristica Cina. Rilanciato sino a configurare una di quelle ventinove “megaregioni urbane”, “città infinite”, “megalopoli policentriche”, come sono state chiamate quelle aggregazioni di importanti aree metropolitane che racchiudono milioni di abitanti e ingenti forze economiche, costituendo le vere e proprie locomotive dell’economia globale. L’HZM Bridge, infatti, incarna e materializza quella che è stata chiamata “Greater Bay Area” (Guangzhou-Hong Kong-Macao con 55 milioni di abitanti) o anche solo “Hong-Shen” (crasi di Hong Kong e Shenzhen, che da sole raggruppano 20 milioni di abitanti e mille miliardi di dollari di Pil). Numeri impressionanti che, da soli, dicono dell’importanza di queste metropoli asiatiche.