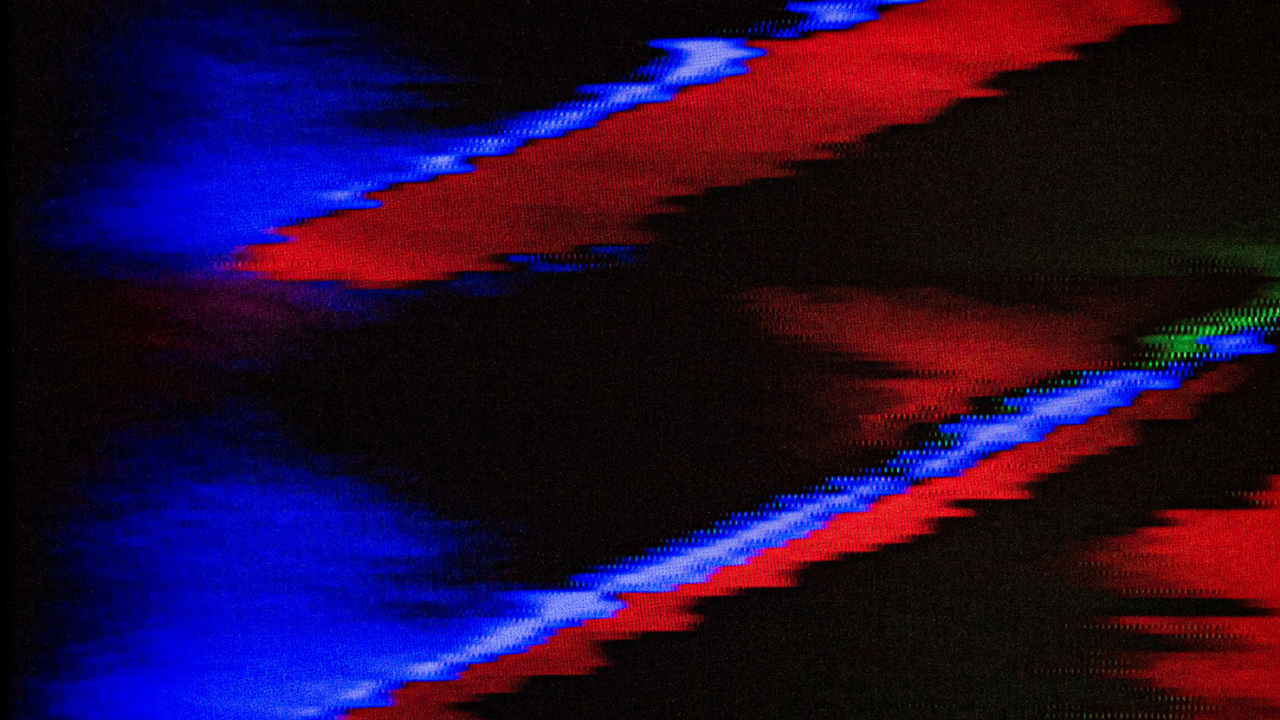Ai margini del campo, seppur sterminato, della cultura italiana si ergono muri. Alti e invisibili, gommosi e impenetrabili. È lì, ai margini, che le professioniste del settore sono catapultate, ora dalla rigidità dell’industria, ora da una narrazione pigra e sensazionalistica.
La regista Maura Delpero ne è l’esempio più recente. Ha vinto il premio come miglior regia ai David di Donatello, uno dei riconoscimenti cinematografici più prestigiosi in Italia. Il film ha inoltre incassato altre sei statuette, fra cui miglior film, miglior sceneggiatura e miglior produzione, sempre attribuibili a Delpero.
Delpero, prima donna e donna imprevista
Media, social e figure di rilievo nel settore hanno salutato la notizia con il consueto strillo destinato alle donne che agiscono in modo imprevisto: «Maura Delpero, prima donna». La carriera, il film, la persona – i contorni della regista – restano intrappolati in un aggettivo numerale che presuppone uno zero precedente e una seconda successiva. Un’assenza prima e una rincorsa dopo che desertificano la persona, lasciandone solo il sesso e il genere.
Una notizia storica, sì, se pensiamo alla cronologia degli eventi e alla possibilità di tracciare un solco per le seconde, le terze, le quarte che verranno quando non ci sarà più bisogno di contare. Ma la persona è ridotta a un primato. La vittoria diventa una celebrazione parziale, che non libera ma isola. L’eccezione non è la conquista: non solo non indica un reale cambiamento, ma quasi lo rallenta. È la conferma di un sistema che non cambia e che si congratula con sé stesso.
Delpero, la trappola di essere prime
Nominare la «prima donna», pur con legittimo entusiasmo, rischia di solidificare l’idea che la norma resti appannaggio maschile. L’impressione è infatti che delle donne si continui a celebrare, insieme alla riduzione della persona alla sua vulva, la singolarità: un’eterna outsider confinata al margine, raccontata in «una modalità sui generis delle celebrità femminile» che la professoressa Daniela Brogi aveva già indicato nel libro Lo spazio delle donne del 2022.
Essere raccontate come prima è una trappola, sia semantica che simbolica. Subito degenera in una narrazione stigmatizzante che nel celebrare l’eccezionalismo conferma la regola, abbattendo le possibilità di normalizzare le donne vincenti, a prescindere dal momento dell’arrivo al traguardo e dal genere.
Conoscere le parole, analisi delle «primedonne»
Fra l’impervietà della questione e la volontà di evitare polarizzazioni, occorrerà riprendere il vocabolario. Conoscere le parole – infrastruttura intima della società – per possederle e cambiarle da dentro.
Per Treccani, la «prima donna» è, nel linguaggio teatrale, l’attrice cui viene affidata la parte più rilevante. Una definizione, che è diventata modo di dire, cristallizzata nella forma unita «primadonna». Se da un lato indica record e conquista, «primadonna» è anche colei o colui, già solitamente noti, che cercano con ogni mezzo di essere al centro dell’attenzione, nella boria instancabile di primeggiare. Evoca quindi capriccio e alterità.
Più che segnalare un cambiamento strutturale, questa formula cristallizza l’anomalia. Il paradosso è che l’enfasi data alla vittoria femminile, e in questo caso di Delpero, pur motivata da entusiasmo o desiderio di giustizia e rivalsa, finisce per generare l’effetto simbolico di isolamento e non di inclusione. Figure femminili di rottura diventano simboli, oscurando l’effettivo lavoro. Nel 1998, il sociologo più illuminato dei tempi recenti, Pierre Bourdieu, scriveva: «Il fatto stesso che si possa evocare l’esistenza di donne che sono riuscite […] serve a mascherare la forza delle strutture che producono la rarità di questi casi».
E ancora: «La forza dell’ordine maschile si misura al fatto che non ha bisogno di giustificarsi: l’ordine simbolico si impone come naturale, senza discorsi, senza spiegazioni». Mostrare una donna che ce l’ha fatta permette al sistema di dire «vedete, funziona», in un’assoluzione collettiva che non mette sotto la lente d’ingrandimento le strutture che rendono quell’eccezione così rara.
L’ansia della misura
Contare non equivale a trasformare. Anzi, il conteggio, la misura e la divisione sono pratiche piuttosto ascrivibili al maschile, inteso come sistema simbolico e sociale costituito da norme, valori e visioni che definiscono ciò che autorevole, neutro o universale, che va al di là del dato biologico o individuale.
Adagiati su una comunicazione pigra e standardizzata e sull’atrofizzazione del pensiero critico, confondiamo la notizia contingente con il cambiamento reale nella società che ci circonda. Che le prime donne non servano alle persone, né tantomeno alle altre donne, è confermato dalla memoria corta che ci assale quando dobbiamo rammentare altre donne vincenti e storie d’ispirazione, proprio perché affastellate nei vari primati.
Da Lina Wertmüller a Paola Cortellesi, passando per Alice Rohrwacher, pluripremiata a Cannes, spesso celebrata più all’estero che in Italia, fino a Esmeralda Calabria, montatrice – professione invisibile nella narrazione pubblica – vincitrice di tre David di Donatello per il miglior montaggio (fra cui Romanzo criminale, nel 2006), non mancano donne che hanno fatto cinema, scritto storie, vinto premi e costruito visioni. Manca invece la capacità di ricordarle, citarle, intrecciare le loro traiettorie come parte di una continuità. Preferiamo l’eccezione al racconto collettivo. E così ogni prima volta si ripete come se il passato non fosse mai esistito e il futuro sia un percorso impraticabile o comunque accidentato.
Un nuovo umanesimo femminista
Non si tratta di negare il valore di una vittoria, che implica l’espugnazione di uno spazio prima tenuto chiuso. Tuttavia, il nuovo obiettivo delle narrazioni contemporanee che devono fare i conti con un mondo in continuo divenire e il portato storico e contraddittorio della pratica femminista, potrà essere leggere con lucidità gli avvenimenti, virando lo sguardo dal traguardo al percorso, dal genere alla persona. Un nuovo umanesimo femminista che metta al centro l’esistenza e la competenza. Prima che qualcuno metta in dubbio l’appartenenza delle donne alla grande storia.