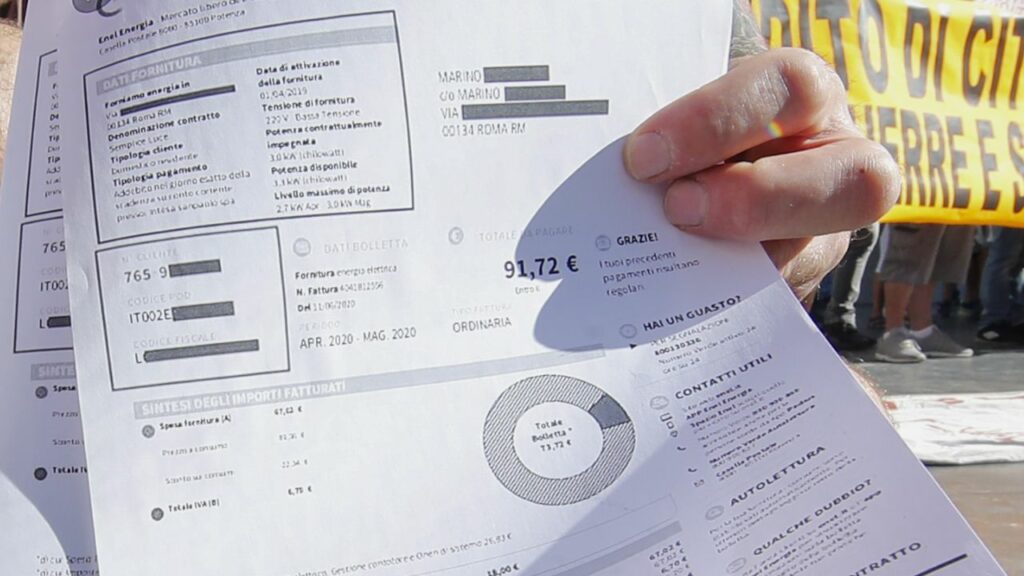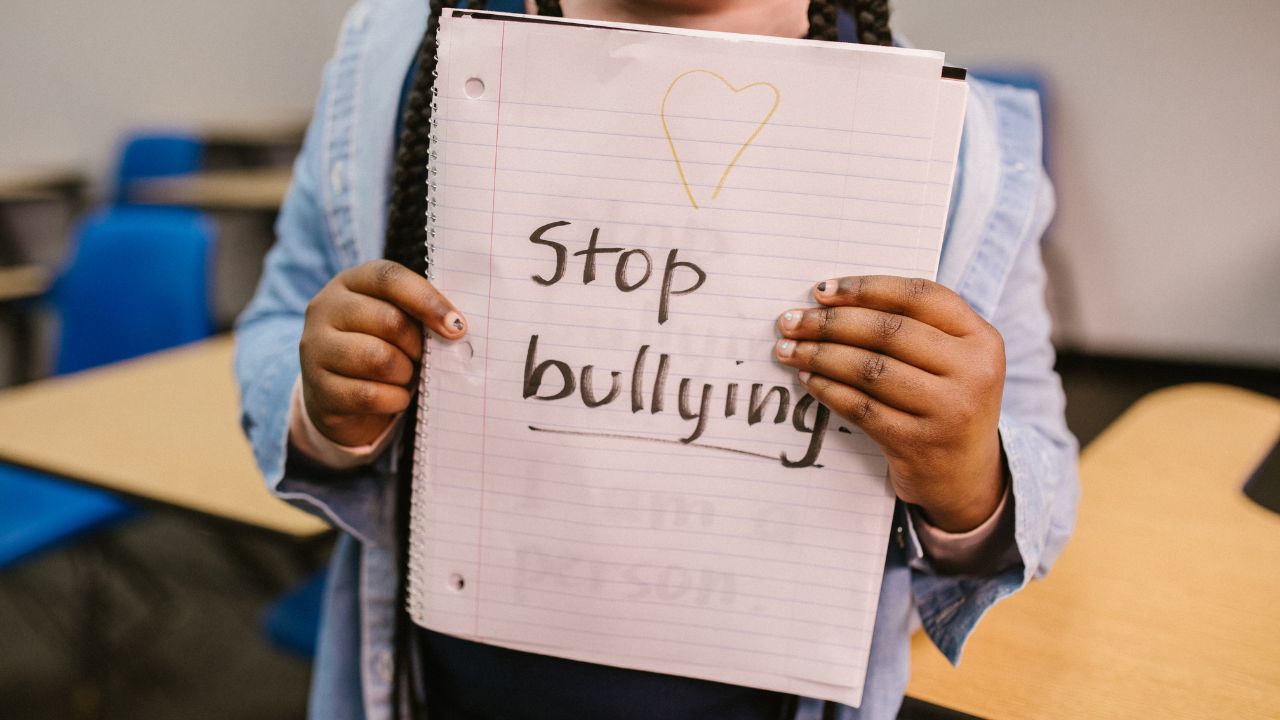Il ritornello è sempre lo stesso. Comincia con il canonico «la bolletta della luce continua a crescere» e si chiude con il classico «in Italia l’energia costa il triplo rispetto ai nostri concorrenti». È la musica che da anni accompagna il pressing delle imprese sul governo per ottenere sconti e incentivi, e che puntualmente si fa più insistente a ridosso della legge di Bilancio.
Eppure, guardando i numeri, la realtà racconta un’altra storia. Dall’inizio dell’anno il prezzo all’ingrosso di luce e gas è sceso sensibilmente: a fine ottobre è tornato ai livelli dell’estate 2021, cioè dopo la pandemia ma ben prima dell’invasione russa dell’Ucraina. Un ritorno alla normalità che però mette a nudo le fragilità strutturali del sistema Paese e rilancia il tema dell’indipendenza energetica, obiettivo dichiarato dalla presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, ma ancora lontano dall’essere realizzato.
Le cifre parlano chiaro: negli ultimi quindici anni le grandi imprese italiane hanno ricevuto sussidi energetici per circa 20 miliardi di euro, finanziati attraverso le bollette pagate dai cittadini. Risorse che avrebbero dovuto alleggerire il peso dei costi, ma che in molti casi hanno contribuito ad aumentare i margini di profitto delle aziende, senza incidere davvero sulla competitività del sistema. Nel tempo, i finanziamenti sono cresciuti fino a superare i due miliardi l’anno.
Una contraddizione evidente se si guarda all’andamento dei prezzi all’ingrosso. Dopo la crisi del 2022, l’indice europeo TTF ha registrato un crollo del 70%, e anche il prezzo dell’energia elettrica sui mercati all’ingrosso è tornato in media sotto i 100 euro a megawattora. Ma il vantaggio per i consumatori resta limitato, schiacciato tra oneri di sistema, accise e costi di rete.
Proprio la rete, però, è uno dei pochi punti di forza italiani. Secondo un’analisi di EY, l’infrastruttura energetica nazionale è tra le più efficienti d’Europa e ha costi inferiori rispetto ai grandi Paesi Ue. Gli italiani spendono in media 11 euro al mese per la rete, contro i 17 della media europea e i 23 euro dei tedeschi. Un risparmio che, calcolato su scala nazionale, vale circa 3 miliardi di euro l’anno.
E allora perché l’energia continua a essere un terreno di scontro? Perché la percezione del costo non coincide con la realtà. Eurostat ha certificato che per i consumatori domestici la componente energetica incide solo per il 57% del prezzo finale: il resto è fatto di tasse e spese accessorie. Un utente medio italiano paga 61,6 euro al mese, contro i 56,4 dell’Eurozona: il 9% in più, non il triplo, come spesso si sostiene.
In sostanza, l’Italia paga meno della Germania, ma più di Spagna e Francia, che possono contare su un mix energetico più bilanciato: rinnovabili abbondanti nel primo caso, nucleare nel secondo. Il nodo resta infatti la composizione del nostro sistema di produzione: la Penisola dipende ancora in larga misura dal gas, mentre la quota di energie rinnovabili è ferma sotto il 30%. Un paradosso, se si pensa che la Germania produce oggi più energia solare dell’Italia, pur avendo la metà delle ore di sole.
La conseguenza è una dipendenza strutturale dalle importazioni che rende il Paese vulnerabile alle oscillazioni dei mercati e ai rischi geopolitici. Eppure, sul tavolo degli investitori ci sono già progetti per 150 Gigawatt di energia verde. Il problema, come sempre, è il tempo. In Italia servono in media tre anni per autorizzare un impianto fotovoltaico e cinque per un parco eolico. In Spagna bastano la metà, in Francia ancora meno.
«Serve snellire le procedure autorizzative», ha ribadito Von der Leyen nel suo ultimo intervento a Bruxelles, «e favorire i contratti di lungo termine per dare stabilità ai prezzi e certezze agli investimenti». Parole che suonano come un richiamo diretto ai governi nazionali, Italia compresa.
Intanto, le associazioni industriali preparano un patto con il governo, un accordo “a costo zero per lo Stato” per sostenere la competitività del sistema produttivo. Ma tra le righe si legge la solita richiesta di agevolazioni, sconti e crediti d’imposta. Il rischio, come sottolineano alcuni analisti, è che le politiche di sostegno diventino una rendita permanente e non uno strumento di transizione.
A questo si aggiunge il paradosso tutto italiano della burocrazia energetica: moduli, autorizzazioni e ricorsi che bloccano cantieri per mesi. Le imprese chiedono chiarezza, ma spesso sono proprio le grandi aziende a frenare l’apertura alla concorrenza, difendendo posizioni consolidate.
La verità è che, nonostante gli allarmi e le dichiarazioni, il costo dell’energia non è più il vero problema: lo è la lentezza con cui il Paese cambia passo. Mentre la bolletta all’ingrosso torna a respirare, quella politica continua a pesare.
Come ha scritto un analista di Nomisma Energia, «il prezzo dell’energia cala, ma il prezzo del sistema resta alto». Un sistema che non è solo fatto di kilowattora, ma di scelte mancate, promesse non mantenute e riforme rinviate. E in un Paese dove anche la luce diventa terreno di propaganda, forse il blackout non è quello dei contatori, ma della visione.