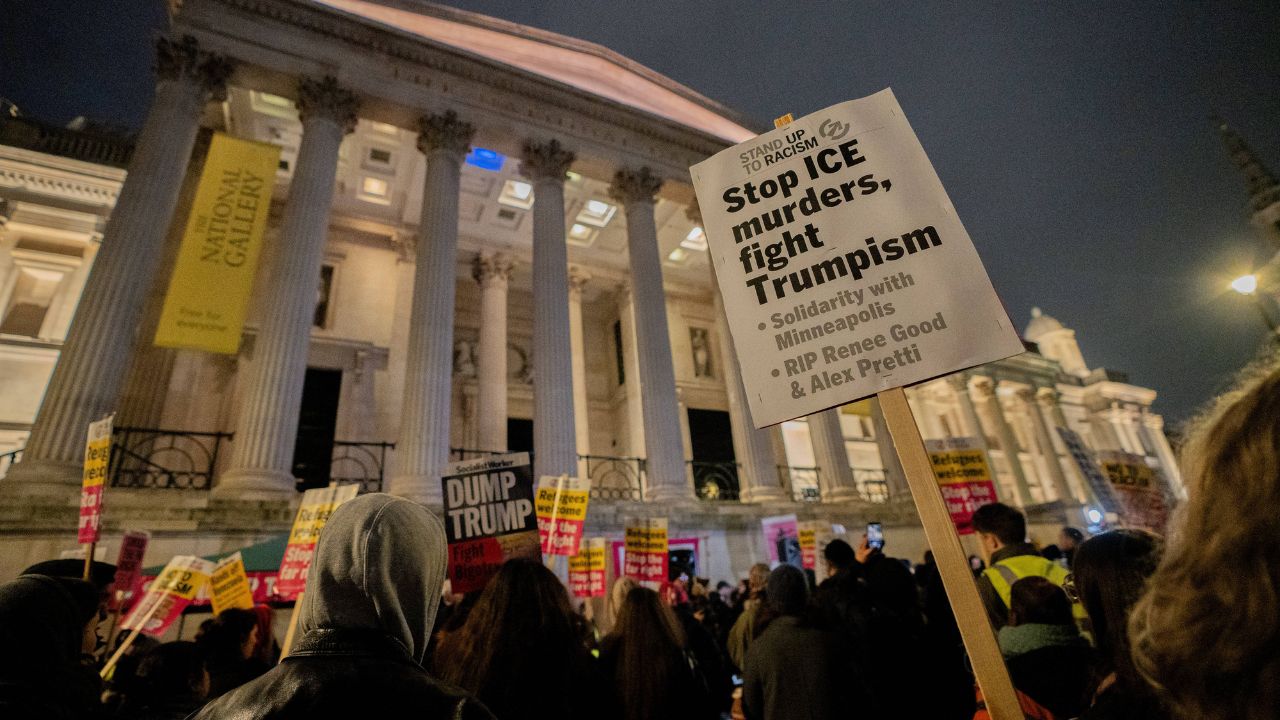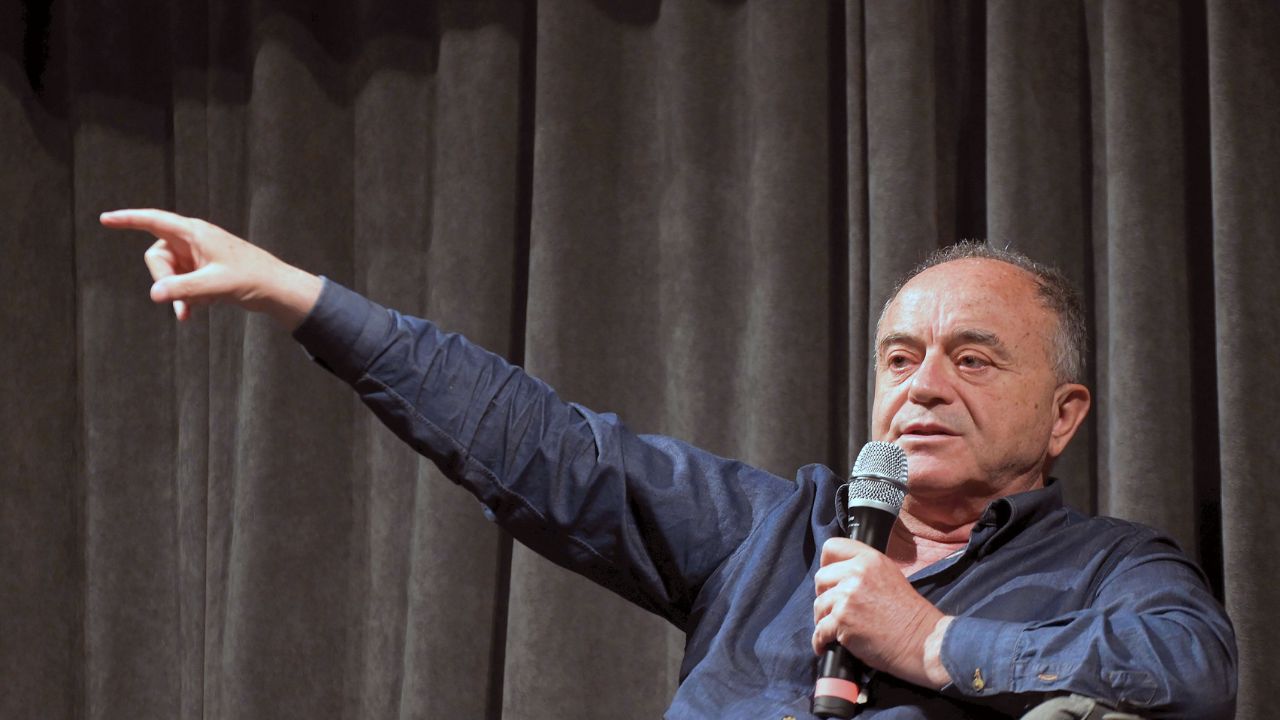A Bruxelles qualcuno ha provato a dirlo sottovoce: «Non è stata Ursula a piegarsi. Siamo stati noi». Perché la verità, dietro l’accordo che ha consegnato all’Europa una “doccia scozzese” di dazi al 15% sulle esportazioni verso gli Stati Uniti, non è la resa di una sola donna, ma la fotografia impietosa di un continente che non riesce mai a presentarsi come un blocco unito.
Ursula von der Leyen è diventata il bersaglio facile. Capro espiatorio ideale per i populismi interni e per chi, a Strasburgo come a Roma, non vede l’ora di scaricare la colpa della stangata su qualcun altro. Eppure, chi conosce i retroscena di questi giorni racconta di una presidente che ha fatto il giro di telefonate a tutti i big dell’Unione – da Macron a Meloni, da Merz a Tusk – prima di sedersi davanti a Donald Trump in Scozia. Non voleva ritrovarsi un continente alle spalle pronto a spararle addosso il minuto dopo la firma.
Il problema è che Trump non gioca a scacchi, ma a poker. E bluffa solo quando sa di avere il tavolo in pugno. L’America, oggi, sa di avere in mano tutte le carte: la supremazia militare, l’ombrello Nato, la leva energetica. Ursula, con ventisette Paesi sulle spalle, era come un giocatore con il mazzo dimezzato, costretta a contrattare sapendo che ogni mossa aggressiva avrebbe potuto scatenare una valanga di ritorsioni.
Macron, l’unico a voler mostrare i muscoli, ha tentato fino all’ultimo di imporre la linea cinese: minacciare ritorsioni immediate, usare il “bazooka” anti-coercizione, persino ventilare la dismissione dei T-bond americani in portafoglio europeo. Ma il presidente francese si è scontrato con la freddezza di Berlino e con la prudenza tattica di Roma.
Friedrich Merz, cancelliere tedesco, ha messo in chiaro che una guerra commerciale con gli Stati Uniti sarebbe stata «un disastro annunciato» per l’export europeo, già traballante. E Giorgia Meloni, che davanti alle telecamere parla di “accordo di massima ancora da definire”, in privato ha espresso la preoccupazione più concreta: Trump, se provocato, non si sarebbe limitato a colpire i nostri prodotti, ma avrebbe potuto ridurre il sostegno a Kiev, mettere in discussione l’impegno nella Nato e ritirare le pedine dallo scacchiere mediorientale.
In altre parole, l’Europa si è trovata a scegliere tra il male e il peggio. Accettare dazi al 15% – che pure faranno male – o aprire una frattura insanabile con l’unico alleato militare credibile che il continente possiede. Non è un caso che la scelta sia ricaduta sulla resa parziale, spacciata per compromesso.
Ma le conseguenze politiche rischiano di essere pesanti. L’Italia, in particolare, rischia di pagare un prezzo salato. I settori più esposti – agroalimentare, moda, meccanica – subiranno la stangata quando gli ordini inizieranno a calare tra fine inverno e primavera. Proprio mentre il Pnrr finirà di garantire ossigeno a un’economia con salari tra i più bassi d’Europa e consumi interni in affanno. L’autunno 2025 potrebbe essere rovente, ma il 2026 rischia di diventare l’anno dei sudori freddi.
E mentre la politica nazionale si prepara alle Regionali, l’Europa mostra la sua fragilità cronica: un’alleanza di ventisette piccoli interessi nazionali, incapace di muoversi come una potenza. Finché l’unanimità resterà la regola, ogni negoziato con Trump – o con chiunque giochi duro sullo scenario globale – sarà una partita truccata, con Bruxelles destinata a subire.
In questa storia, Ursula von der Leyen resta il volto più visibile, ma non l’unica responsabile. L’Europa che la critica è la stessa che le ha legato le mani. E che ora, davanti allo specchio dei dazi, scopre di essere ancora una volta un gigante economico dai piedi d’argilla.