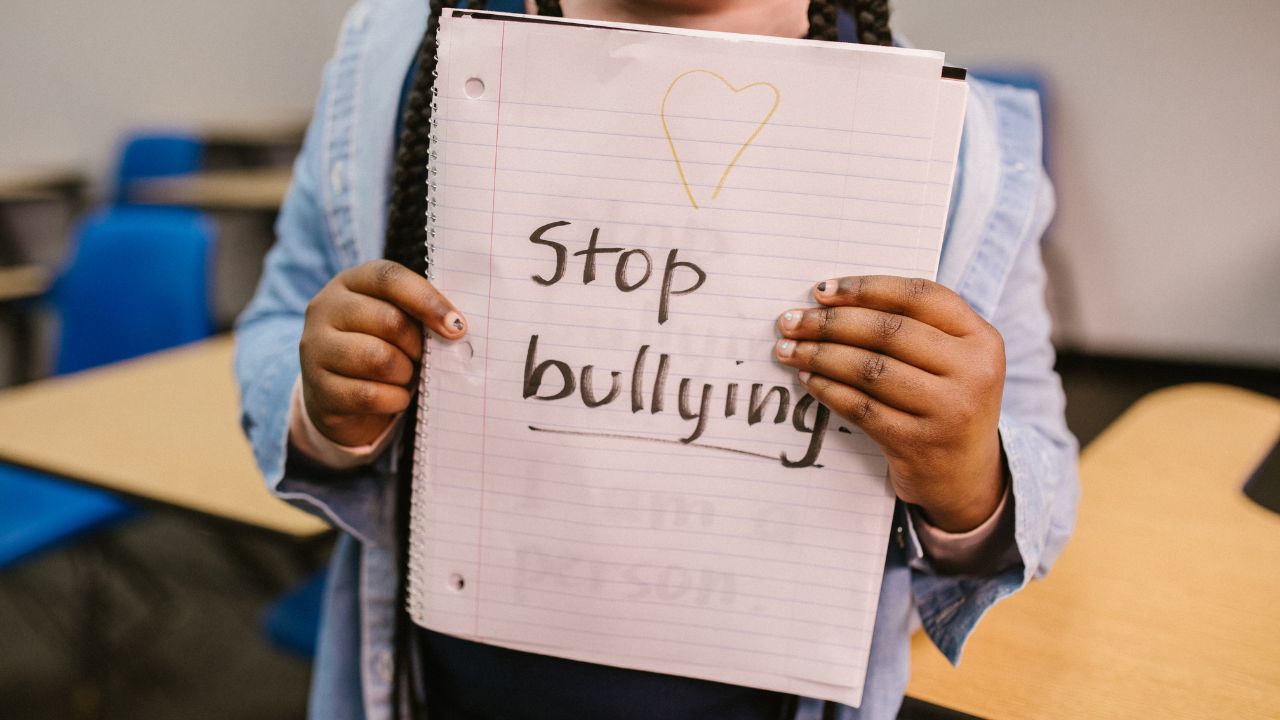Stando ai documenti interni visionati dall’agenzia, nel 2024 le inserzioni fraudolente pubblicate su Facebook, Instagram, Threads e WhatsApp avrebbero fruttato al colosso oltre 16 miliardi di dollari, pari a circa il 10% dell’intero fatturato annuo. Non una svista, ma un meccanismo sistemico che Meta conoscerebbe bene. E sul quale, scrive Reuters, avrebbe persino basato parte delle sue previsioni economiche per gli anni a venire.
Gli annunci incriminati coprono uno spettro vastissimo: investimenti inesistenti, trading truffaldino, prodotti vietati, “sextortion”, schemi piramidali, promesse di guadagni facili. In molti casi si tratta di pubblicità a pagamento, che passano regolarmente i controlli della piattaforma.
Gli algoritmi di Meta dovrebbero bloccare i contenuti sospetti, ma secondo i documenti aziendali lo fanno solo quando il rischio di truffa supera il 95%. Il risultato è che milioni di annunci ingannevoli vengono pubblicati ogni giorno. E non basta: chi visualizza una truffa, spiega l’inchiesta, ha molte più probabilità di vederne altre, perché il sistema pubblicitario personalizza le inserzioni sulla base degli “interessi” dell’utente. In pratica, più si cade in una trappola, più se ne incontrano.
Le truffe sfruttano spesso immagini di personaggi famosi, da Fabio Fazio a Sigfrido Ranucci, per attrarre fiducia e clic. Ma dietro non ci sono né investimenti né brand reali: solo pagine fantasma, link a piattaforme non regolamentate e raccolte di dati personali.
Un documento interno citato da Reuters descrive la situazione in termini inequivocabili: “Gli inserzionisti fraudolenti rappresentano una componente stabile e significativa del nostro ecosistema di ricavi.” A tanto arriva il paradosso di un colosso che guadagna anche dalle proprie falle.
Meta avrebbe persino previsto nel bilancio pluriennale una progressiva “riduzione controllata” del peso di queste entrate: dal 10,1% del 2024 al 7,3% nel 2025, fino a un più rassicurante 5,8% nel 2027. Non un azzeramento, dunque, ma un ridimensionamento pianificato. Come se il guadagno sulle frodi fosse ormai una voce contabile strutturale.
Il problema, però, non riguarda solo le cifre. È la filosofia aziendale a sollevare dubbi. In un memo interno del febbraio 2025, i vertici di Meta raccomandano di “moderare le azioni contro gli inserzionisti sospetti”, avvertendo che un blocco eccessivo “potrebbe costare all’azienda più dello 0,15% del fatturato”. Tradotto: oltre 135 milioni di dollari in sei mesi.
«Dobbiamo essere cauti – si legge nel documento –. I cali di entrate accettabili includono anche i casi in cui inserzioni legittime vengano erroneamente rimosse. Seguiamo linee guida specifiche per proteggere i ricavi».
A smentire l’inchiesta è intervenuto Andy Stone, portavoce del gruppo: «I dati diffusi offrono una visione selettiva e distorta del nostro impegno contro le truffe». Stone ha sottolineato che negli ultimi 18 mesi le segnalazioni degli utenti di annunci fraudolenti sono diminuite del 58%, e che nel 2025 sono stati rimossi oltre 134 milioni di contenuti pubblicitari sospetti.
Ma Reuters ribatte: il problema è il tasso di risposta. I report interni indicano che il 96% delle segnalazioni viene ignorato o respinto, e che le truffe pubblicitarie vengono classificate come un problema di “bassa gravità”, semplicemente una “esperienza utente negativa”.
Un ex investigatore interno, Sandeep Abraham, oggi esperto di sicurezza informatica, è lapidario: «Se le banche non possono trarre profitto dalle frodi, non si capisce perché le Big Tech dovrebbero poterlo fare».
Le preoccupazioni si moltiplicano anche in Europa, dove autorità e associazioni dei consumatori chiedono chiarimenti. In Italia, le campagne truffaldine che sfruttano l’immagine di conduttori noti come Fabio Fazio o Sigfrido Ranucci hanno già portato a numerose denunce. Ma Meta continua a incassare regolarmente i proventi delle sponsorizzazioni che alimentano quei contenuti.
Secondo i dati di Reuters, un terzo delle truffe online concluse con successo negli Stati Uniti nel maggio 2025 sarebbe partito proprio da un annuncio su Meta, mentre le piattaforme concorrenti avrebbero tassi di frode sensibilmente più bassi.
Dentro l’azienda, i memo parlano chiaro: “Le attività sospette non devono compromettere l’ecosistema pubblicitario”, scrivono i dirigenti. Anche a costo di tollerare qualche inganno di troppo. E quando gli inserzionisti sospetti vengono segnalati, finiscono in una sorta di “asta di rischio”, che aumenta il costo delle inserzioni anziché bloccarle.
Il risultato è un circolo vizioso perfetto: più gli utenti denunciano le truffe, più le truffe diventano redditizie.
La prospettiva che emerge dall’inchiesta è inquietante: un colosso che non solo non riesce a difendere i propri utenti, ma che ha imparato a monetizzare la loro vulnerabilità. Un paradosso da 16 miliardi di dollari che, per Meta, sembra ormai parte integrante del modello di business.
E intanto, mentre scorriamo i feed di Facebook o Instagram, tra un post di amici e un video virale, è probabile che ogni giorno – senza accorgercene – sfuggiamo a una delle 15 miliardi di trappole digitali che tengono in piedi l’impero di Zuckerberg.