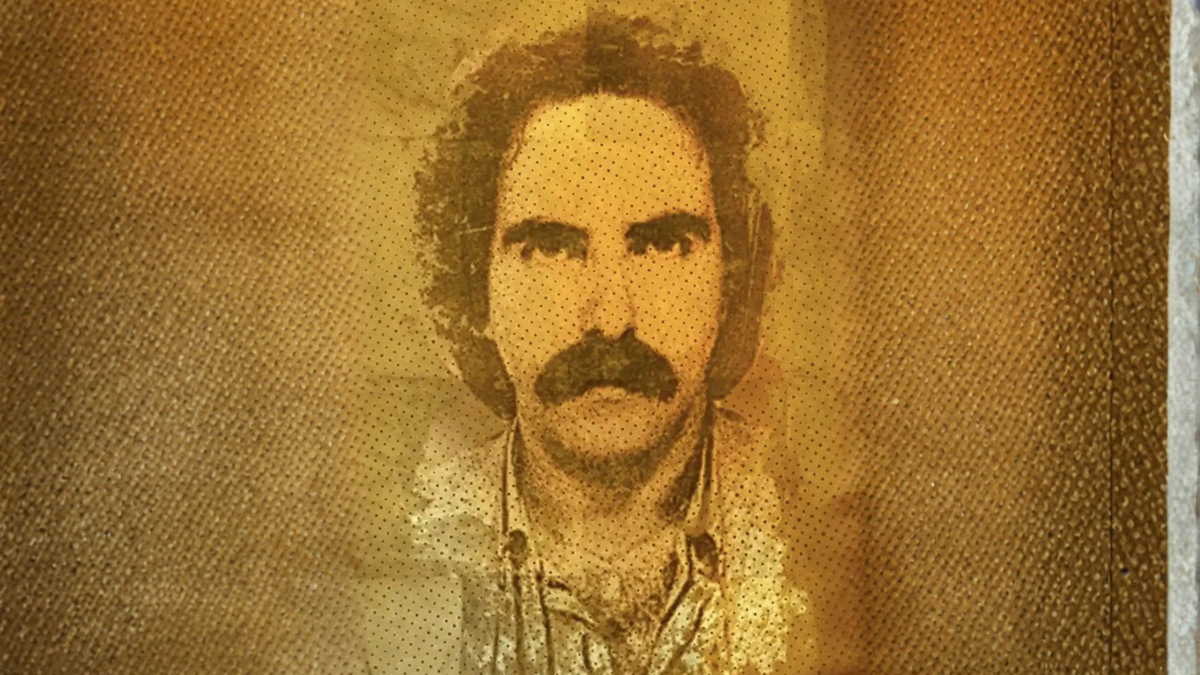La pressione fiscale italiana si ferma al 42,6%, ma Oltralpe tocca il 45,2%: Parigi diventa la capitale europea delle tasse. La Cgia di Mestre però avverte: “Burocrazia, salari fermi e infrastrutture carenti continuano a frenare la crescita”.
L’Italia resta un Paese ad alta pressione fiscale, ma non più il peggiore d’Europa. Secondo i dati elaborati dalla Cgia di Mestre, il prelievo complessivo – tra tasse e contributi – nel 2024 si attesta al 42,6% del Pil, un dato che ci colloca al quinto posto tra i Paesi dell’Unione. Un livello che continua a pesare su imprese e famiglie, ma che almeno non ci consegna più la maglia nera. A guidare la classifica ora è la Francia, con un’imposta effettiva pari al 45,2% del Pil: un record che, tradotto in cifre, significa 57 miliardi di euro in più di tasse e contributi rispetto ai contribuenti italiani. Seguono Belgio (45,1%), Austria (44,8%) e Lussemburgo (43%).
“Il nostro sistema resta inefficiente e opprimente, ma non più isolato – osservano dall’Ufficio studi della Cgia –. La Francia ha superato l’Italia per carico fiscale complessivo, ma la differenza vera si gioca sulla qualità della spesa pubblica”. Infatti, se da un lato Parigi mantiene standard più alti in welfare e servizi, dall’altro continua a scontare un debito pubblico crescente e una produttività stagnante. L’Italia, invece, pur zavorrata da una burocrazia tentacolare e da una fiscalità complessa, mostra segnali di maggiore dinamismo. Tra il 2019 e il 2024, il Pil reale italiano è cresciuto del 5,8%, un risultato superiore a quello di Francia (+4,3%) e Germania, rimasta ferma a zero. Solo la Spagna ha fatto meglio, con un +6,8%.
Sul fronte occupazionale, poi, l’Italia può vantare un tasso di disoccupazione sceso al 6%, due punti in meno rispetto alla media francese. “Nonostante tutto, il mercato del lavoro italiano ha mostrato una tenuta superiore alle aspettative”, rileva la Cgia. Anche l’export continua a sostenere la ripresa: 33 miliardi di euro in più rispetto ai cugini d’Oltralpe.
Eppure, il quadro resta fragile. “Ci sono criticità strutturali che non si risolvono con qualche decreto o incentivo temporaneo – avverte la Cgia –. L’Italia paga ancora un ritardo cronico in tre campi chiave: occupazione femminile, salari e infrastrutture”. Il tasso di occupazione delle donne è ancora tra i più bassi d’Europa: 53,7% contro una media Ue del 70%. Una forbice che, da sola, basterebbe a spiegare buona parte del divario di produttività con i Paesi del Nord. A questo si aggiungono stipendi fermi da anni, erosi dall’inflazione e dal peso del costo della vita.
«L’Italia non è un Paese povero, ma impoverito», sintetizza un analista. «Abbiamo un sistema produttivo vitale, esportazioni record e risparmio privato altissimo, ma tutto viene frenato da una macchina amministrativa che consuma risorse e scoraggia gli investimenti».
Il peso della burocrazia è infatti un’altra zavorra: tempi lunghi per i permessi, adempimenti infiniti, moduli e scadenze che costringono imprese e cittadini a una corsa a ostacoli quotidiana. Secondo la Cgia, ogni anno il sistema burocratico italiano costa all’economia oltre 57 miliardi di euro in inefficienze e ritardi.
C’è poi la questione energetica: il prezzo dell’elettricità e del gas per le imprese italiane resta tra i più alti d’Europa. Un handicap che si riflette sul costo dei prodotti, sulla competitività industriale e, inevitabilmente, sulla pressione fiscale, che serve anche a compensare queste carenze Sul piano politico, la fotografia di Mestre arriva in un momento delicato per il governo. Palazzo Chigi punta a mantenere il taglio del cuneo fiscale e a introdurre ulteriori agevolazioni per i redditi medio-bassi, ma la coperta resta corta. La revisione del Pnrr e le tensioni sui conti pubblici rendono difficile pensare a interventi strutturali.
«Servono riforme vere, non pannicelli caldi», si legge nella relazione finale della Cgia. «Non basta abbassare una tassa se poi si moltiplicano gli adempimenti o si rinviano i crediti alle imprese. Serve una semplificazione radicale, una riduzione del numero di imposte e un riordino della spesa pubblica». Il confronto con Parigi, però, regala un piccolo sospiro di sollievo: per una volta, almeno sul fronte fiscale, non siamo i peggiori. La Francia paga la scelta di una politica di welfare molto espansiva e di un debito in crescita che sfiora il 110% del Pil. L’Italia, invece, sopravvive con un equilibrio precario, ma più virtuoso del previsto. I numeri lo confermano: la pressione fiscale resta alta, ma la capacità di resistenza delle imprese e delle famiglie italiane rimane sorprendente.
Eppure, la sensazione diffusa è che si viva comunque “tartassati”. Perché non è solo la quantità di tasse a pesare, ma il modo in cui vengono gestite. Quando il cittadino ha la percezione di pagare tanto senza ricevere in cambio servizi adeguati, la frustrazione cresce. In fondo, come ricorda amaramente un vecchio detto da bar, “in Italia non sono le tasse a far paura, ma il fatto che non servano mai a migliorare la vita di chi le paga”.