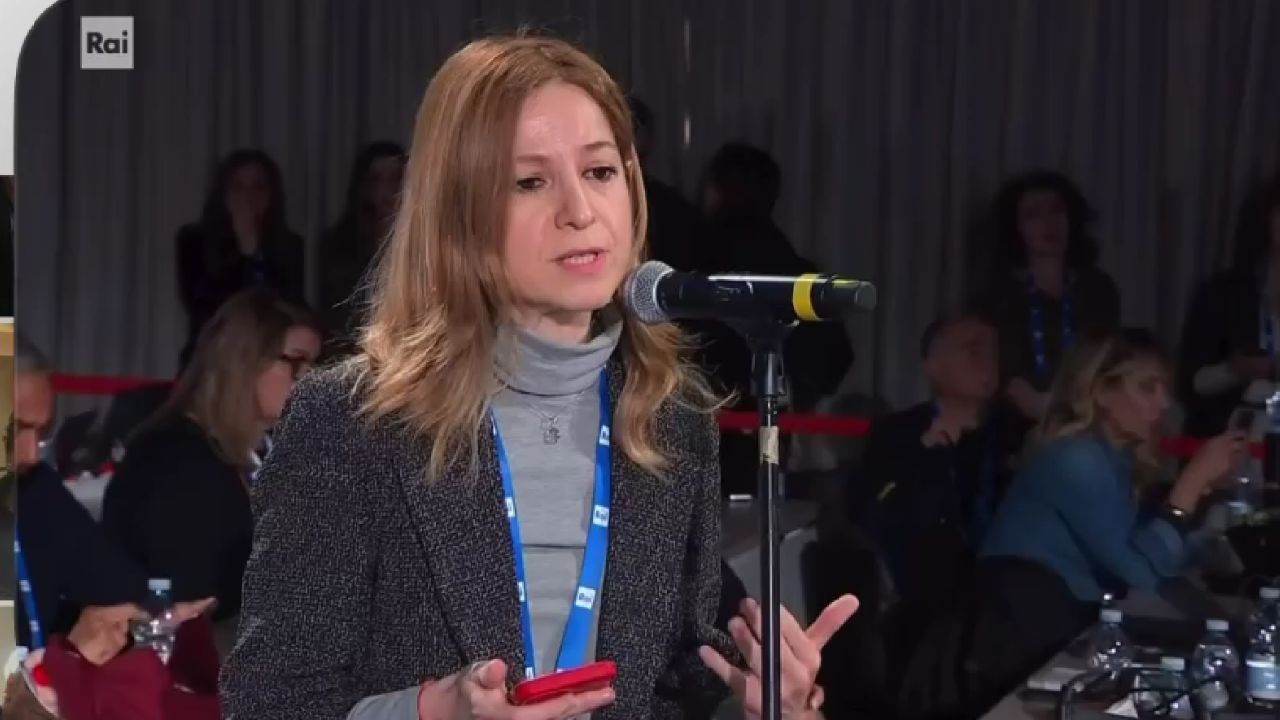Settantacinque anni dopo la dichiarazione Schuman, simbolo fondativo dell’integrazione europea, l’asse Parigi-Berlino si ricompone e riprende centralità nella guida politica del continente. Lo fa a Kyiv, nel cuore di un’Europa ferita dalla guerra, ma anche determinata a difendere la democrazia e i propri valori. In questa cornice, però, colpisce un’assenza: quella dell’Italia. E non si tratta di un’assenza casuale o tecnica, ma di una scelta politica che potrebbe segnare l’inizio di un isolamento sempre più marcato del nostro Paese nel consesso europeo.
Il vertice a Kyiv
Il 75° anniversario della dichiarazione Schuman è stato celebrato con un vertice straordinario a Kyiv tra i cosiddetti “paesi volenterosi” – Francia, Germania, Polonia, Paesi Bassi, Repubblica Ceca e paesi baltici – che hanno ribadito con forza il loro sostegno militare e politico all’Ucraina. Il messaggio è stato chiaro: l’Unione Europea intende rafforzare la propria coesione strategica e accelerare l’integrazione ucraina.
L’Italia, invece, era assente. Nessun rappresentante del governo Meloni ha partecipato all’incontro. E la scelta – perché tale appare – è stata notata da tutti gli osservatori internazionali.
L’assenza italiana non è un fulmine a ciel sereno. Negli ultimi mesi, Roma ha adottato una linea di ambiguità sull’Ucraina: continua formalmente a sostenere Kyiv, ma evita prese di posizione forti, si defila su temi chiave come l’invio di nuove armi offensive, e cerca equilibri più autonomi nel Mediterraneo e nei rapporti con gli Stati Uniti e la Cina.
Ci sono almeno tre motivi principali dietro questo isolamento:
Cautela elettorale interna: il governo Meloni teme che un sostegno troppo marcato all’Ucraina possa spostare consensi verso posizioni più neutraliste o sovraniste, soprattutto in vista delle elezioni europee.
Una strategia di politica estera ambigua: l’Italia ha moltiplicato i segnali di distacco da Bruxelles e dal tradizionale asse occidentale, cercando nuove sponde con paesi come l’Ungheria, o rafforzando legami bilaterali non sempre coerenti con la linea europea.
Mancanza di visione geopolitica: a differenza di Francia e Germania, Roma sembra oggi priva di una strategia europea chiara, oscillando tra il ruolo di partner affidabile e quello di mediatore terzo, in un’Europa che però chiede chiarezza e determinazione.
Le conseguenze sul futuro dell’Italia in Europa
Questo autoisolamento può avere conseguenze gravi, anche nel breve periodo:
-Perdita d’influenza: l’Italia rischia di non avere voce nei processi decisionali chiave, soprattutto su dossier strategici come la difesa comune, la ricostruzione dell’Ucraina e il futuro allargamento dell’UE.
-Marginalizzazione economica: con la nuova fase di investimento e ricostruzione europea, chi resta fuori dai tavoli decisionali rischia anche di perdere risorse e opportunità.
-Impatto sulla politica interna: un’Italia marginalizzata in Europa potrebbe vedere crescere le tensioni interne tra forze pro-europee e forze euroscettiche, alimentando instabilità politica.
L’Italia deve decidere che ruolo vuole avere nell’Europa del futuro. Rimanere ai margini, per calcolo politico o incertezza strategica, può sembrare una scelta tattica, ma rischia di diventare un boomerang storico. Mentre l’Europa si riorganizza attorno a una nuova leadership franco-tedesca rafforzata da paesi dell’Est, Roma deve rispondere a una domanda semplice ma cruciale: vuole contare o restare spettatrice?