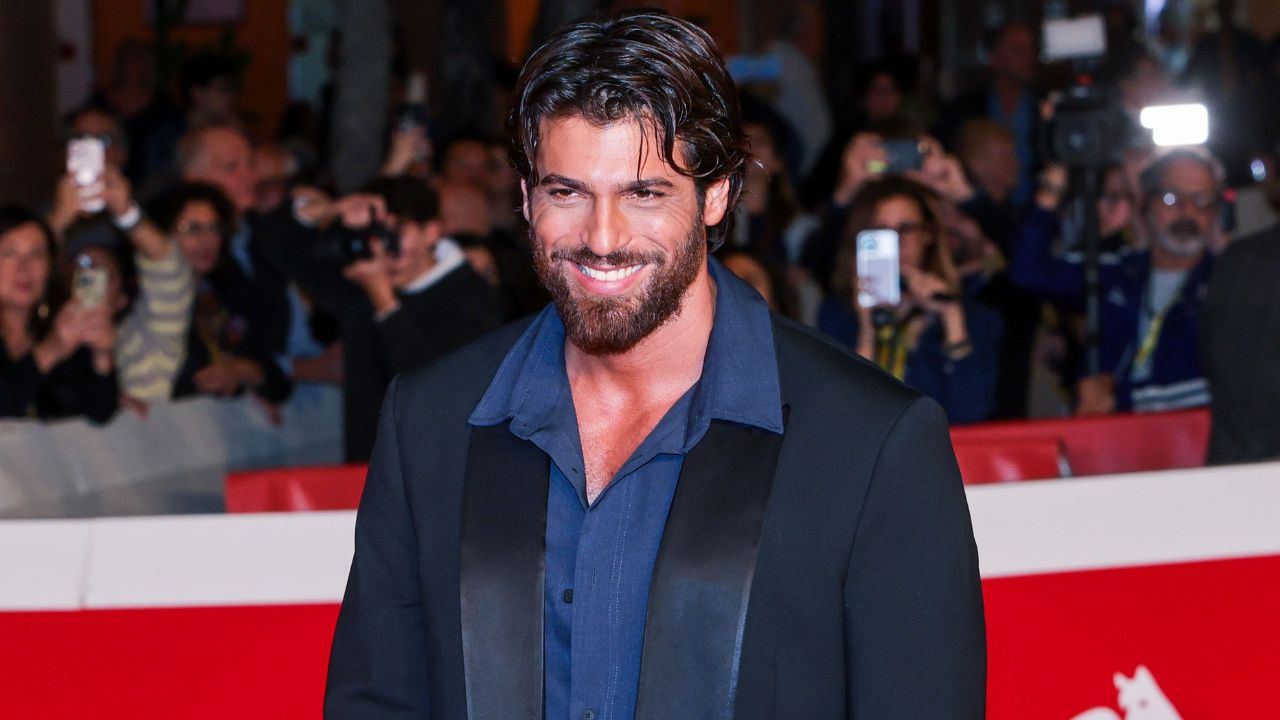La COP30 di Belém si è chiusa con un risultato che lascia l’amaro in bocca: piccoli passi avanti, ma una distanza ancora enorme tra ciò che la scienza chiede e ciò che la politica internazionale riesce a mettere in campo. Lo hanno detto chiaramente anche gli eurodeputati alla guida della delegazione del Parlamento europeo, intervenuti a caldo dopo la conclusione dei negoziati, anche tramite un report pubblicato dal Parlamento Europeo. L’impressione, ancora una volta, è che le politiche per il climate change necessitino di tempi più lunghi del previsto, in un quadro internazionale sempre più teso anche a causa di agenti esterni alla questione ambientale.
La situazione attuale
La presidente della delegazione, Lídia Pereira (PPE), ha sottolineato come l’Unione europea si sia trovata di fronte a un fronte compatto formato da Paesi BRICS e Stati arabi, insieme a una Presidenza della conferenza “non allineata al livello di ambizione necessario”. Il risultato è un documento finale che riconosce il problema del divario delle emissioni, dà il via a un evento di alto livello sull’attuazione e apre iniziative come la Belém 1.5°C Mission e il Global Implementation Accelerator. Passi utili, certo, ma lontani da un vero cambio di passo.
Sul tema dell’adattamento, Pereira ha rivendicato la protezione dei finanziamenti all’interno del nuovo quadro del NCQG e l’impegno per triplicare il sostegno ai Paesi più vulnerabili entro il 2035. Ma anche qui il nodo è lo stesso: la velocità. Le misure non viaggiano al ritmo dell’emergenza climatica.
Ancora più dura la posizione di Mohammed Chahim (S&D), vicepresidente della delegazione, che parla apertamente di “base minima per l’azione climatica globale”. Il deputato olandese ha ricordato che il presidente brasiliano Lula aveva alzato molto le aspettative, e l’UE era arrivata con l’obiettivo di guidare una coalizione ambiziosa. Ma la resistenza dei Paesi produttori di petrolio e i nuovi equilibri geopolitici hanno rallentato tutto.
Cosa resta e cosa manca
L’immagine che emerge è quella di un’Europa che prova a spingere, ma che si ritrova spesso isolata, costretta a “remare controcorrente”, insieme al Regno Unito, per conservare almeno un frammento di ambizione globale. Un isolamento che rischia di ripetersi se Bruxelles non riuscirà a costruire nuove alleanze internazionali.
La COP30, dunque, si chiude senza crolli, ma anche senza slanci. Il multilateralismo ha retto, ma la velocità dell’azione resta drammaticamente inferiore ai tempi imposti dalla crisi climatica. Il risultato è un compromesso che conferma una verità scomoda: la politica globale del clima viaggia molto più lentamente del clima stesso.
Per i prossimi negoziati, la sfida è esattamente questa: trasformare iniziative e dichiarazioni in misure operative con tempi più rapidi. Perché il pianeta, semplicemente, non aspetta.