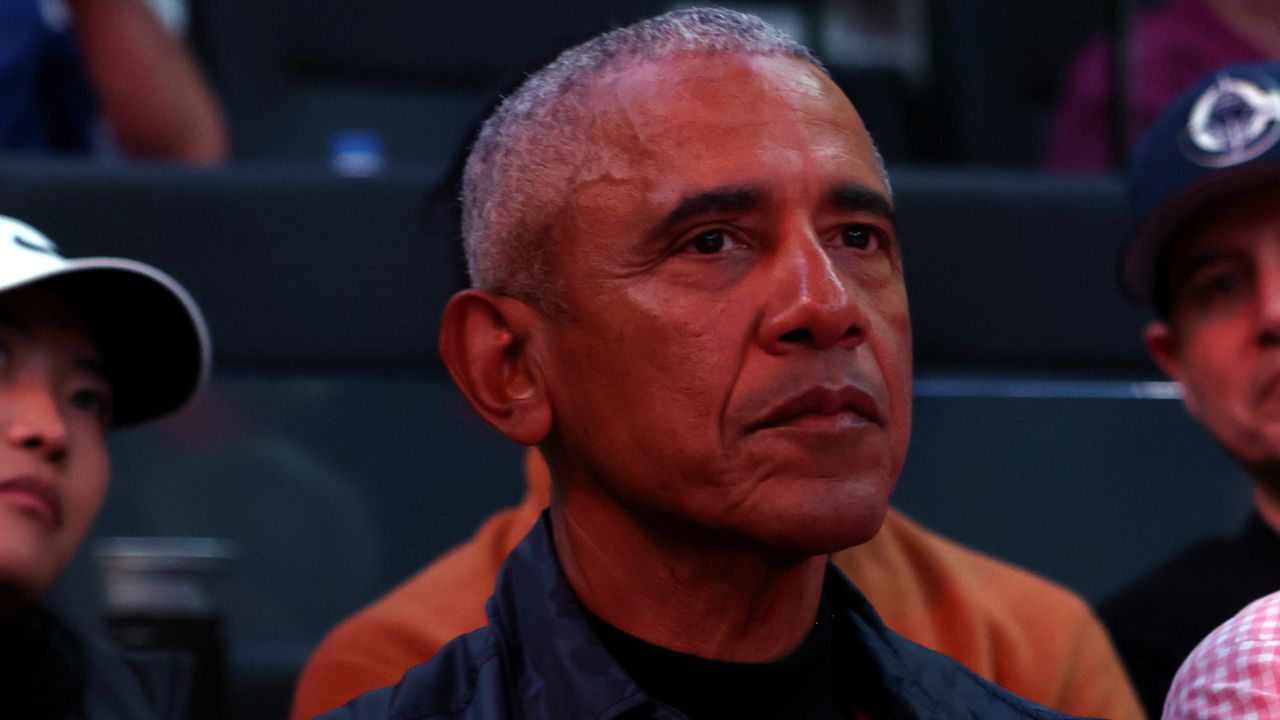L’Europa sta vivendo una trasformazione profonda e silenziosa, ed è una trasformazione che non nasce dalle pressioni esterne, ma dal cuore stesso delle sue istituzioni. Dietro la parola anodina “omnibus”, che richiama le stagioni dei provvedimenti-fiume italiani, si sta consumando un attacco sistemico alle regole che hanno plasmato l’Unione negli ultimi vent’anni. Un attacco condotto all’interno del Parlamento europeo da una maggioranza nuova, ibrida, che unisce i Popolari di Manfred Weber ai Conservatori di Giorgia Meloni, fino ai Patrioti e ai gruppi che orbitano attorno a Marine Le Pen e Viktor Orbán. È una fusione politica che sta cambiando la grammatica dell’Europa più di quanto non dicano i comunicati ufficiali.
Il segnale più evidente è arrivato giovedì, quando il Ppe ha festeggiato l’approvazione del “sustainability omnibus”, esibito come un trofeo: «Siamo andati oltre la proposta della Commissione», ha affermato Jörgen Warborn, il relatore che guida il dossier. “Oltre” significa alleggerire gli obblighi per le imprese, ridurre la trasparenza, smontare pezzo dopo pezzo le responsabilità sociali e ambientali introdotte negli anni grazie alle mobilitazioni di ong, sindacati, attivisti. È un rovesciamento culturale che coincide con l’“urgenza di semplificazione” evocata da Ursula von der Leyen sin dall’inizio del suo secondo mandato, una scelta che si sovrappone sorprendentemente alle richieste di BusinessEurope, la Confindustria continentale.
La rotta della Commissione era chiara già a gennaio, quando la presidente, fresca della riconferma con il sostegno decisivo delle destre, ha annunciato la sua “Bussola per la competitività”: meno vincoli, meno obblighi di rendicontazione, più libertà per l’industria. Lo strumento per raggiungere questi obiettivi non passa attraverso il dibattito ordinario, con studi d’impatto e consultazioni pubbliche, ma attraverso una serie di atti omnibus che funzionano come spugne legislative: cancellano ciò che esiste, rarefanno le tutele, rimescolano gli equilibri.
È una scelta che segna il confine tra due stagioni politiche. Nel 2020, agli esordi, von der Leyen fu la prima a intestarsi la “corporate due diligence”, il principio secondo cui le aziende che vogliono operare sul mercato europeo devono verificare gli impatti su persone e ambiente lungo tutta la propria filiera. Oggi è la stessa Commissione a rimettere in discussione quel pilastro, proprio nel momento in cui entra finalmente in vigore. È la stessa Commissione che depotenzerà il Gdpr, considerato per anni il grande baluardo europeo contro l’invadenza tecnologica e la sorveglianza di massa. Ed è la stessa Commissione che prepara un “digital omnibus” che colpirà il neonato AI Act prima ancora che abbia il tempo di dispiegare effetti reali.
La regia politica è del Ppe, che da anni sperimenta maggioranze variabili. Weber utilizza gli equilibri parlamentari come una leva: resta nella maggioranza tradizionale quando conviene, poi vira a destra quando gli serve per ottenere ciò che vuole. Il voto segreto invocato dai Patrioti per far cadere il primo testo sull’omnibus ne è stato il segnale plastico: un colpo di mano che ha permesso ai Popolari di rompere la vecchia “piattaforma Ursula” e di tornare in aula con una versione più estremista, approvata insieme alle destre radicali. Le quali, naturalmente, esultano.
Quello che colpisce è la rapidità del cambiamento. Il linguaggio politico della semplificazione – «non si deve disturbare chi produce», come ripete Giorgia Meloni nei suoi comizi – è stato adottato con sorprendente naturalezza dalla Commissione. Non è più l’Europa dell’antitrust e della concorrenza, ma un’Europa che scommette sulle concentrazioni industriali e sullo “scale up”, una visione che favorisce grandi gruppi e conglomerati a scapito dei meccanismi di controllo. Di fatto, un avvicinamento ai modelli americani in un momento in cui i rapporti con Washington sono segnati dalla pressione esercitata da Donald Trump. Dopo la famosa stretta di mano in Scozia, il presidente americano ha vantato di aver ottenuto da Bruxelles un segnale di disarmo regolatorio; un’affermazione che l’Ue ha dovuto ufficialmente smentire, ma che oggi appare meno improbabile.
La preoccupazione di chi segue i dossier dall’interno è che il meccanismo degli omnibus diventi la normalità. Il prossimo pacchetto, quello “digital”, sarà presentato mercoledì e conterrà modifiche destinate a indebolire privacy, sicurezza, tracciabilità dei dati. Una manovra che, secondo chi conosce i documenti preparatori, ha già ottenuto il sostegno dei governi più ostili alla governance digitale europea. E che vede il Ppe pronto a giocare lo stesso schema: scavalcare la Commissione, cercare una maggioranza con la destra, quindi presentare la misura come un successo pragmatico per “aiutare la competitività”.
È un cambio di paradigma che ridisegna non solo il profilo dell’Unione ma anche il ruolo del Parlamento. Un tempo orgoglioso della propria autonomia, oggi guidato da una presidente – Roberta Metsola – eletta con i voti dell’estrema destra, che garantisce al Consiglio «ciò che si aspetta». La frase circola da giorni nei corridoi di Bruxelles, come un avvertimento su ciò che verrà.
In questo clima, ong e sindacati contano ormai gli spazi che restano. La mobilitazione sulla corporate due diligence aveva convocato oltre 700 organizzazioni in tutta Europa. Oggi quel fronte vede ridursi le sue possibilità di intervento, mentre i governi si allineano alla linea del pragmatismo e il Parlamento sperimenta alleanze fluide che spingono sempre più a destra.
La tempesta perfetta contro l’Europa, dicono alcuni. Una riscrittura silenziosa delle regole, dicono altri. Il fatto certo è che la battaglia sugli omnibus non è un dettaglio tecnico: è la fotografia di un’Unione che decide di cambiare pelle, e che lo fa nel modo più discreto, più rapido, più difficile da intercettare. Una trasformazione che sarà difficile ignorare quando i suoi effetti cominceranno a toccare la vita quotidiana di cittadini, imprese e istituzioni.