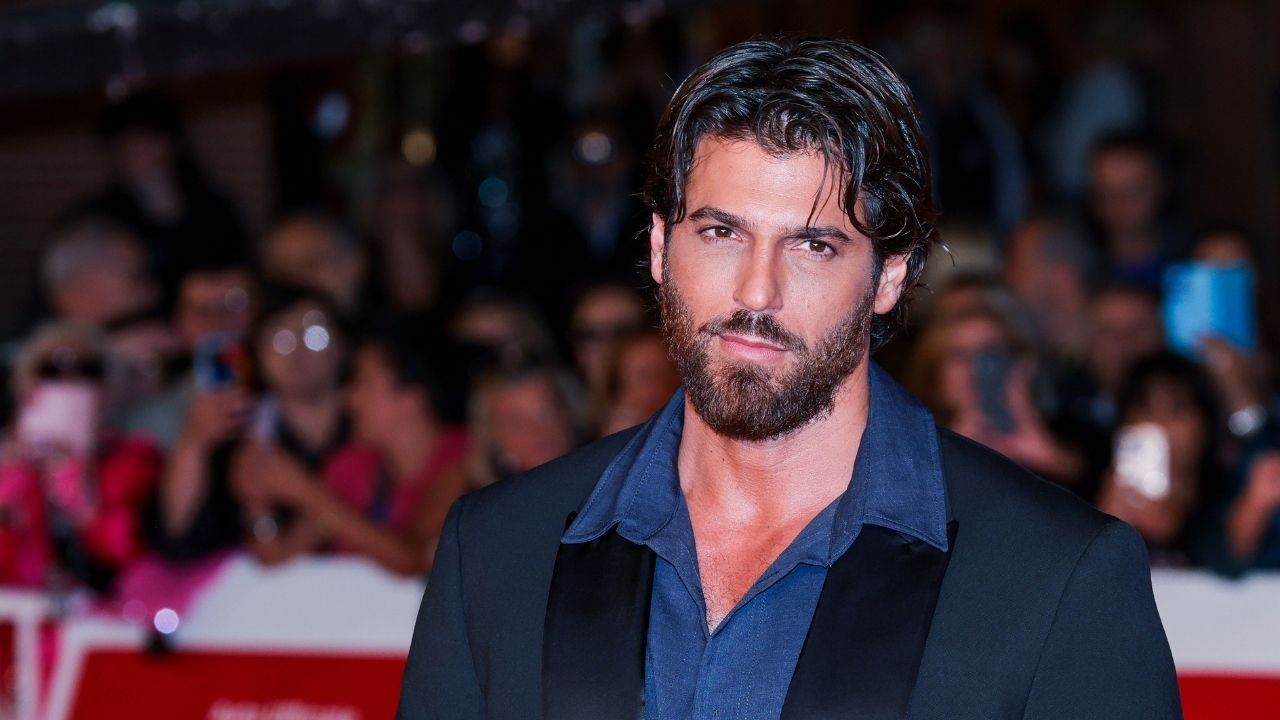Il funesto crollo della Torre dei Conti a Roma, del 3 novembre u.s., non è solo una tragedia monumentale: è lo specchio delle storture del sistema degli appalti e della sicurezza nei cantieri. Dietro il fascino dei restauri finanziati dal PNRR, si nascondono fretta, frammentazione degli appalti e catene di subappalti che diluiscono responsabilità e rendono difficili i controlli. La normativa esiste, i principi di sicurezza sono chiari, ma quando la logica del risparmio e del rispetto dei tempi prevale sulla tutela della vita e sull’integrità degli edifici, anche di quelli storici, tutto il sistema mostra la sua fragilità.
Non basta la verifica formale: serve una cultura reale della sicurezza, un controllo rigoroso della filiera e la certezza che chi firma un appalto sia realmente responsabile di ciò che avviene sul cantiere. Altrimenti, ogni restauro, ogni opera in generale rischia di trasformarsi in una tragedia annunciata e noi tutti convitati di pietra.
L’incidente della Torre dei Conti non è solo una drammatica emergenza locale: è un segnale che richiama la necessità di una reale riflessione sistemica. Quando si parla di lavori pubblici, soprattutto in contesti complessi e vincolati (beni culturali, interventi Pnrr, centri storici), l’equilibrio tra tempi, costi, qualità e sicurezza diventa centrale. Se l’appalto viene concepito come mera gara al più basso costo o al più rapido avvio, si rischia di comprimere le condizioni necessarie per proteggere chi lavora e chi vive intorno al cantiere.
Occorre dunque una revisione degli approcci: la sicurezza e la qualità non possono essere la variabile d’uscita di un sistema che privilegia la rapidità. L’appalto, la ristrutturazione, la riqualificazione devono includere – come condizione primaria e non residuale – la tutela strutturale, la trasparenza nella catena degli affidamenti, il reale esercizio delle responsabilità e la sicurezza dei lavoratori. Solo così un cantiere può essere un’opportunità e non un potenziale dramma.
Occorre fare una breve pausa di riflessione e una rivisitazione delle norme soprattutto forse della Legge Biagi a ventidue anni dalla sua entrata in vigore. Con il D.Lgs. 276/2003 (legge Biagi) viene eliminato il divieto di interposizione nelle prestazioni di lavoro previsto dalla legge 1369/1960, reintroducendo nell’appalto- regolato dall’art. 29- anche la mera fornitura di manodopera. In pratica, basta formalmente il potere direttivo e organizzativo dell’appaltatore – potere che, nella realtà, si manifesta raramente negli appalti endoaziendali o nelle attività strettamente connesse al ciclo produttivo dell’appaltante.
L’esperienza dimostra infatti che nessun imprenditore accetta che qualcun altro “comandi” nella propria azienda, mentre l’assunzione del rischio d’impresa è praticamente quasi sempre inesistente: il costo dei servizi appaltati riguarda quasi esclusivamente la remunerazione della manodopera. Così, ciò che doveva essere uno strumento di flessibilità si è trasformato in un meccanismo di precarizzazione e sfruttamento, con lavoratori che diventano meri strumenti di profitto, privi di reale tutela e di autonomia nella gestione del proprio lavoro.
Gli oltre vent’anni della legge Biagi si caratterizzano per stagnazione economica, produttività ferma e un’espansione incontrollata di appalti e subappalti, accompagnati dal ritorno di forme di lavoro che si avvicinano al «paraschiavismo».
Ventidue anni di appalti di manodopera dovrebbero raccontare la modernità del lavoro italiano, ed oggi essere pronti per la sfida dell’Intelligenza artificiale. Invece, parlano ancora di sfruttamento, precarietà e “flessibilità “che significa solo un’altra parola “mercificazione del lavoro umano”, fino a quando non interviene la Morte!!
Nella pratica, gli appalti raramente rispettano i limiti fissati dalla legge: l’impresa committente mantiene il controllo completo sui lavoratori senza assumersi alcun rischio economico. I subappalti a catena, incontrollati, ed oggi la moltiplicazione dei contratti di rete moltiplicano il precariato, ritardano i pagamenti, e lasciano i lavoratori senza garanzie né tutele. Pulizie, logistica, manutenzione, ristorazione: ovunque il costo principale del servizio è la paga dei lavoratori, e il rischio d’impresa resta un’illusione. Secondo alcuni sociologi del lavoro, il nuovo assetto normativo ha realizzato il sogno dei datori di lavoro: poter impiegare nella propria azienda decine di migliaia di lavoratori non propri, senza obblighi reali nei loro confronti. L’essere umano diventa una risorsa da sfruttare, come un macchinario: attivabile e disattivabile a piacimento, un mero meccanismo di ON-OFF senza tutele né diritti.
Si è così instaurata “… una nuova organizzazione sociale basata su tre pilastri: la ricchezza accumulata dai padri, la distruzione della scuola e dell’università, e un’infrastruttura di stampo paraschiavistico…”, che interessa milioni di persone in tutti i settori economici e dei servizi. I lavoratori coinvolti svolgono mansioni pesanti, usuranti o degradanti, sottopagati, licenziabili in qualsiasi momento e privi di protezioni legali o sindacali, intrappolati in contratti capestro o addirittura senza contratto e noi ispettori del lavoro siamo sempre molto pochi.
Il fenomeno dell’interposizione lavorativa, celebrato dai cantori della legge Biagi come simbolo di modernità, flessibilità e competitività, non si dimostrato altro che un meccanismo per precarizzare i lavoratori e aumentare i profitti. Dietro le parole altisonanti di produttività e occupabilità, si nasconde la realtà: milioni di persone trasformate in strumenti, senza diritti, senza sicurezza e senza dignità. Qualcuno definisce il sistema degli appalti e del lavoro interposto contemporaneo come «paraschiavistico», e Papa Francesco lo confermava con forza, il primo maggio di qualche anno fa: «Ci sono ancora gli schiavi… ogni ingiustizia che si fa al lavoratore è calpestare la dignità».
La legge 1369/1960, ispirata dalla Carta di Filadelfia del 1944, sanciva un principio chiaro: “Il lavoro non è merce”. Un principio universale che affonda le radici nella storia: già nel 1929, John Steinbeck descriveva la Grande Crisi americana come una spirale di sfruttamento in cui i lavoratori erano disposti ad accettare salari sempre più bassi pur di sopravvivere, anticipando quella che definì “la nuova schiavitù”. E ancora nel 1860 Abraham Lincoln denunciava la stessa ingiustizia: pochi godono dei frutti del lavoro di molti. Coerente con le sue parole, Lincoln abolì la schiavitù e lottò contro chi voleva mantenerla, ricordandoci che la dignità del lavoro non è negoziabile.
Oggi, a distanza di decenni, il sistema degli appalti(nelle sue forme diverse di esternalizzazione) e delle cooperative spurie ripropone questa stessa dinamica: milioni di lavoratori trattati come merce, privi di tutele e costretti a mansioni pesanti e sottopagate. La storia sembra ripetersi, ma le parole dei grandi testimoni del passato ci ricordano che la dignità del lavoro deve sempre venire prima del profitto.
L’intervento della Magistratura del lavoro sul fenomeno dell’interposizione di manodopera – appalti, somministrazione, distacco – ha prodotto risultati positivi e importanti, ma resta una lunga battaglia contro pratiche che spesso aggirano i diritti dei lavoratori. Solo nel 2016 si è registrata una falla normativa, prontamente sanata successivamente, che però evidenzia quanto fragile sia la tutela reale. La Cassazione, già con le Sezioni Unite 22910/2006, ha chiarito un principio inequivocabile: “Datore di lavoro è chi utilizza effettivamente le prestazioni del lavoratore… chi le utilizza deve adempiere a tutte le obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro”.
E ha ribadito che questo principio non è stato né può essere cancellato dal D.Lgs. 276/2003: le innovazioni introdotte rappresentano eccezioni tipizzate, mai deroghe generali. In altri termini, non si può trasformare la somministrazione o l’appalto in una scappatoia per eludere responsabilità, ma questo spesso accade nei fatti. La giurisprudenza non più recente (Cass. 29889/2019) confermava che il divieto di interposizione resta saldo: l’art. 29 D.Lgs 276/2003 ribadisce la sostanza della normativa storica, stabilendo quali strumenti sono leciti e quali pratiche costituiscono sfruttamento, con sanzioni concrete per somministrazione irregolare o appalto fittizio.
Eppure, la realtà mostra uno scarto drammatico tra norma e prassi: milioni di lavoratori restano sottopagati, licenziabili, privi di tutele, mentre aziende aggirano il principio di “datore effettivo” trasformando esseri umani in semplici costi variabili, come se il lavoro fosse una merce. La Corte ha chiarito che il datore di lavoro formale deve sempre dimostrare la genuinità dell’intermediazione, ma spesso la prova è difficile da ottenere, soprattutto quando le catene di appalti sono lunghe e complesse.
In sostanza, la legge c’è, la giurisprudenza conferma principi chiari, ma la vera sfida resta la loro applicazione: mentre le norme tentano di proteggere la dignità dei lavoratori, il sistema degli appalti e della somministrazione continua a offrire scorciatoie per sfruttamento e precarizzazione. La questione non è solo tecnica: è etica, economica e sociale, e mette in luce quanto fragile sia la tutela dei diritti nel mercato del lavoro contemporaneo.La giurisprudenza, pur ribadendo continuamente che la somministrazione irregolare e l’interposizione fittizia sono vietate (Cass. n. 18530/2023, n. 18455/2023, n. 25167/2025), non riesce a fermare la diffusione di questa pratica: la legge ha creato strumenti, ma non ha impedito che diventassero mezzi di sfruttamento. Appalti “genuini” , distacchi leciti sono l’eccezione; la norma, nel concreto, è stata usata per aggirare responsabilità e diritti.
La separazione tra il “datore di lavoro formale” e l’utilizzatore reale della prestazione è stata teoricamente condizionata e limitata dal legislatore: ammessa solo in ipotesi computate e controllate, come fossero eccezioni al principio che tutela il lavoratore. Ma oggi questo impianto si frantuma sotto il peso della realtà. Il D.Lgs. 276/2003 non ha abolito il divieto della somministrazione irregolare di manodopera (già vietata dall’art. 1 della Legge 1369/1960), e tuttavia questa norma è stata aggirata con sistemi che la giurisprudenza recente denuncia come appalti-fantasma e simulazioni che portano al lavoro privo di tutele.
La Cassazione ha ribadito: spetta sempre al datore “formale” e sostanziale dimostrare che l’intermediazione è genuina. Quando questo non avviene, si viene alla luce del sole situazioni in cui il lavoratore è subordinato di fatto all’appaltante, ma formalmente collocato da un’altra impresa–una modalità che riproduce fedelmente lo sfruttamento-: urlo a gran voce mansioni usuranti, paghe basse, licenziabilità rapida, diritti negati!!
Sentenze recenti chiariscono la gravità della situazione. Per esempio:
- Con la ordinanza n. 20591 del 2024 la Cassazione ha affermato che negli appalti “labour‐intensive”, ad alto utilizzo di manodopera, è necessario valutare con rigore l’effettiva assunzione del rischio d’impresa e la reale autonomia dell’appaltatore
- Con la sentenza n. 18530 del 4 maggio 2023 la Cassazione ha confermato la condanna per “contratto di appalto” che in realtà simulava una somministrazione di manodopera
- Con la sentenza n. 18455 del 28 giugno 2023 la Cassazione ha ribadito che la fornitura di mezzi tecnici e attrezzature dall’appaltante all’appaltatore può determinare la presunzione della somministrazione vietata, se l’appaltatore non è autonomo nell’organizzazione e gestione
- Più di recente, la sentenza n. 25167 del 9 luglio 2025 ha affermato che un appalto che è “schermo” per somministrazione irregolare può integrare addirittura il reato di dichiarazione fraudolenta mediante fatture per operazioni inesistenti.
Questi sviluppi mostrano che la norma esiste, le sentenze pure, ma la pratica dominante continua a privilegiarne l’elusione. Gli appalti “leggeri”, quei contratti dove la prestazione è quasi esclusivamente manodopera e l’appaltatore è di fatto solo un “staff nominale”, sono il terreno su cui si costruisce un lavoro senza tutela. I lavoratori diventano variabili usa-e-getta, gestiti come semplici costi, privati del diritto elementare di essere riconosciuti come soggetti di un rapporto di lavoro vero. In conclusione: la legge c’è, i giudici ribadiscono i principi, ma manca il reale salto di applicazione. Il sistema degli appalti e delle catene di somministrazione irregolare continua a evolvere, aggirando diritti, diluendo responsabilità, mascherando il rapporto di lavoro subordinato.
È una questione non solo tecnica e giuridica, ma soprattutto morale: di dignità, di equità, di rispetto per chi lavora. E finché la direzione dell’intervento sarà solo punitiva e sporadica, senza un cambiamento strutturale del modello organizzativo e della cultura del lavoro, la promessa di tutela rimarrà una dichiarazione formale, non una realtà vissuta. Il fenomeno degli appalti illeciti, delle false cooperative e della somministrazione abusiva di manodopera rappresenta una delle più rilevanti sfide strutturali del mercato del lavoro italiano contemporaneo. A oltre venti anni dall’entrata in vigore della Legge Biagi, si osserva come il quadro normativo, pur formalmente orientato alla tutela dei lavoratori, presenti rilevanti margini di discrezionalità e inefficacia applicativa. La cosiddetta “flessibilità” organizzativa, teorizzata come principio di modernizzazione del lavoro, si traduce spesso in una dissociazione tra rischio imprenditoriale e obblighi nei confronti dei lavoratori, favorendo forme di interposizione che la giurisprudenza continua a definire irregolari (Cass. S.U. n. 22910/2006; Cass. n. 25167/2025).
Il contrasto efficace agli abusi richiede un rafforzamento sistematico dei controlli ispettivi. La semplice verifica episodica della regolarità contrattuale non è sufficiente a interrompere la catena dei subappalti e delle cooperative spurie. È necessario sviluppare strumenti digitali e banche dati centralizzate per la tracciabilità dei contratti, delle ore lavorate e dei pagamenti, accompagnati da sanzioni proporzionate e certi, in grado di scoraggiare le pratiche irregolari. La dottrina e la giurisprudenza sottolineano da tempo che il datore di lavoro effettivo, cioè chi utilizza le prestazioni del lavoratore, non può sottrarsi alle proprie responsabilità. Tuttavia, nella pratica, la responsabilità solidale tra committente e appaltatore rimane scarsamente applicata.
Rafforzare questo principio, con obblighi chiari di verifica e certificazione della genuinità dell’appaltatore, costituisce un passaggio imprescindibile per collegare effettivamente flessibilità organizzativa e tutela dei diritti fondamentali dei lavoratori. Il fenomeno delle cooperative di comodo evidenzia una lacuna normativa: la possibilità di costituire soggetti giuridici formalmente regolari ma privi di reale autonomia. È necessario prevedere criteri oggettivi per distinguere le cooperative autentiche da quelle funzionali alla mera elusione degli obblighi contrattuali, e introdurre misure sanzionatorie che ne impediscano la partecipazione agli appalti pubblici e privati.
Le tutele attuali risultano spesso inadeguate di fronte a forme di sfruttamento sistematico. Occorre garantire strumenti efficaci di accesso diretto alla giustizia, meccanismi di segnalazione anonima e fondi di garanzia salariali in caso di insolvenza o frode dell’appaltatore. Inoltre, incentivare la contrattazione collettiva e le azioni sindacali può contribuire a ristabilire un equilibrio tra potere contrattuale dei lavoratori e margini di flessibilità delle imprese.
La criticità del fenomeno richiede una visione integrata: normativa chiara, responsabilità estesa, controlli efficaci, sanzioni certe e tutela attiva dei lavoratori. Solo un approccio sistemico può ridurre le distorsioni generate dall’interposizione e dalla somministrazione abusiva di manodopera, evitando che la flessibilità diventi sinonimo di sfruttamento.
In conclusione, il dibattito sulla modernizzazione del lavoro non può limitarsi a slogan retorici sulla competitività e l’occupabilità. La verifica empirica e giurisprudenziale dimostra che senza regole rigorose e strumenti di tutela realmente operativi, gli appalti di manodopera rischiano di perpetuare una condizione di precarietà strutturale e sfruttamento legalizzato, riproponendo forme di lavoro “paraschiavistico” contemporaneo. Oggi è predominante il lavoro “usa-e-getta”. Secondo dati recenti dell’INAIL e delle ispezioni dell’INL, in alcuni settori oltre il 50 % degli appalti risulta irregolare, con violazioni di sicurezza e contrattuali. La normativa esiste, ma senza un’applicazione rigorosa e controlli incisivi, la “flessibilità” resta un eufemismo per sfruttamento sistematico.
di Francesca Levato