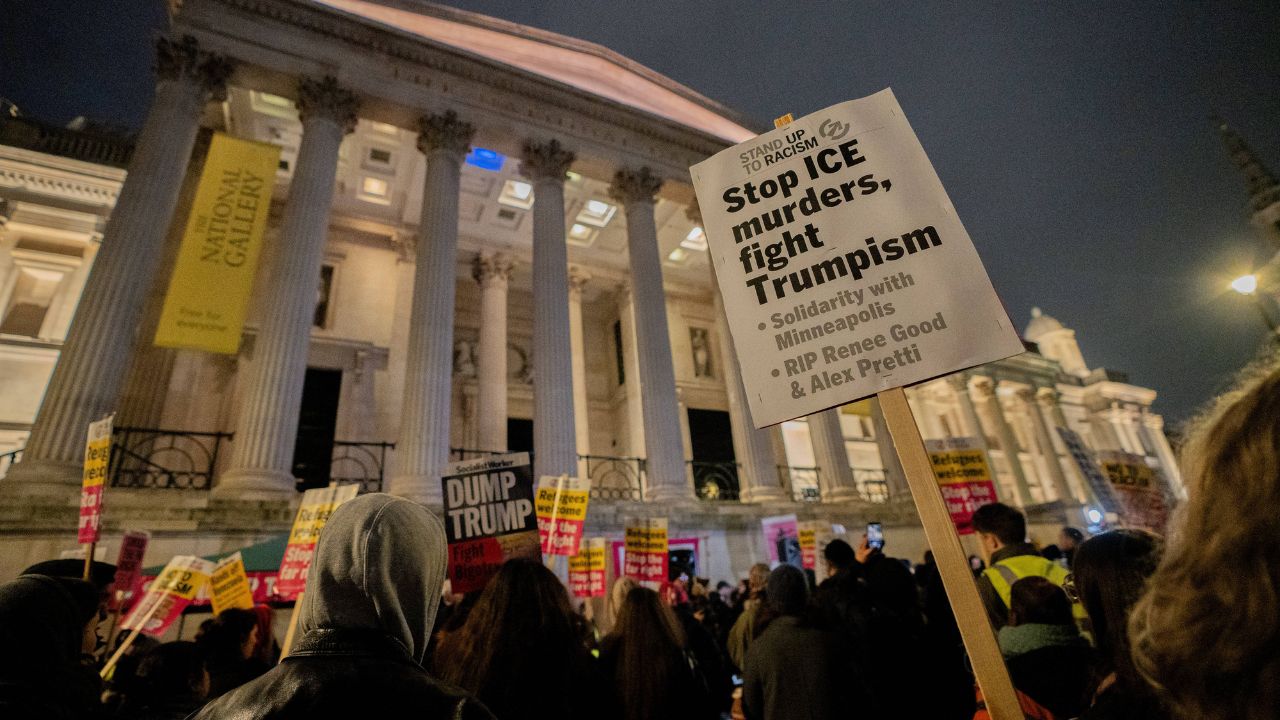Mario Draghi non usa mezzi termini e trasforma il suo rapporto sull’economia europea in una requisitoria politica. A Bruxelles, dice, è scattata l’ora della verità. «L’inazione minaccia la nostra sovranità», ammonisce. Un avvertimento che arriva in un contesto in cui l’Unione europea appare sempre più lenta nel reagire alle sfide globali: la guerra commerciale avviata da Donald Trump tornato alla Casa Bianca, la competizione crescente con la Cina, la fragilità delle catene di approvvigionamento.
Secondo Draghi, l’Europa continua a pagare una dipendenza eccessiva dall’estero. L’accordo Mercosur può offrire qualche margine, ma non cambia la sostanza: «Gli Stati Uniti assorbono circa tre quarti del deficit delle partite correnti globali. Diversificare i mercati è irrealistico nel breve termine». Il risultato è che i margini di manovra sono ridotti e l’Ue rischia di restare schiacciata tra due giganti che corrono molto più veloci.
Il punto centrale della sua analisi riguarda la lentezza del sistema comunitario. «C’è una grande frustrazione tra cittadini e imprese», sottolinea. «Ci vedono incapaci di tenere il passo con la velocità del cambiamento altrove. Sono pronti ad agire, ma temono che i governi non abbiano colto la gravità del momento». Una denuncia che mette a nudo il divario tra le aspettative della società e la capacità delle istituzioni di rispondere.
Draghi non accetta la giustificazione secondo cui la complessità dei meccanismi europei è garanzia di rispetto delle regole: «Si trovano scuse per questa lentezza, diciamo che è il modo in cui è costruita l’Ue, che è rispetto dello stato di diritto. Questo è compiacimento».
La ricetta è chiara: «Serve un percorso diverso che richiede nuova velocità, scala e intensità. Significa agire insieme, non frammentare gli sforzi. Concentrare le risorse dove l’impatto è maggiore e produrre risultati entro mesi, non anni». Una linea che suona come un ultimatum, indirizzato a governi spesso più attenti alle politiche interne che a quelle comuni.
Uno dei fronti più caldi resta quello dell’auto. Draghi smonta i target ambientali fissati dall’Ue, in particolare la scadenza del 2035 per la vendita di veicoli a emissioni zero: «Quegli obiettivi si basano su presupposti ormai superati». Il piano avrebbe dovuto generare un circolo virtuoso, con infrastrutture di ricarica capillari, crescita del mercato interno e calo dei costi delle auto elettriche. Ma il meccanismo non ha funzionato.
«Ci si aspettava che settori adiacenti come batterie e chip si sviluppassero parallelamente, sostenuti da politiche industriali mirate. Non è accaduto», constata. Il risultato è un’industria in affanno, stretta tra la concorrenza cinese e l’aggressività statunitense, mentre i consumatori restano disorientati.
Le parole dell’ex premier assumono il tono di una chiamata alle armi. Draghi non si limita a evidenziare ritardi e promesse mancate, ma mette in discussione la tenuta stessa della sovranità europea. «Significa produrre risultati entro mesi», ripete. Non un consiglio, ma una scadenza politica.
Il rapporto, richiesto dalla Commissione europea, arriva a pochi mesi dalle elezioni comunitarie e diventa inevitabilmente un documento politico. Da Bruxelles si aspettavano un’analisi tecnica, hanno ricevuto una sveglia sonora. Una denuncia che costringe i governi a uscire dall’ambiguità: continuare con la logica del rinvio o assumere finalmente scelte drastiche.
La mossa di Draghi, come sempre, è calibrata. Non un attacco frontale a von der Leyen, ma un messaggio che attraversa l’intera architettura europea. E che lascia intravedere il suo ruolo futuro: tecnico, garante o possibile protagonista della prossima stagione comunitaria.
Per ora resta la fotografia di un’Europa ferma mentre il mondo corre. Una fotografia che porta la firma di Mario Draghi e che difficilmente potrà essere archiviata come un documento qualsiasi.