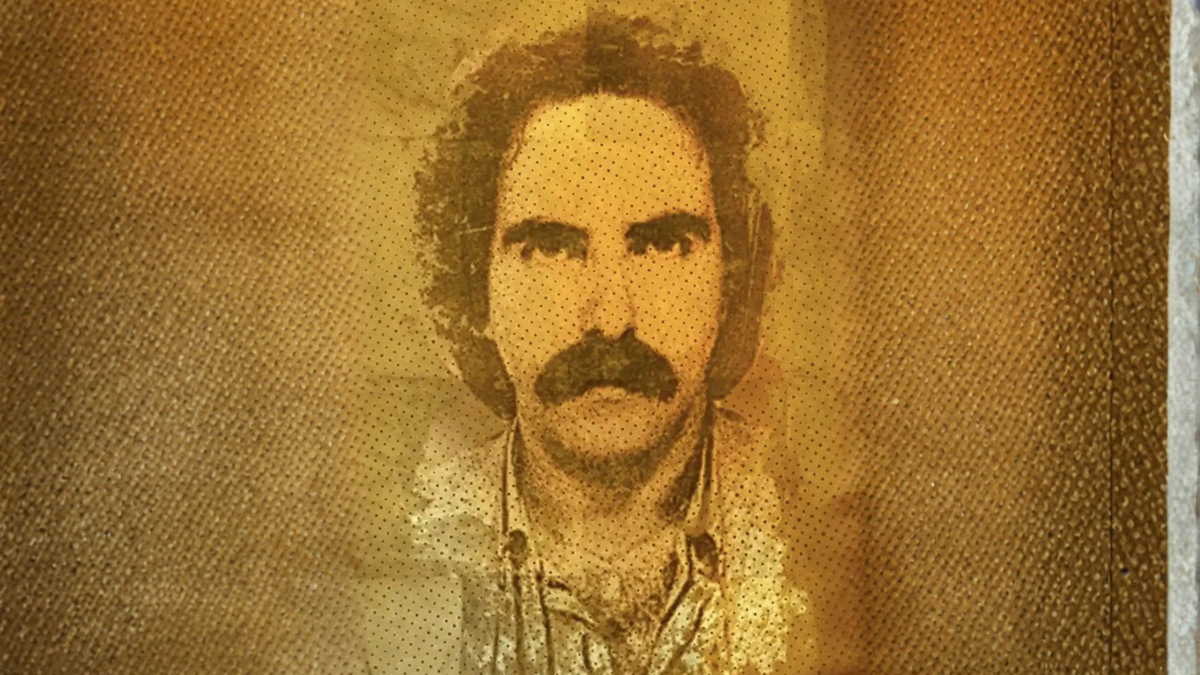La Lega è entrata in uno di quei momenti in cui, sotto la cenere, non c’è più brace: c’è direttamente il fiammifero. La scissione di Roberto Vannacci, che per una parte della vecchia guardia viene descritta come la fine di un’“anomalia”, non è soltanto un capitolo di folklore politico o un’uscita di scena da talk show: è il pretesto perfetto, quasi un lasciapassare, per riaprire la questione che nel Carroccio nessuno ha mai davvero chiuso. Che fine farà Matteo Salvini? E soprattutto: quante chance ha di restare in sella, adesso che il partito è di nuovo attraversato da una tentazione antica, quella di tornare al Nord, al pragmatismo, al federalismo da tessera e sezioni, mettendo in soffitta l’idea di una Lega “nazionale” che ha divorato la vecchia Padania e poi si è messa a inseguire qualunque vento tirasse più forte?
Dentro questo scenario, la lettura più cinica e insieme più diffusa è semplice: Vannacci, per alcuni, non è stato solo un alleato scomodo. È stato anche un alibi. Una figura ingombrante che permetteva di rimandare la resa dei conti, perché finché il problema si chiamava “Vannacci”, Salvini poteva presentarsi come l’unico argine interno capace di tenere insieme un pezzo di partito e un pezzo di pubblico. Adesso che quel pezzo se ne va, la domanda torna nuda: non c’è più nessuno da usare come bersaglio intermedio. Il bersaglio finale, se qualcuno deciderà di sparare, è il segretario.
I segnali che arrivano dal racconto interno sono quelli tipici dei partiti che si stanno guardando allo specchio con un’espressione che non promette bene. C’è chi parla di “boccata d’aria fresca”, chi sogna un ritorno alle urne nel Nord, chi ripete che gli anni delle “mattane” sovraniste hanno lasciato in giro più macerie che consenso. E poi ci sono i numeri, che in politica non sono mai innocenti. Secondo un sondaggio attribuito a “Izi”, presentato in una trasmissione televisiva, la potenziale base elettorale di un’eventuale formazione di Vannacci sarebbe prevalentemente di destra e con un bacino che arriva in larga parte da Fratelli d’Italia.
La fotografia che circola è questa: il 39% di chi sarebbe disposto a votare “Futuro Nazionale” alle ultime politiche avrebbe scelto FdI, quasi il 26% avrebbe votato Lega, il 20% proverrebbe da altri partiti e un 15% nel 2022 non avrebbe votato. Traduzione brutale: Vannacci non “porta via” solo alla Lega. Ma alla Lega qualcosa porta via eccome, e nel momento peggiore possibile.
È qui che entra in scena il trio dei governatori, i “caballeros” che da anni vengono evocati come l’ombra lunga sulla segreteria di Salvini: Attilio Fontana, Massimiliano Fedriga e Luca Zaia. Da tempo, raccontano i rumor, i tre manifestano insofferenza, poi però al momento della sfida vera, quella che non si risolve con una mezza frase in corridoio, la partita si raffredda. Stavolta, però, l’aria è diversa perché l’occasione sembra scritta apposta: la scissione di Vannacci può essere presentata come il “reset” necessario per riposizionare il partito. E quando un partito parla di riposizionamento, di solito sta parlando di leadership.
Ma non è un’offensiva semplice, né lineare. Perché Zaia, per quanto venga indicato come il più “libero” politicamente, non è più governatore e questo gli dà spazio, sì, ma gli toglie anche quella leva quotidiana del potere istituzionale che oggi pesa più delle tessere. E infatti, nel racconto interno, Zaia viene dipinto come l’uomo che potrebbe prendersi sulle spalle ciò che resta e ri-aggregare i nordisti della prima ora, compresi i bossiani che orbitano fuori dal partito. Il problema, dicono gli stessi che lo citano, è la voglia: troppo istituzionale, poco incline alla conflittualità, poco “divisivo” nel senso politico del termine. E senza una dose di conflitto, certe scalate non partono nemmeno.
L’alternativa “di sorpresa” sarebbe Massimiliano Fedriga: più giovane, presidente del Friuli Venezia-Giulia, con un profilo che negli anni si è costruito una reputazione da amministratore solido. C’è chi sostiene che avrebbe il supporto di Zaia, e chi pensa che proprio questa coppia possa diventare il baricentro di un nuovo corso. Il punto è che Fedriga ha un mandato lungo davanti e, di conseguenza, anche un rischio personale enorme: entrare in una guerra interna significa bruciarsi le mani. E il potere, in politica, è anche l’arte di capire quando conviene tenere le mani pulite e quando invece bisogna affondarle nel fango.
Sullo sfondo, però, c’è un altro nome che torna come un ritornello: Massimiliano Romeo, segretario della Lega lombarda, indicato come possibile regista della pressione interna. Non necessariamente il volto pubblico, ma l’uomo capace di trasformare l’irritazione diffusa in una strategia. Perché le rivolte interne non nascono mai solo dalla rabbia: nascono quando qualcuno organizza la rabbia e le dà un calendario.
E infatti il calendario, in questa storia, ha una data precisa: 23 marzo. Il referendum sulla riforma della giustizia. Nel racconto che circola in Lega, quel voto si è trasformato in ciò che spesso succede in Italia: da consultazione su un tema specifico a prova di forza politica, un test sul governo e sui suoi equilibri, una cartina tornasole che tutti interpreteranno come vogliono. La logica interna descritta è spietata: se vince il “Sì”, Salvini potrà rivendicare una tenuta, un risultato, un’aria di vittoria utile a congelare la contestazione.
A quel punto, ai “dissidenti” non resterebbe che tentare la via morbida: “far rinsavire” il leader e riportare il partito su binari più nordisti, più pragmatici, meno ideologici. Tradotto in slogan da bar: meno Lega nazionale, più federalismo e Padania, e chi se ne importa del Ponte sullo Stretto.
Se invece il “No” dovesse imporsi, la lettura cambia di colpo. Per il governo sarebbe l’inizio di una fase di logoramento, perché nessuno perderebbe un referendum senza pagarne il prezzo politico. Ma per Salvini, dentro la Lega, quella sconfitta potrebbe diventare la chiave che mancava: il pretesto “oggettivo” per aprire la pratica del dopo, per trasformare l’irritazione in una resa dei conti che non si può più rimandare. E quando in un partito cominciano a circolare parole come “de profundis”, significa che qualcuno sta già immaginando il giorno dopo.
Resta una variabile, forse la più importante: la Lega, oggi, è un partito che deve decidere se vuole sopravvivere come macchina di governo o come identità. La scissione di Vannacci, per alcuni, è un’opportunità per togliersi un problema; per altri è un rischio perché svuota ulteriormente un consenso già fragile. In mezzo c’è Salvini, che sa fare politica “di pancia” come pochi, ma che negli anni ha anche accumulato nemici, diffidenze e stanchezza. Il 23 marzo dirà qualcosa sul referendum, certo. E in Lega, quando il racconto cambia, di solito cambia anche il manico.