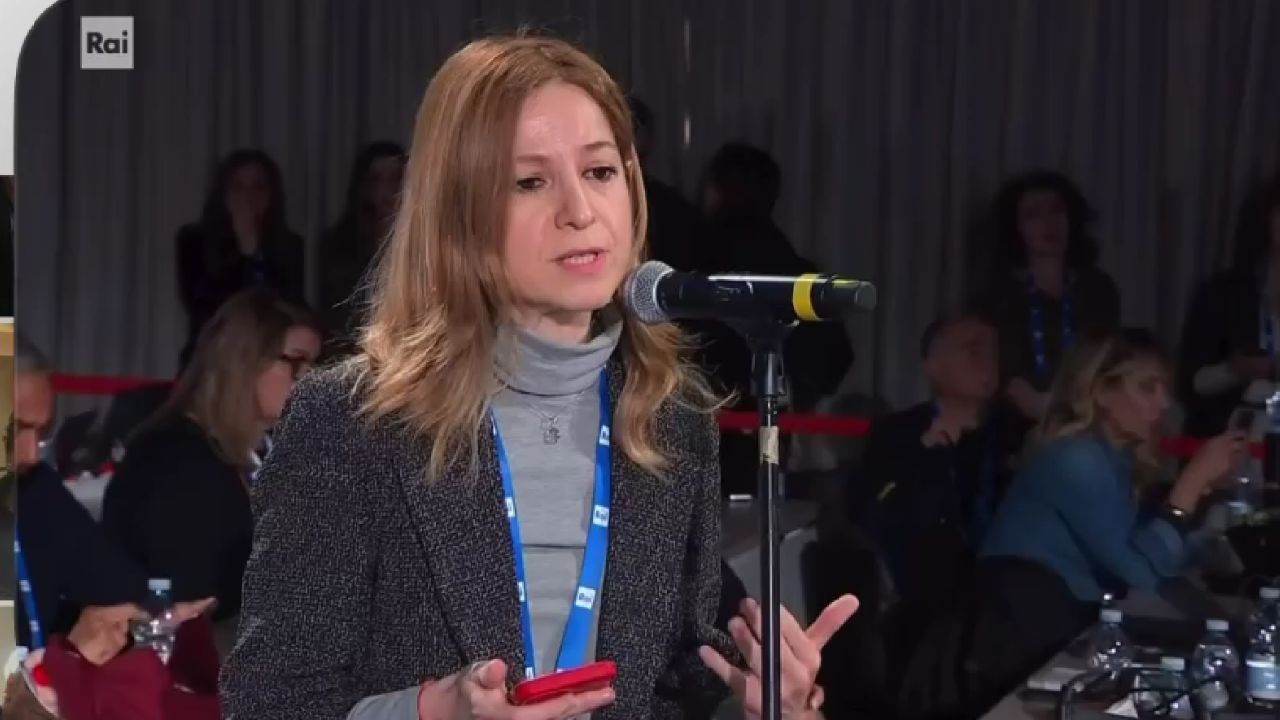Per diventare dirigente dello Stato, d’ora in poi, potrebbe bastare una buona pagella interna. Niente più prove pubbliche, niente più selezioni aperte, niente più concorsi. È questa, in sintesi, la rivoluzione approvata dal Consiglio dei Ministri su proposta del titolare della Pubblica Amministrazione Paolo Zangrillo. Una riforma presentata come meritocratica, ma che rischia di trasformarsi in un’autostrada per promozioni poco trasparenti, chiuse all’interno di un sistema che premia l’anzianità, la permanenza e, soprattutto, la fedeltà.
Secondo il nuovo disegno di legge, i funzionari pubblici con almeno dieci anni di servizio potranno accedere alla dirigenza attraverso un meccanismo di avanzamento “per merito”. Un termine suggestivo, persino nobile, che però assume contorni sfocati se scollegato da un sistema di verifica oggettivo. In questo caso, il concorso pubblico viene sostituito da una procedura interna: sarà la dirigenza a valutare chi è “pronto” per salire di grado. Il rischio? Che il merito venga confuso con l’obbedienza.
Dietro la retorica dell’efficienza si cela un cambio radicale di paradigma: la Pubblica Amministrazione non sarà più un’istituzione aperta, dove tutti possono ambire alle posizioni apicali dimostrando capacità, ma una struttura chiusa, piramidale, dove si scala solo dall’interno. Non per talento, ma per cooptazione. Non per competenza, ma per compatibilità.
Questa modifica incide su uno dei capisaldi della democrazia amministrativa: l’articolo 97 della Costituzione. “Agli impieghi si accede mediante concorso”, recita la norma. Una frase breve, ma carica di significato: il concorso è lo strumento che garantisce l’imparzialità della PA, la parità di condizioni tra cittadini, la separazione tra politica e burocrazia. Abolirlo, o renderlo opzionale, significa scardinare una garanzia di equità in nome di una presunta “modernizzazione”.
Certo, il sistema dei concorsi non è perfetto. I bandi sono lenti, le graduatorie a volte ingestibili. Ma il concorso ha un merito che nessuna procedura interna potrà mai replicare: è aperto, pubblico, anonimo. Premia chi studia, chi si prepara, chi ci prova. Non chi ha saputo aspettare dieci anni al posto giusto. E soprattutto, non chi ha imparato a muoversi bene nella catena gerarchica.
La nuova norma rischia di creare una nuova élite burocratica, impermeabile al rinnovamento. Una PA che promuove sé stessa, secondo logiche interne, sottratte a ogni controllo esterno. I giovani brillanti, i laureati con esperienze internazionali, gli innovatori digitali? Tagliati fuori. Perché non hanno dieci anni di servizio, perché non appartengono al circuito interno, perché non possono essere “valutati” da chi non li conosce.
Si parla di performance, ma si dimentica che i criteri di valutazione sono spesso opachi, difficili da misurare, fortemente influenzati dai rapporti personali. Una riforma davvero meritocratica dovrebbe introdurre strumenti nuovi per valutare il valore reale di chi lavora nella PA: risultati concreti, impatti misurabili, indicatori comparabili. Invece qui si crea un meccanismo autoreferenziale, in cui i capi promuovono chi vogliono. E spesso, chi vogliono, sono quelli che non fanno ombra.
L’esperienza sul campo è certamente un valore. Ma da sola non basta. Il vero merito si misura nella capacità di innovare, di proporre soluzioni, di adattarsi ai cambiamenti. E queste qualità non si acquisiscono con l’anzianità, ma si coltivano con lo studio, l’apertura, il confronto. Con il concorso, appunto.
Zangrillo ha dichiarato che “bisogna superare l’ideologia del concorso”. Ma non è ideologia: è una conquista civile. È la differenza tra una pubblica amministrazione che serve lo Stato e una che serve il potere. Tra un dirigente scelto per valore e uno scelto per convenienza. Tra un Paese che seleziona i migliori e uno che promuove i fedeli.
In un’epoca in cui si chiede alla PA di affrontare sfide complesse – digitalizzazione, transizione ecologica, innovazione dei servizi – serve un capitale umano all’altezza. E per ottenerlo, serve aprire le porte, non chiuderle. Scommettere sul futuro, non sul passato. Costruire percorsi selettivi rigorosi e trasparenti, non passaggi interni che sembrano pensati più per blindare carriere che per riconoscere talento.
Questa riforma rischia di congelare la PA nel suo stato attuale. Di rinunciare all’idea stessa di ascensore sociale, sostituendola con una scala a chiocciola interna, riservata a chi è già salito abbastanza. Di trasformare il “pubblico” in un club privato, dove si entra una volta sola e poi ci si accomoda.
E alla fine, a pagare saranno i cittadini. Perché dietro ogni decisione pubblica c’è un dirigente. E se quel dirigente è stato scelto per fedeltà e non per merito, la qualità del servizio – dalla scuola alla sanità, dalla giustizia alla sicurezza – sarà inevitabilmente peggiore. E nessun comunicato stampa potrà cambiare questa semplice verità.