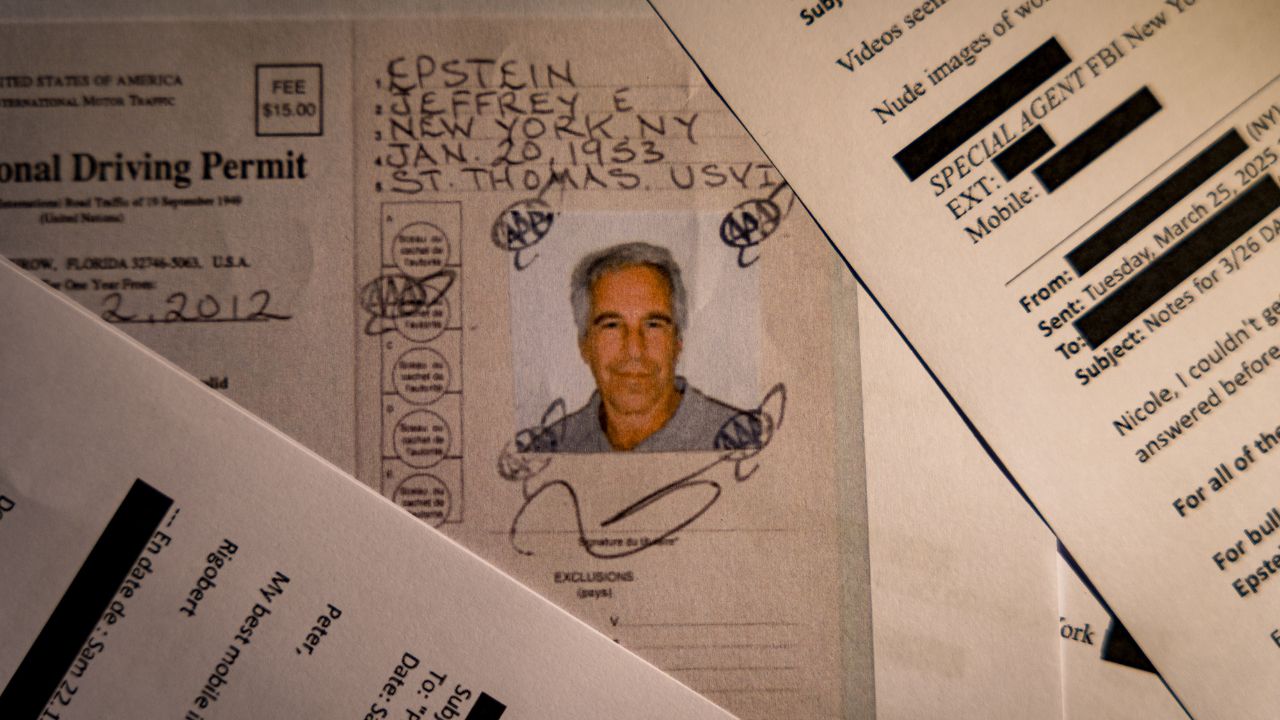C’è una forma di eroismo che non prevede medaglie, ma solo comunicati stampa indignati. È l’eroismo di chi decide di conquistare l’egemonia culturale senza avere la minima intenzione di leggere un libro, ascoltare una critica o accettare un dissenso. È una scalata romantica e un po’ scomposta, condotta con l’ardore dei rivoluzionari e l’attrezzatura di chi ha dimenticato i ramponi a casa.
L’ultimo capitolo si chiama Pucci-gate. Un comico viene invitato a Sanremo, scoppia la prevedibilissima polemica social (perché il Festival è un generatore automatico di indignazione), lui decide di fare un passo indietro. Stop. In qualunque altro Paese sarebbe finita lì. In Italia no. Diventa una questione di libertà, democrazia, censura, persecuzione ideologica e, volendo, pure di sovranità nazionale.
Titoli a nove colonne: “Censura rossa”, “Purghe democratiche”, “Non si può più ridere”. Il governo mobilitato come se fosse stato dichiarato l’assedio all’Ariston. La presidente del Consiglio riflette sulla “deriva illiberale”, il ministro Tajani avverte che è “vietato ridere”, Ignazio La Russa telefona in solidarietà. Una mobilitazione che ricorda la crisi di Sigonella. Solo che qui l’oggetto del contendere non è la geopolitica, ma una battuta.
Il paradosso è questo: la destra rivendica da anni la necessità di conquistare la propria “fetta di egemonia culturale”. Legittimo. La cultura non è un condominio con posti assegnati. Ma l’egemonia non si dichiara. Si costruisce. E non si improvvisa.
Invece l’impressione è quella di un Risiko giocato con la fretta: nomina in quota, annuncio trionfale, polemica, scivolone, accusa alla sinistra, vittimismo, reset. È diventato un format. Prima di Pucci c’era stato Paolo Petrecca, direttore di Rai Sport, protagonista di telecronache olimpiche confuse. Ma guai a parlare di preparazione: è sempre un attacco ideologico.
Poi la vicenda di Beatrice Venezi, che preferisce essere chiamata “il direttore”, con una battaglia linguistica che ha oscurato il merito artistico. Le proteste? Non critiche professionali, ma egemonia rossa. È un riflesso automatico: se qualcuno obietta, è un complotto.
E ancora Pino Insegno, ritorno in grande stile e ascolti minuscoli. O il caso Luca Barbareschi. O la nostalgia di una Rai che dovrebbe incarnare la nuova stagione culturale ma fatica a superare la prova dell’audience. Ogni inciampo diventa una questione ideologica, mai una domanda di competenza.
Il capolavoro narrativo resta l’epopea dell’ex ministro Gennaro Sangiuliano: una saga che ha superato la fiction. E anche lì, invece di interrogarsi sugli errori, si è preferito evocare l’ostilità dell’ambiente culturale.
Il vero nodo è un altro: l’egemonia culturale non è una conquista amministrativa. Non si ottiene per decreto. Non si assegna con una nomina. Non nasce dalla sostituzione di un nome con un altro. Nasce da un tessuto, da un lavoro lungo, da una credibilità riconosciuta. È lenta, organica, stratificata. È l’opposto della reazione impulsiva.
E invece la guerra culturale si combatte come una campagna elettorale permanente. Ogni critica è censura. Ogni flop è sabotaggio. A forza di gridare al complotto, si finisce per non vedere il problema reale: l’autorevolezza non si impone, si conquista.
Il caso Pucci è emblematico. Nessun bavaglio istituzionale, nessuna legge repressiva. Un corto circuito mediatico e una scelta autonoma. Ma trasformarlo in un atto di repressione sistemica serve a rafforzare la narrazione di una maggioranza accerchiata da un nemico culturale onnipresente.
La realtà, meno epica, è più semplice: la qualità non ha bisogno di vittimismo. Quando c’è, si vede. Quando manca, si sente. Nel frattempo la rivoluzione promessa assomiglia a una sit-com involontaria. Si entra in scena con l’aria di cambiare la storia e si esce con un comunicato contro “l’intellighenzia rossa”. Si parla di merito e si scivola sulle competenze. Si invoca la libertà e si reagisce a ogni critica come fosse un attentato.
L’ironia finale è che, nel tentativo di demolire un presunto monopolio culturale, si è finiti per crearne una caricatura speculare. Non un nuovo modello, ma una versione polemica di quello che si contesta. La famosa egemonia diventa una battaglia simbolica sui social, mentre il mondo reale chiede qualcosa di molto più semplice: professionalità, credibilità, serietà.
Forse l’errore è pensare che la cultura sia un territorio da occupare. Non lo è. È un terreno su cui si cammina. E se si inciampa sempre nello stesso punto, prima di accusare qualcuno di aver teso il filo, bisognerebbe controllare le proprie scarpe.
Per ora la rivoluzione culturale resta sospesa tra ambizione e imbarazzo. E l’unica cosa davvero egemonica sembra essere la sensazione che, a furia di gridare alla censura, si sia perso il senso del ridicolo.