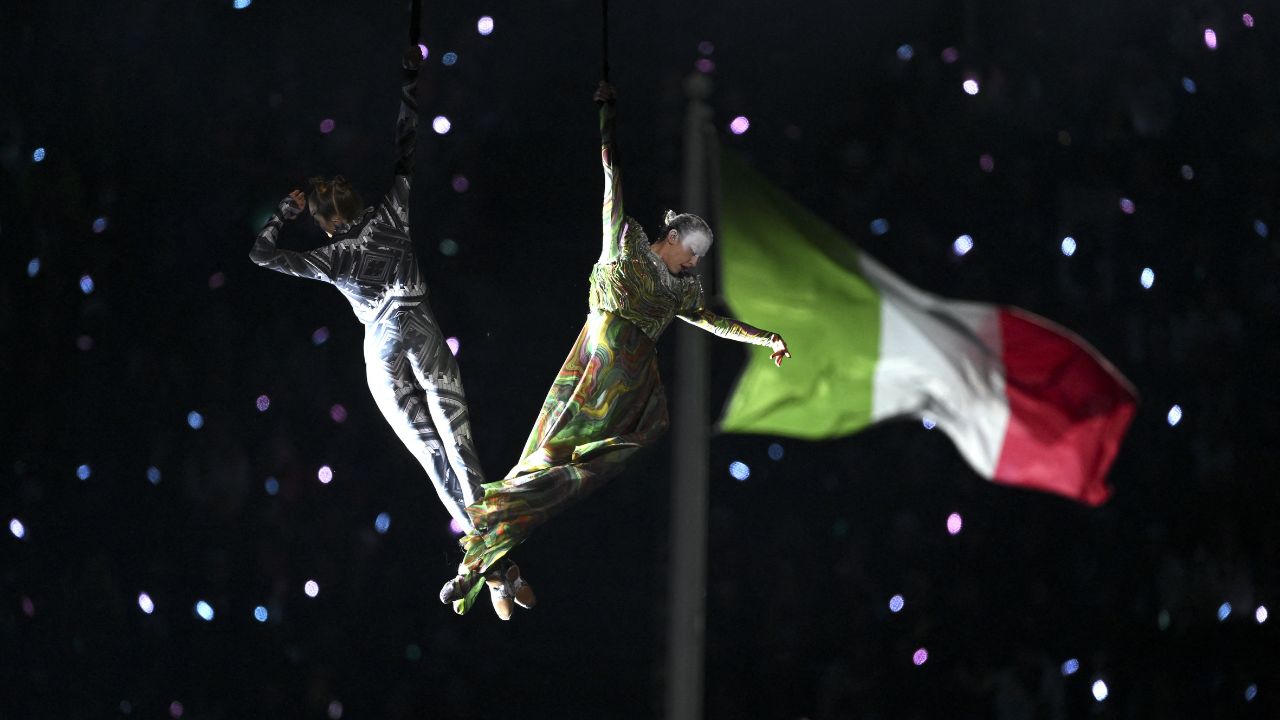La democrazia si regge su cittadini consapevoli, ma l’Italia sembra aver imboccato la strada della disaffezione: cala l’interesse, si allarga il vuoto sociale, cresce il peso dei social. Ma quando arriva il voto, tutti in fila. La politica non interessa più a nessuno, ma poi davanti all’urna ci si presenta comunque. È questo il paradosso che emerge dall’ultimo rapporto dell’Istat sulla partecipazione politica in Italia. Una fotografia che, dal 2003 al 2024, mette in fila numeri impietosi: meno di un italiano su due (48,2%) si informa almeno una volta a settimana di politica, mentre quasi un terzo (29,4%) ammette candidamente di non occuparsene mai.
Tradotto in cifre: oltre 15 milioni di cittadini, tra cui 8 milioni e 900mila donne e 6 milioni e 300mila uomini, vivono come se le scelte di governo non li riguardassero. La democrazia, insomma, sopravvive a colpi di inerzia, con una partecipazione sempre più “silenziosa”, fatta di click distratti sui social e di chiacchiere episodiche, più che di studio, approfondimento e confronto.
Il declino è trasversale, ma colpisce di più chi ha un livello di istruzione più basso. Se tra i laureati soltanto l’11,3% dichiara di non informarsi mai di politica, la quota sale al 24,4% tra i diplomati e tocca il 41,2% tra chi ha al massimo la licenza media. La politica diventa così un affare per élite istruite, mentre il resto del Paese resta ai margini. Con una conseguenza pericolosa: meno partecipazione significa più terreno fertile per slogan facili, fake news e derive populiste.
Anche il genere gioca la sua parte, ma le distanze si assottigliano. Nel 2003 si informava regolarmente il 66,7% degli uomini contro il 48,2% delle donne. Oggi gli uomini sono scesi al 54,1% e le donne al 42,5%, con un divario ridotto a 11,6 punti percentuali. La parità si raggiunge, ma verso il basso: a un livellamento dettato dall’apatia.
Il territorio, poi, conferma le solite spaccature. Nel Centro-Nord più della metà dei cittadini si informa almeno una volta a settimana, mentre al Sud e nelle Isole il dato precipita intorno al 40%. In quelle stesse aree meridionali, non a caso, la quota di chi non si informa mai sfiora il 37,3%, contro il 25% del Nord. È una frattura che non riguarda solo la politica, ma tocca il tessuto sociale ed economico del Paese.
E i mezzi di informazione? Qui il bollettino è ancora più cupo. I talk show politici, un tempo cavalli di battaglia delle prime serate televisive, sono ormai in via d’estinzione: se nel 2003 oltre un cittadino su cinque li aveva seguiti almeno una volta nell’anno, oggi siamo scesi al 10,8%.
Una disfatta per il piccolo schermo, che perde appeal proprio sul terreno che un tempo lo consacrava. Peggio ancora va alla carta stampata: nel 2003 più della metà degli italiani (50,3%) comprava un quotidiano per informarsi, nel 2024 siamo crollati al 25,4%. Si dimezza la platea, si dimezza l’autorevolezza. A sopravvivere, con numeri ben diversi, sono i giornali online: due terzi di chi usa Internet per informarsi (65,4%) continuano a leggere testate giornalistiche in versione digitale. Ma quasi la metà degli utenti (47,5%) preferisce affidarsi ai social network, il regno delle notizie lampo, degli algoritmi e delle fake news.
Nel frattempo, parlare di politica è diventata un’attività residuale. Più di un terzo degli italiani (36,9%) non discute mai di politica con amici, familiari o colleghi. Una cifra che significa 11 milioni e mezzo di donne e 7 milioni e mezzo di uomini. Il silenzio sostituisce il confronto, e la piazza – reale o virtuale – diventa terreno di minoranze urlanti piuttosto che di dibattito collettivo.
Eppure, quando arriva il momento del voto, le file ai seggi non mancano. L’Italia resta un Paese in cui l’atto del votare mantiene un valore simbolico, quasi rituale, anche per chi durante l’anno non ha mai acceso un talk show né letto una riga di programma politico. Una partecipazione che rischia di essere più automatica che consapevole, più dettata dall’abitudine che dall’informazione.
Gli studiosi dell’Istat avvertono: non è una semplice questione di statistiche. La qualità della democrazia si misura anche da qui, dal rapporto tra cittadini e istituzioni, dalla capacità di alimentare un dialogo vivo e informato. Se questo rapporto si affievolisce, il rischio è che le decisioni restino in mano a pochi e che la maggioranza si limiti a ratificare scelte prese altrove.
In conclusione, i dati fotografano un’Italia sempre più spettatrice e sempre meno protagonista della vita politica. Si spegne la curiosità, si attenua la passione civile, si riduce lo spazio dell’approfondimento. Restano i voti, ogni tanto, e restano i social, a volte. Ma una democrazia che sopravvive solo nel giorno dell’elezione è una democrazia fragile, sospesa sul filo dell’indifferenza.