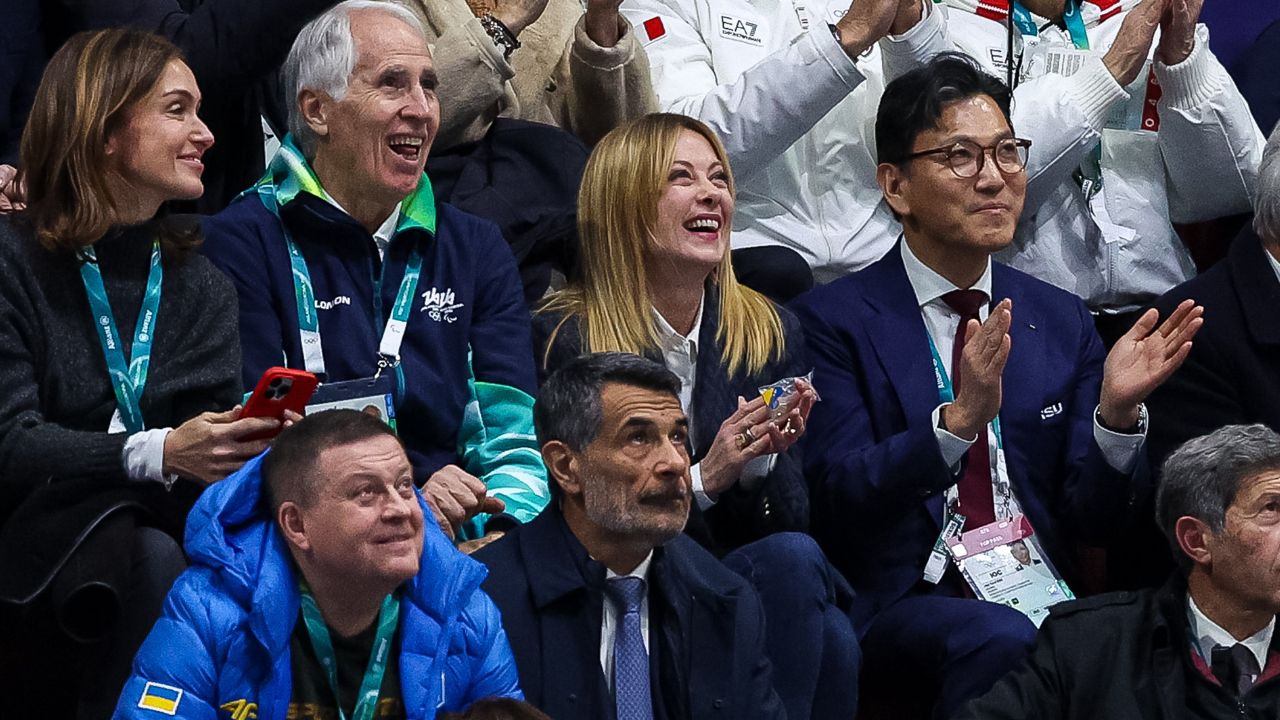Il titolo è di quelli che non ammettono mezze misure: “L’Iran si prepara alla guerra con gli Stati Uniti”. Lo scrive il Wall Street Journal, e lo fa incastrando il pezzo in una narrazione che nelle ultime ore trova eco anche altrove: le rivelazioni di Axios secondo cui Trump “si sta avvicinando” a un grande conflitto contro la Repubblica islamica, e lo stesso clima registrato da CNN e New York Times. Il punto di partenza, però, è paradossale: i colloqui diplomatici a Ginevra avrebbero prodotto progressi, come dichiarato da entrambe le parti. Progressi veri, dicono. Ma non sufficienti per disinnescare davvero l’ipotesi dello scontro.
Il confronto, in questa fase, ruota attorno a due problemi principali, che per Washington sono due porte da chiudere contemporaneamente e per Teheran una sola da tenere aperta. Il primo è la volontà iraniana di limitare il negoziato al solo programma nucleare, lasciando fuori sia il capitolo su missili e armi convenzionali, sia il nodo delle operazioni di destabilizzazione attribuite a gruppi alleati nella regione, a partire da Hezbollah. Il secondo riguarda quanto la Repubblica islamica sia disposta a concedere sul dossier atomico: agli occhi degli Stati Uniti, le aperture finora prospettate non garantirebbero la fine di ogni attività che possa essere finalizzata a costruire armi. E in una trattativa in cui il lessico è fatto di “garanzie”, “ispezioni”, “limiti” e “verifiche”, il dettaglio non è un dettaglio: è la sostanza.
Dentro questo perimetro, il messaggio politico che arriva da Washington è stato riassunto in modo netto dal vice presidente Vance, parlando con Fox: «i colloqui sono andati bene sotto certi aspetti, ma sotto altri è molto chiaro che il presidente ha stabilito alcune linee rosse che gli iraniani non sono ancora disposti a riconoscere e a lavorarci sopra». La frase pesa perché contiene due elementi che, messi insieme, sono benzina in un contesto già saturo: da un lato l’ammissione che qualcosa si muove, dall’altro la conferma che le linee rosse sono già state piantate nel terreno e che, al momento, Teheran non ci sta camminando sopra.
Da qui nasce l’interpretazione più “strategica” della tensione: è possibile che la Casa Bianca stia alzando la pressione per ottenere più concessioni, spingendo gli ayatollah davanti a una minaccia visibile e misurabile. In questo scenario, la parola chiave diventa deterrenza, e la deterrenza prende la forma della potente “Armada” che il Pentagono sta schierando davanti alle coste iraniane. Il rischio, però, è che la dinamica sfugga al controllo proprio perché la pressione non è solo retorica. Se Trump dovesse convincersi che la diplomazia ha raggiunto il suo limite e non esiste più spazio di manovra per un accordo ritenuto accettabile, l’idea evocata è quella di un’azione militare nel giro di poche settimane.
E qui cambia anche il tipo di obiettivo immaginato. Non si parlerebbe più soltanto di un intervento “chirurgico” per distruggere alcune strutture chiave del programma nucleare. L’ipotesi descritta è quella di un’offensiva ampia e prolungata, finalizzata a debilitare il regime fino a farlo cadere, anche sfruttando l’onda di eventuali nuove proteste interne, come quelle represse con la forza nelle settimane scorse. Una prospettiva che, letta da Teheran, non è un’operazione militare: è una minaccia esistenziale.
Secondo il Wall Street Journal, proprio questa percezione starebbe prendendo spazio nella leadership iraniana: la convinzione che la guerra possa diventare inevitabile, anche per lo spiegamento di forze ordinato da Trump. Il quadro operativo citato è robusto e volutamente visibile: l’aggiunta della portaerei Ford accanto alla Lincoln, il trasferimento di altri 50 caccia tra F-35, F-22 e F-16 nella regione, e oltre 150 voli cargo per posizionare armi e munizioni in Medio Oriente. La scelta di rendere “contabile” la pressione militare serve a costruire credibilità. Ma, contemporaneamente, contribuisce ad alimentare la narrativa dell’assedio.
Sul fronte iraniano, la risposta non è solo diplomatica: è organizzativa, militare e psicologica. Il capo del Consiglio per la sicurezza nazionale, Ali Larijani, mette in cornice il concetto: «Abbiamo rivisto a affrontato le nostre debolezze. Se la guerra ci verrà imposta, risponderemo». La guida suprema Khamenei alza ulteriormente il registro, scegliendo un’immagine destinata a circolare: «l’unica arma più potente delle portaerei americane è quella che le manderà in fondo al mare». Due frasi diverse, stesso messaggio: l’Iran vuole apparire pronto, compatto, non ricattabile.
Nel dettaglio, la preparazione descritta passa da una serie di mosse che hanno un obiettivo comune: non farsi decapitare al primo colpo. Il regime avrebbe iniziato a schierare le forze, fortificare i siti nucleari, disperdere e diversificare la catena di comando e, nel frattempo, continuare la repressione del dissenso. La Guardia rivoluzionaria avrebbe rivisto la cosiddetta “difesa a mosaico”, cioè un modello che concede ai comandanti locali autorità decisionale nel caso in cui venissero isolati dal centro. In altre parole: se saltano comunicazioni e vertici, l’apparato deve comunque poter reagire senza paralizzarsi.
C’è poi il cuore geografico della tensione, quello che basta nominare per far cambiare tono a qualsiasi briefing: lo stretto di Hormuz. Le unità navali iraniane lo pattugliano e avrebbero condotto esercitazioni a fuoco non troppo lontano da dove incrocia la portaerei Lincoln al largo dell’Oman. È uno di quei punti in cui una mossa può essere letta come dimostrazione o come provocazione, a seconda del binocolo politico con cui la guardi. E ad aumentare la preoccupazione per un possibile allargamento dello scontro, viene citato anche un elemento esterno: una nave russa attraccata nel porto di Bandar Abbas. Un dettaglio che, in una fase di nervi scoperti, viene pesato più del suo valore immediato.
Sul piano delle capacità, il quadro delineato dal Wall Street Journal insiste sulla quantità e sulla varietà della minaccia: circa 2.000 missili a medio raggio in grado di colpire Israele; numerosi vettori a corto raggio che possono raggiungere basi e navi americane nel Golfo Persico, comprese quelle in Qatar e Barhein; e anche armi sottomarine. Parallelamente, i siti nucleari di Isfahan e la montagna Pickaxe sarebbero stati fortificati, mentre la contraerea ha condotto esercitazioni e le autorità di Teheran avrebbero individuato stazioni della metropolitana e altri spazi da usare come rifugi in caso di bombardamenti. I Pasdaran, infine, avrebbero creato circa cento punti di osservazione per bloccare proteste o raid, segno che l’idea di conflitto si intreccia con la paura di un fronte interno.
In questo scenario, la sensazione è che i due piani stiano correndo in parallelo: da una parte la diplomazia che cerca uno spiraglio, dall’altra le due macchine militari che si comportano come se quello spiraglio potesse chiudersi da un momento all’altro. Ed è proprio questa sovrapposizione, fatta di negoziati e portaerei, di linee rosse e missili, a rendere la fase più instabile: perché quando tutti si preparano al peggio, diventa più facile convincersi che il peggio sia già iniziato.