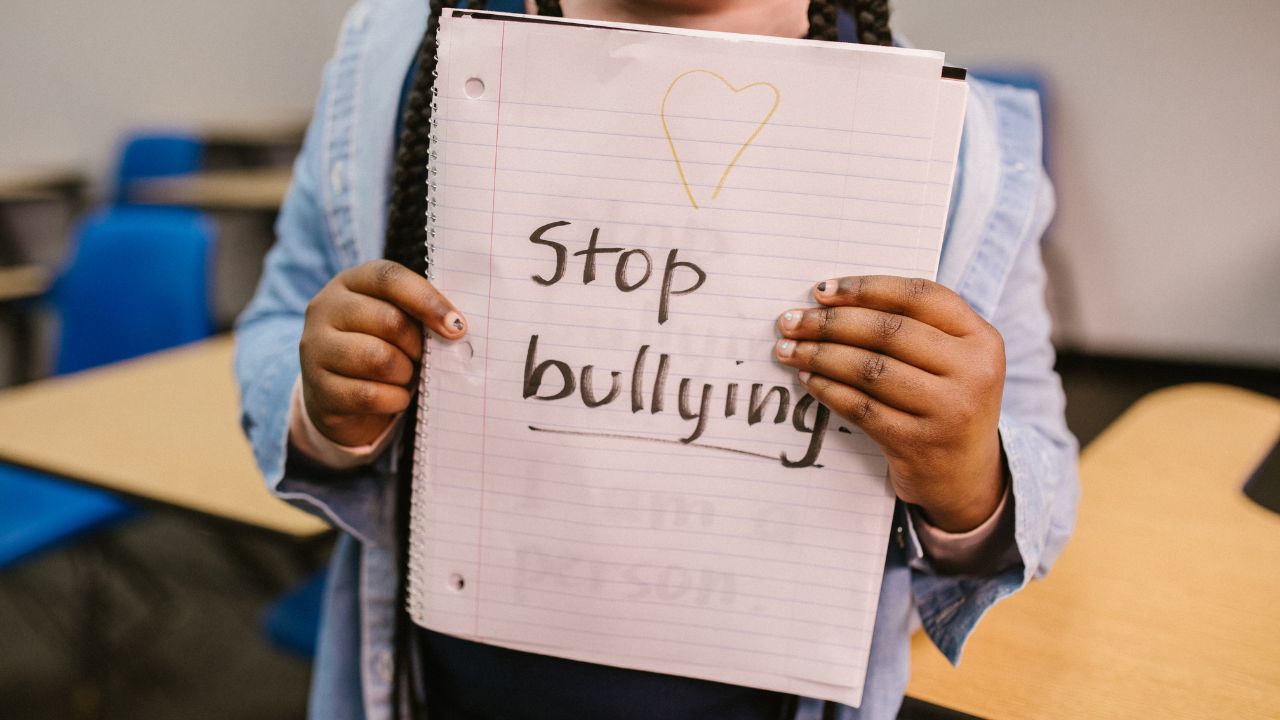Uno vuole smontarla, l’altro ampliarla. Sulle strade italiane, tra pattuglie miste e presidi davanti ai siti sensibili, lo scontro è tutto interno al centrodestra. Guido Crosetto, oggi ministro della Difesa, ha aperto alla possibilità di chiudere l’operazione “Strade sicure” e riportare i militari “al loro lavoro originario”. Una linea opposta a quella di Ignazio La Russa, che da ministro la promosse nel 2008 e che adesso, dal vertice di Palazzo Madama, la difende pubblicamente.
“Mi spiace contraddire il mio amico Crosetto,” premette la seconda carica dello Stato, “ma eliminare ‘Strade sicure’, che istituimmo insieme quando ero alla Difesa, sarebbe un errore.” Tono fermo, memoria storica puntellata dal riferimento alle origini: “È risultata negli anni tra i provvedimenti più apprezzati dall’opinione pubblica, non solo dal centrodestra.” Poi l’avvertimento: “Se Crosetto vorrà testare cittadini, sindaci e forze di maggioranza eviterà di dare un’inutile pedata a chi mette la sicurezza tra le priorità.”
È il segnale plastico di un’eterna faglia nella destra italiana: rigore, ordine e percezione di sicurezza da un lato, riorganizzazione degli impieghi e ridefinizione del ruolo delle Forze Armate dall’altro. Crosetto, che guida via XX Settembre con l’obiettivo dichiarato di alleggerire i compiti “civili” dei militari e rafforzarne la preparazione operativa, ritiene superata la stagione dell’impiego prolungato nelle città. La Russa, storico fautore del modello, teme invece un passo indietro sul piano simbolico e operativo.
Ma che cosa significa esattamente “Strade sicure” oggi? L’operazione entra nel diciassettesimo anno di attività continuativa, nata il 4 agosto 2008 con la legge 125 e confermata dalle proroghe successive, inclusa quella del dicembre 2020. Prevede l’impiego di un contingente dell’Esercito in concorso alla polizia per la sicurezza urbana, il controllo del territorio e la vigilanza dei siti sensibili, dalle stazioni ferroviarie ai luoghi di culto, dagli aeroporti ai palazzi istituzionali.
Al momento, sono oltre 6.600 i militari dispiegati in 58 province, impegnati a presidiare circa mille siti. Duecento unità operano nella “Terra dei fuochi”, mentre circa 800 uomini sono destinati al dispositivo “stazioni sicure” che copre 21 scali ferroviari nelle principali città italiane, da Milano a Napoli, da Venezia a Palermo. Un dispositivo imponente che rappresenta, numeri alla mano, la missione più onerosa per le Forze Armate in termini di personale e mezzi.
La sua storia coincide con le esigenze del Paese negli ultimi quindici anni. Dall’Expo 2015 al Giubileo della Misericordia, passando per i vertici G7 e G20, fino alle emergenze sismiche e alla pandemia. In ogni fase, i militari hanno affiancato le forze di polizia con compiti di sorveglianza e contenimento, diventando parte del paesaggio urbano di molte città.
Non a caso, l’operazione vede ora scendere in campo anche il Viminale. Il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ha rassicurato sul mantenimento del dispositivo, mentre dalla Lega arriva un contrattacco diretto. “Altro che tagliare i militari,” osserva il vicecapogruppo Igor Iezzi, “andrebbero aumentati di almeno mille unità. È un presidio prezioso per tutto il territorio.”
La partita resta aperta. Tra il desiderio di ridisegnare il perimetro dell’impiego militare e la spinta a conservarne la presenza nelle piazze, il confronto appare tutt’altro che simbolico: riguarda l’idea stessa di sicurezza urbana in Italia e il confine, sempre sottile, tra emergenza e normalità.