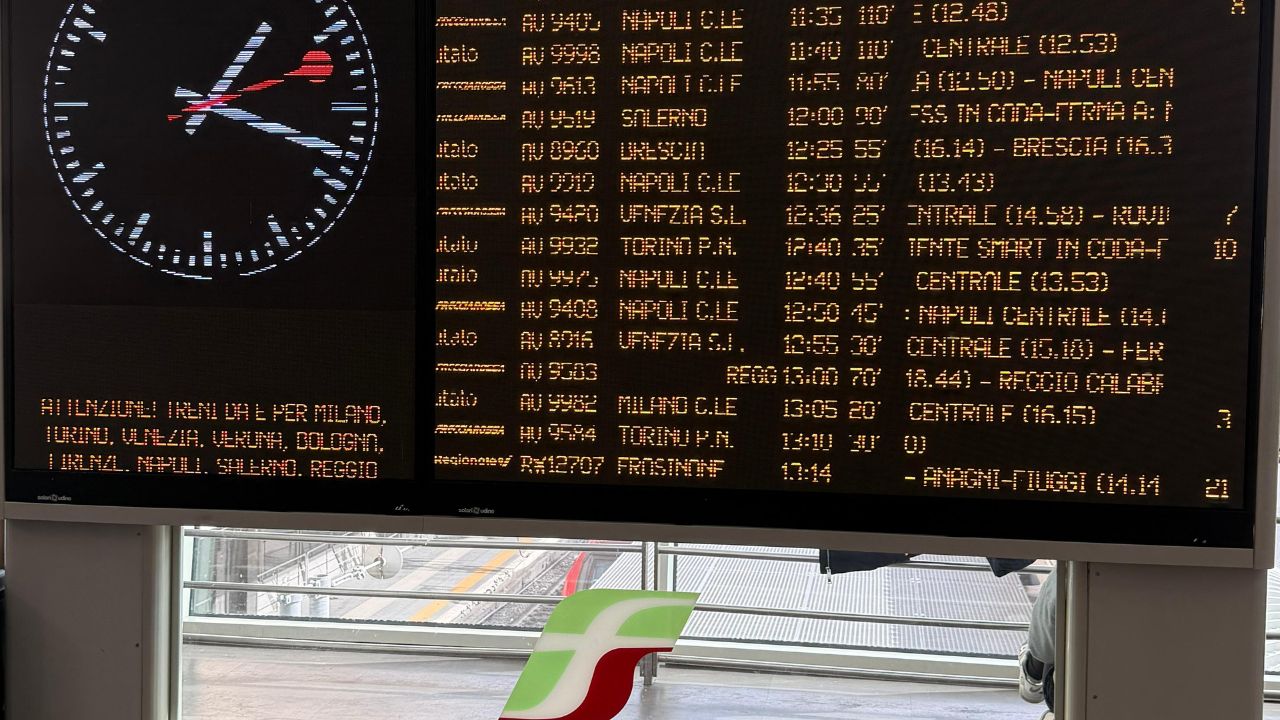Donald Trump l’ha chiamata sicurezza nazionale, l’ha venduta come forza negoziale, l’ha difesa come una leva per “riallineare” i Paesi alle “nostre più forti volontà”. Ma adesso il presidente sembra pronto a fare quello che, in politica, si fa quando l’aria cambia: ridurre il volume e cercare una via d’uscita. Il Financial Times scrive che Trump “intende ridurre i dazi sui prodotti in metallo e alluminio”. Non un dettaglio tecnico: un segnale. E soprattutto un segnale che arriva mentre negli Stati Uniti la parola che torna più spesso non è “industria”, ma “costo della vita”.
Il quotidiano economico colloca “l’ultimo ammorbidimento” in un contesto di “persistente ansia degli elettori riguardo all’accessibilità economica”. Traduzione: l’inflazione percepita, le spese quotidiane, la sensazione di un carrello che pesa più del solito. E quando si avvicinano le elezioni di midterm di novembre, anche la retorica muscolare tende a diventare più elastica. Soprattutto se, nel frattempo, il Congresso manda segnali che somigliano a uno schiaffo.
Il colpo, questa volta, arriva da una frattura dentro il partito. Mercoledì sera la Camera ha approvato una mozione contro l’imposizione di misure doganali al Canada: 219 a 211. Un voto reso possibile, dopo un passaggio procedurale, dal sostegno di tre deputati repubblicani. Il punto politico non è soltanto il numero, ma il precedente: una contestazione esplicita dell’uso dell’“emergenza nazionale” come scorciatoia per imporre tariffe bypassando il Congresso. È su quella scorciatoia che l’Amministrazione aveva giustificato le misure verso Ottawa, agganciandole al tema del fentanyl e del contrabbando ai confini.
Trump non ha aspettato l’esito finale per reagire: ha sfogato la rabbia contro i “traditori” e via Truth ha accusato i dissidenti di aiutare gli avversari alle primarie. Poi il cuore della sua difesa, in una frase che è quasi un manifesto: «Le Tariffs ci hanno dato – ha scritto – una grande sicurezza nazionale perché al solo menzionare la parola i Paesi si sono allineati alle nostre più forti volontà». È il Trump classico: l’idea che la tariffa non sia una tassa, ma un’arma. Il problema è che, quando l’arma la senti nel portafogli, il consenso smette di essere un automatismo.
La rivolta, raccontata come la più significativa espressione di dissenso interno su una policy dell’Amministrazione, rischiava persino di essere più ampia: prima del voto, secondo la ricostruzione riportata, erano “almeno trenta” i deputati repubblicani pronti a schierarsi con i democratici. Il lavoro di Mike Johnson, lo Speaker, avrebbe contenuto i danni. Ma il dato politico resta: a nove mesi dal midterm, le crepe tra deputati, base e Casa Bianca “si stanno allargando”. E quando un partito comincia a fare i conti con le crepe, il leader comincia a fare i conti con la realtà.
La realtà, qui, si misura in percentuali e in conti finali. Un sondaggio del Pew Research Center citato nel materiale indica che il 60% degli americani è contrario al rafforzamento delle tariffe, mentre il 37% appoggia la linea del presidente. Una maggioranza netta, che si spiega con un’intuizione semplice: il prezzo non lo pagano “gli altri”, lo paghi tu. E su questo arrivano numeri ancora più esplosivi, perché colpiscono il racconto alla base della strategia trumpiana.
Uno studio realizzato “in collaborazione fra New York Fed e la Columbia University” avrebbe evidenziato che tra febbraio e novembre scorsi l’80% del peso dei costi dei dazi è ricaduto sugli americani. Restringendo il periodo all’ingresso delle tariffe reciproche, cioè all’inizio dell’estate, quel peso arriverebbe al 94%. Trump contesta quei calcoli e in un commento pubblicato il 30 gennaio sul Wall Street Journal sostiene che la quota maggiore di spese è sostenuta dai produttori stranieri e dai mediatori. Ma nel materiale si cita anche un altro numero, ancora più brutale: il Congressional Budget Office ritiene che il 95% dei costi ricada sugli americani.
È su questo terreno che l’“indietro tutta” diventa plausibile. Perché se la battaglia dei dazi nasce come promessa di reindustrializzazione e posti di lavoro, la verifica passa dai risultati. E lì, almeno per ora, i conti non sono lineari: la produzione industriale sarebbe salita in un anno del 2,5%, ma resterebbe inferiore alla media registrata sotto Biden. Un aumento, insomma, che non basta a chiudere la discussione, soprattutto se il prezzo politico è un elettorato inquieto e un partito che inizia a votare contro.
In questo quadro, l’idea di ridurre i dazi su metallo e alluminio appare come un tentativo di abbassare la temperatura senza sconfessare la narrativa. Non un dietrofront dichiarato, ma un “ammorbidimento” presentabile come aggiustamento tecnico. Un modo per limitare l’impatto sui consumatori e sulle filiere, senza rinunciare del tutto alla postura negoziale. E anche un messaggio al Congresso: se mi ostacolate, posso ancora muovermi; se mi lasciate spazio, posso gestire la marcia in modo controllato.
Resta l’immagine plastica di questa stagione: un cappello “Make America Great Again” “made in China”, citato come simbolo della contraddizione. È la fotografia di una guerra commerciale raccontata come patriottica ma intrecciata, per forza di cose, a una globalizzazione che non si spegne con uno slogan. E in mezzo, un presidente che sente il rumore dei numeri: quelli dei sondaggi, quelli dei voti in Aula, quelli dello scontrino alla cassa. E decide che, almeno per una volta, conviene abbassare i dazi prima che siano i dazi ad abbassare lui.