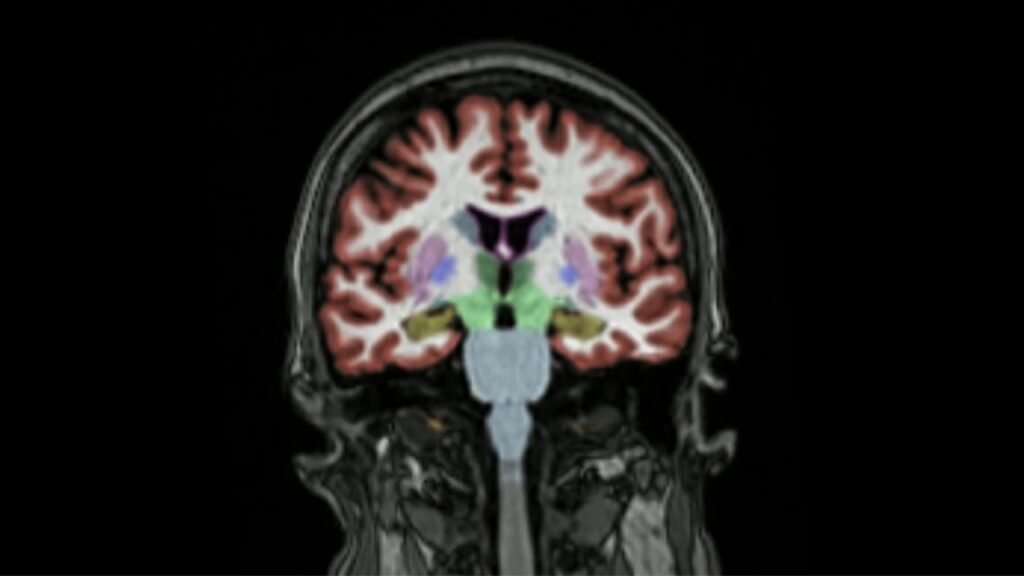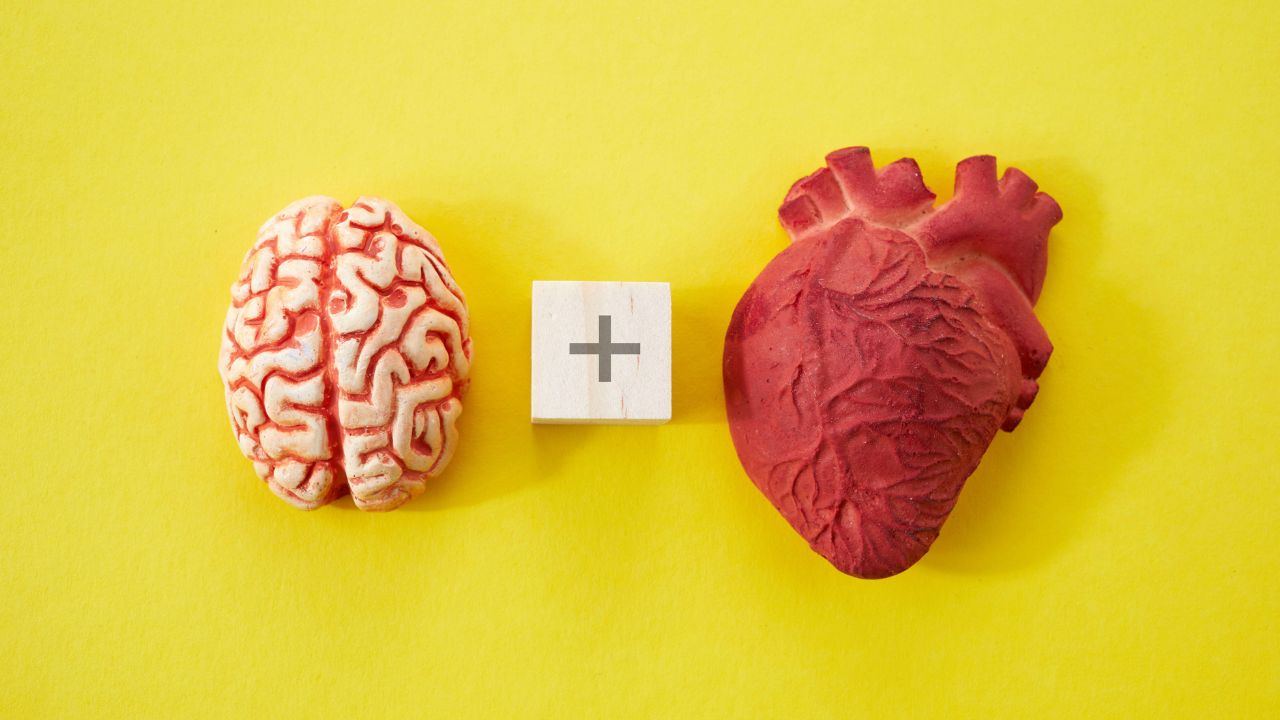Nel Comando, romanzo di Rocco Carbone uscito nel 1996 e da poco ripubblicato da Rubbettino, uno dei protagonisti è Logoteta, un sinologo di fama internazionale. Il professore, molto anziano e malato di Alzheimer, rivela il motivo per cui, a un certo punto della sua vita, ha deciso di occuparsi di sinologia, la scienza che studia la lingua, la storia e la cultura del mondo cinese antico.
Si tratta, spiega l’insigne studioso, di una disciplina in cui si è sempre in una condizione di principianti perché dopo cinquant’anni ci si sente ancora apprendisti e questo vuol dire restare giovani: «La giovinezza del nostro cervello […] dipende dalla capacità di imparare, di apprendere nuove cose. Quando smettiamo di farlo, smettiamo anche di essere giovani». È così che Logoteta chiarisce come la disposizione alla ricerca avvicini la condizione dello studioso a quella della gioventù, aggiungendo poi che «per imparare, bisogna avere anche molta umiltà. E non tutti ce l’hanno».
Appare significativa questa definizione di Carbone, soprattutto alla luce del fatto che lo scrittore calabrese, scomparso tragicamente nel 2008, aveva conseguito un dottorato alla Sorbonne di Parigi e dedicato i suoi primi lavori allo studio e alla critica della letteratura. Carbone, nel corso del romanzo, sottolinea ancora la vicinanza dei comportamenti di Logoteta a quelli di un bambino, un po’ per gli effetti della malattia degenerativa che lo affligge, un po’ perché la correlazione assume in lui un carattere particolare.
L’uomo, infatti, non regredisce «verso una forma indefinita di infanzia», ma rivive, con grande precisione, situazioni ed episodi vissuti durante i primi anni di vita. Egli non ricorda semplicemente il giorno in cui la madre lo aveva accompagnato nel bosco a fare una passeggiata. Logoteta è in quel bosco, la sua stanza dì ospedale diventa quel bosco, la sedia diventa un albero, appoggiato al quale è in grado di sentire l’odore della resina e la superficie ruvida della corteccia.
È davvero efficace l’immagine che Carbone usa per trasmettere “en artiste” un aspetto importante del lavoro dello studioso: come se, grazie al suo aiuto, si potesse conoscere qualcosa di cui magari abbiamo abbiamo avuto una qualche contezza in un momento della nostra infanzia, ma dalla quale, senza l’apporto e la sensibilità del diligente ricercatore, saremmo rimasti per sempre esclusi.
di Alessandro Gaudio