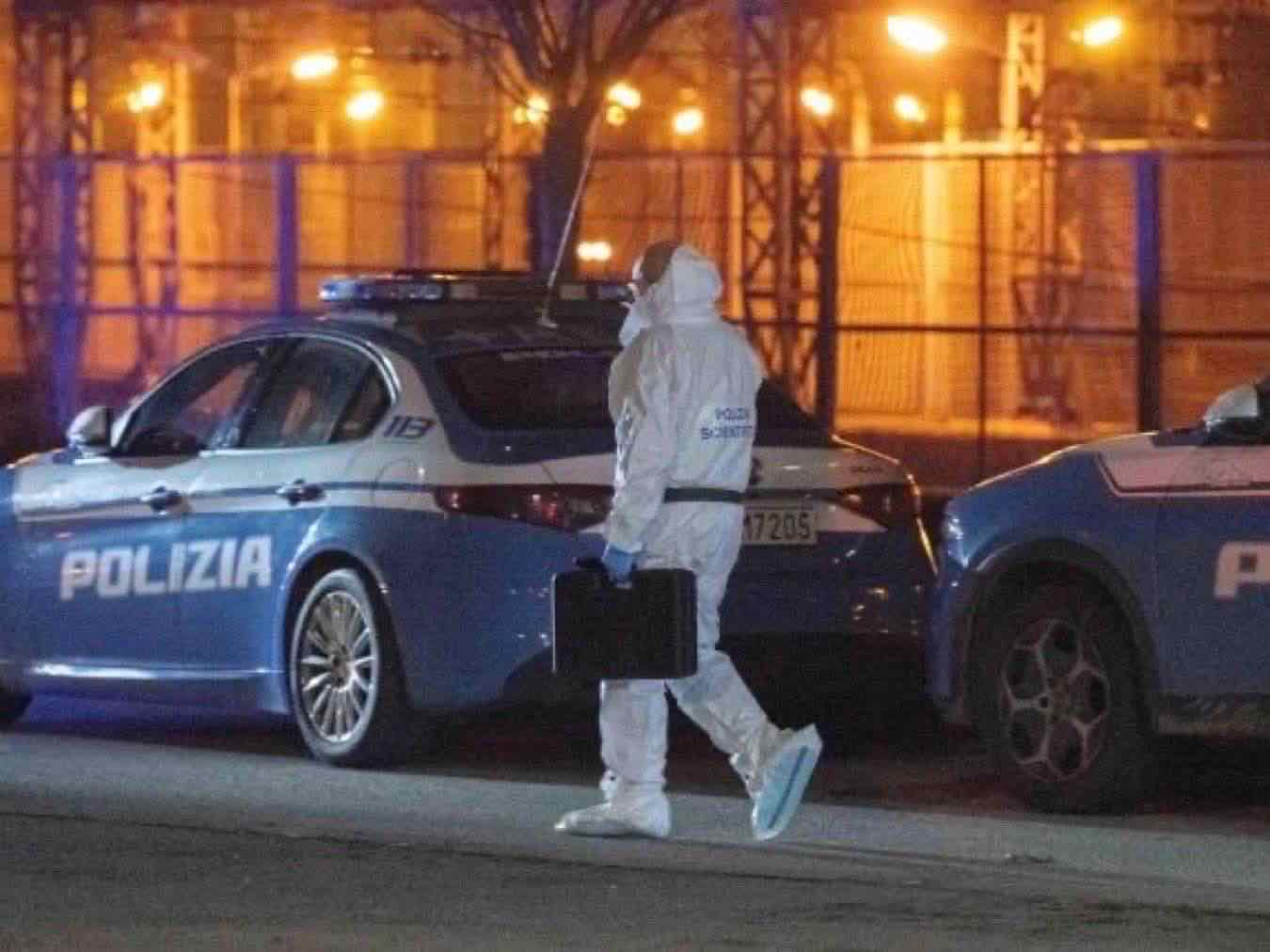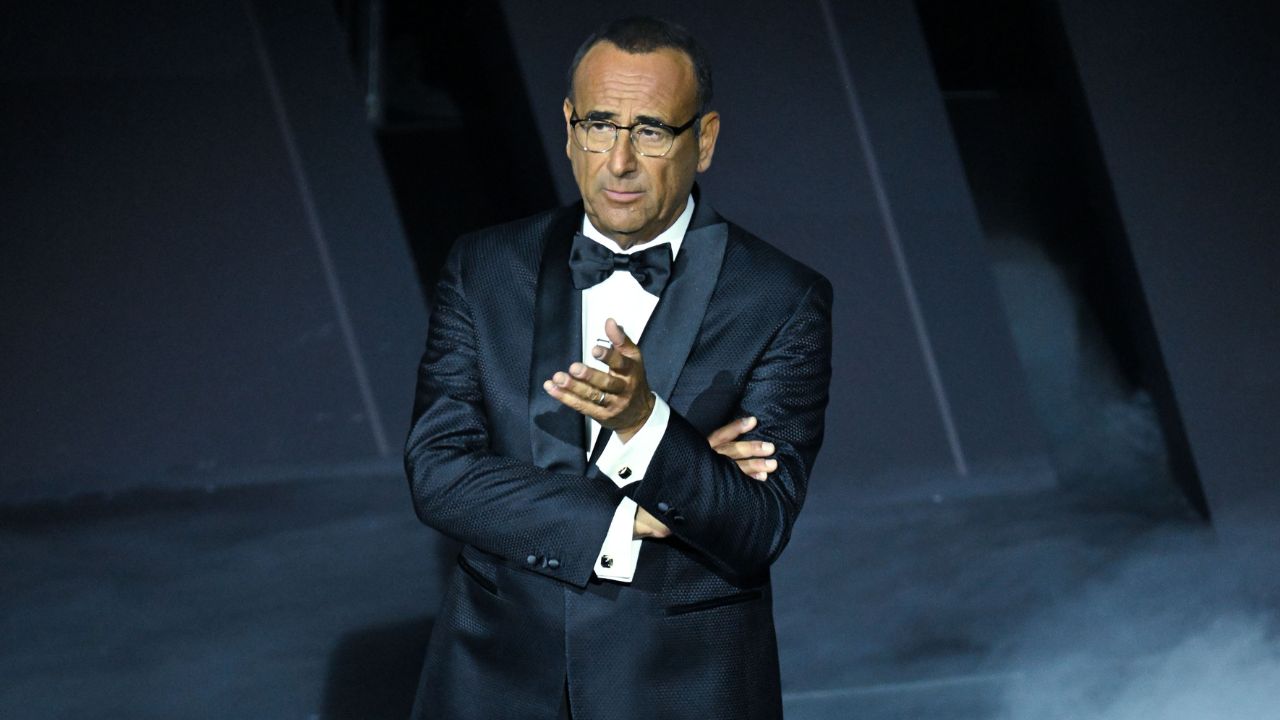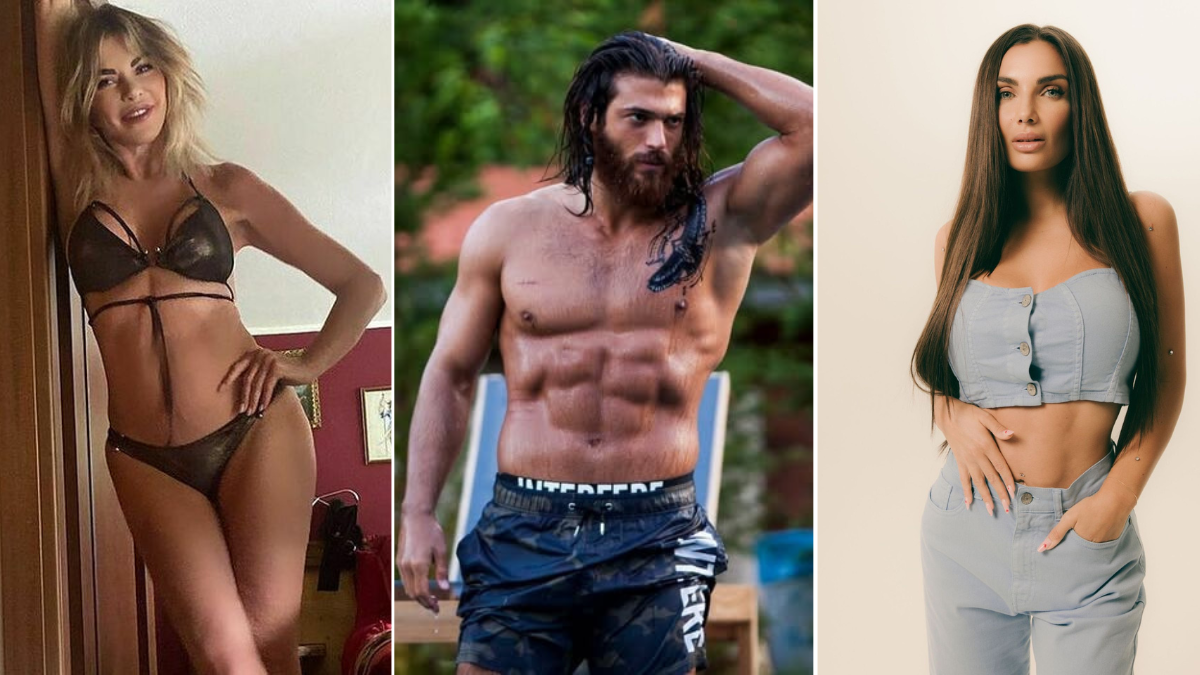Il dato che apre il Rapporto Svimez 2025 sorprende per dimensioni: tra il 2021 e il 2024 il Mezzogiorno ha registrato una crescita del Pil pari all’8,5 per cento, contro il 5,8 del Centro-Nord. È un divario che non si vedeva da tempo e che si riflette anche nella dinamica dell’occupazione, aumentata dell’8 per cento. Oltre un terzo degli 1,4 milioni di nuovi posti di lavoro creati nel Paese si trova al Sud, un risultato legato in larga parte alla spinta del Pnrr e agli investimenti pubblici. Eppure questo scenario non basta a trattenere i giovani. In quello stesso quadriennio, quasi mezzo milione di posti di lavoro è nato nel Mezzogiorno, ma 175 mila giovani hanno deciso di andare via. È la “doppia emigrazione” che Svimez identifica come nodo strutturale: prima verso il Centro-Nord, poi sempre più verso l’estero, spesso senza ritorno.
Per raccontare questa contraddizione, il direttore Luca Bianchi sceglie l’immagine di Gaetano, il protagonista di “Ricomincio da tre”, interpretato da Massimo Troisi. Un giovane che parte non perché lo desideri, ma perché non gli viene data la possibilità di restare. È la stessa dinamica che oggi, pur in un Sud che cresce, continua ad allontanare i ragazzi più qualificati. «Le analisi elaborate dalla Associazione – osserva il presidente della Repubblica Sergio Mattarella – sono occasione preziosa per individuare linee di sviluppo per la comunità nazionale, significativo contributo al consolidamento della coesione». Il monito istituzionale amplia lo sguardo: non si tratta soltanto di un’emergenza meridionale, ma di un rischio che investe l’intero Paese.
Il Rapporto fotografa un paradosso evidente. Cresce l’occupazione, ma cresce anche la quota di lavori poveri. La caduta del potere d’acquisto è stata più marcata al Sud rispetto al resto d’Italia: –10,2 per cento contro –8,2 del Centro-Nord. I lavoratori poveri sono 2,4 milioni, e metà vive nelle regioni meridionali. Tra il 2023 e il 2024, altri 120 mila occupati a basso reddito si sono aggiunti al totale nazionale, di cui 60 mila proprio nel Mezzogiorno. Avere un lavoro non significa più uscire dalla vulnerabilità: salari bassi, contratti fragili, part-time involontari e nuclei familiari con un solo percettore consolidano la precarietà.
La spinta del Pnrr, che ha destinato al Sud 27 miliardi di opere pubbliche, ha dato sollievo ai territori, e i Comuni hanno accelerato l’esecuzione dei cantieri. Tre progetti su quattro sono in fase esecutiva, in linea con il Centro-Nord. Ma questo non si traduce immediatamente in occupazione stabile. Molti nuovi impieghi riguardano infatti la costruzione di infrastrutture, lavori che per loro natura hanno un orizzonte temporaneo. Sei giovani su dieci assunti nel 2021-2024 sono laureati, un dato che supera quello del resto del Paese. Ma la prima porta d’ingresso nel mercato resta quella del turismo: oltre un terzo dei nuovi addetti under 35 si colloca nella ristorazione e nell’accoglienza, settori a bassa specializzazione e bassa retribuzione. Crescono sì i giovani nei servizi Ict e nella pubblica amministrazione, ma la massa delle opportunità rimane ancorata ai comparti tradizionali.
Il nodo decisivo è la perdita di capitale umano. Svimez calcola che la migrazione dei laureati costi al Sud circa otto miliardi di euro ogni anno. È un drenaggio che compromette la possibilità stessa di sviluppo: la formazione universitaria, finanziata anche con risorse pubbliche, produce risultati di cui spesso beneficiano altri territori. Il bilancio dal 2000 al 2024 è netto: il Mezzogiorno ha perso 32 miliardi di capitale umano, mentre il Centro-Nord ne ha guadagnati ottanta. Le università meridionali stanno diventando più attrattive nella fase degli studi, ma dopo la laurea il sistema non riesce a trattenere i giovani né ad assorbirne le competenze. Ogni anno quarantamila under 35 si trasferiscono al Centro-Nord, mentre 37 mila laureati italiani emigrano all’estero. La crisi abitativa aggrava la fuga: il diritto alla casa diventa un’emergenza sociale per molti ragazzi.
Guardando al futuro, il Rapporto indica alcune strade. La revisione del Pnrr offre uno spazio per attrarre investimenti in tecnologie di frontiera: digitalizzazione avanzata, filiere energetiche, progetti dual use, decarbonizzazione industriale, Ipcei strategici. Le grandi imprese, sostiene Svimez, possono essere un fattore chiave: rappresentano il 76 per cento dell’export manifatturiero nazionale e generano esternalità lungo le filiere. Nel Sud gli addetti dei grandi impianti sono quasi seicentomila, con 46 miliardi di valore aggiunto. Nei comparti più tecnologici il peso dei grandi stabilimenti supera il cinquanta per cento, molto più che nel resto d’Italia. È un segnale che indica una potenzialità ancora inespressa.
In questa direzione si muove anche la Zes Unica, pensata per accelerare gli investimenti con autorizzazioni rapide. Tra marzo 2024 e novembre 2025 sono state rilasciate 865 autorizzazioni, per oltre 3,7 miliardi di euro. I tempi burocratici si sono dimezzati, da 98 a 54 giorni. Puglia, Campania e Sicilia mostrano la reattività più alta, mentre Sardegna, Abruzzo e Basilicata restano indietro. Gli interventi riflettono la tradizionale struttura produttiva del Sud: agroindustria in testa, seguita dall’automotive. Ma crescono anche elettronica, Ict e cleantech, segnali di una possibile transizione verso filiere di qualità.
Restare, però, è anche una scelta culturale. Negli ultimi anni si è formato un movimento dal basso: quarantacinque organizzazioni siciliane hanno firmato il “Patto per restare”, nato dal progetto “Questa è la mia terra” del Centro Studi Giuseppe Gatì. Festival, assemblee e cantieri territoriali hanno prodotto idee e proposte per contrastare lo spopolamento. È un tentativo di trasformare la fuga in radicamento, di immaginare un Sud dove “freedom to move” non escluda il “right to stay”.