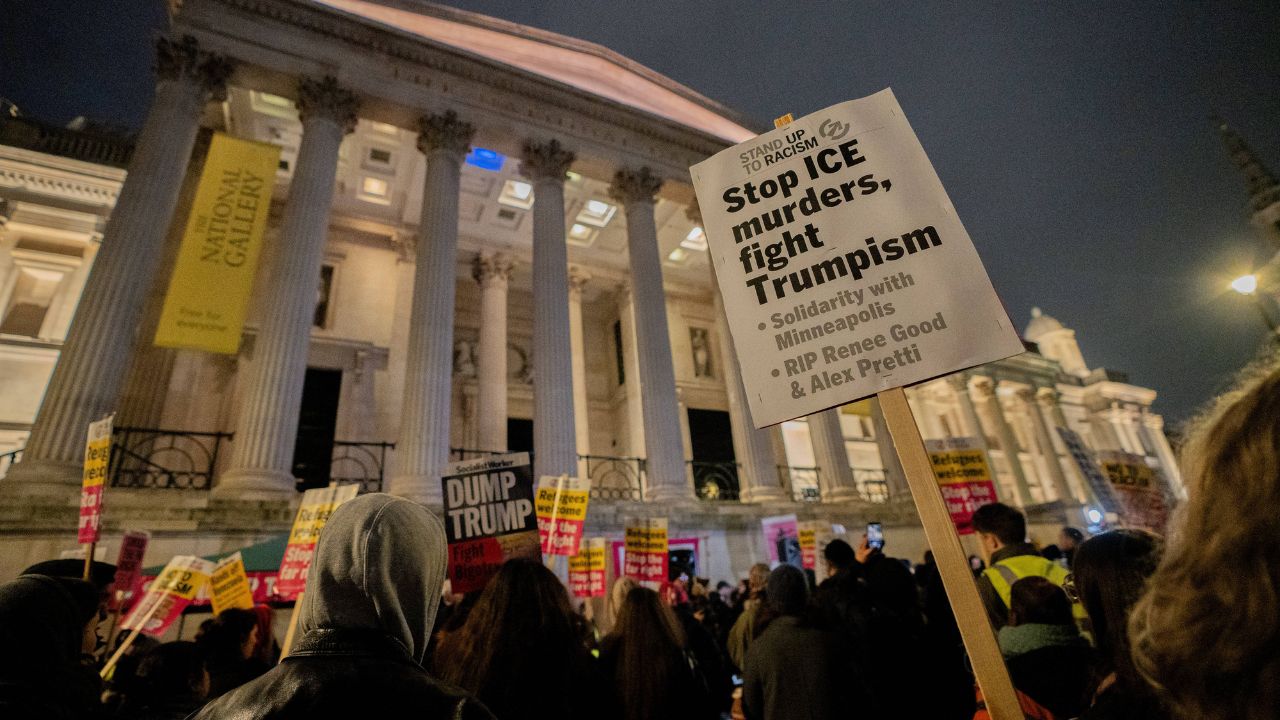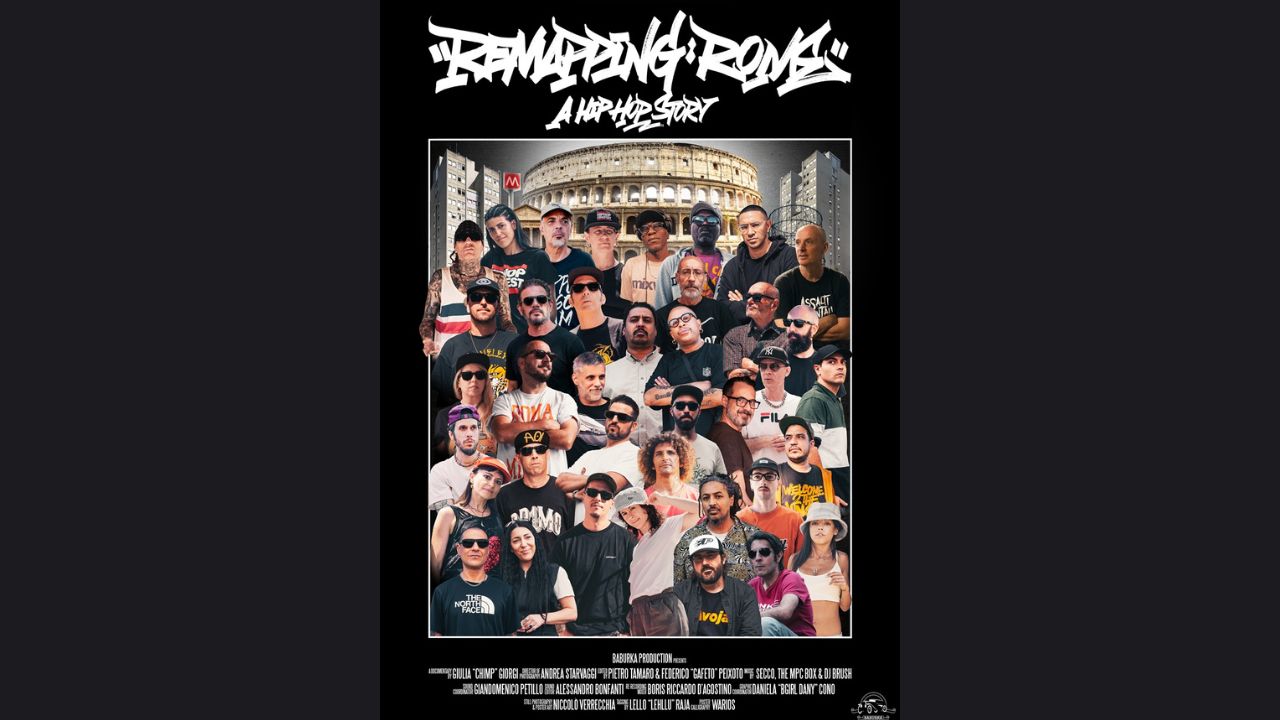Vi è una sorta di aura sacrale che circonda la figura di Goffredo Mameli, il poeta che, appena ventenne, consegnò alla nascente Patria italiana una pagina destinata all’eternità. Quasi sospinto da un fremito profetico, egli scolpì, poeticamente, nel 1847 “Il Canto degli Italiani”, testo che sarebbe poi passato alla storia come Inno di Mameli, e che successivamente sarebbe assurto a dignità di inno nazionale repubblicano. Ma quel 1847, denso di febbrile fermento, fu già sufficiente perché la poesia circolasse con l’impeto di una chiamata alle armi spirituale, accolta come voce della gioventù ardente che sognava la libertà.
Mameli, adolescente di genio, non compose quei versi su commissione ufficiale: essi sgorgarono, piuttosto, dal crogiolo della passione patriottica che infiammava i salotti e le piazze di Genova, laddove l’eco delle rivoluzioni europee e delle aspirazioni risorgimentali risuonava come promessa e minaccia insieme. La sua vena poetica, nutrita di ideali mazziniani e di fervore repubblicano, si fece canto collettivo. Lo scritto nacque quale appello vibrante, un testo concepito per scuotere e trascinare, non per addormentare nell’eleganza dell’idillio lirico.
La musica fu commissionata a Michele Novaro, cantante lirico, compositore, direttore d’orchestra e patriota italiano. Impiegò non più di un mese per comporre la musica dell’inno di Mameli.
Qui emerge il nodo ardito del nostro interrogativo: e se a musicare quei versi fosse stato Giuseppe Verdi (1813-1901)? L’Italia, in quegli anni, vibrava già del nome verdiano, sinonimo di epicità e catarsi. Verdi era l’alfiere dell’arte nazionale, colui che sapeva tramutare l’ansia civile in melodia ascendente, in accordi che parevano brandire la spada dell’indipendenza. I suoi cori patriottici — dal “Va’ pensiero” (dal Nabucco) a “Si ridesti il leon di Castiglia” (da Ernani) — agitavano l’anima popolare con potenza teatrale, fiammeggiando come vessilli morali su scene liriche che travalicavano il teatro per diventare rito civico.
Eppure, Goffredo Mameli, o forse il destino, non si rivolse a lui. La musica fu affidata a Michele Novaro, figura colta e appassionata, ma lungi dall’essere un titano del repertorio. Perché mai? Verrebbe da supporre che la scelta non fosse dettata da sfiducia bensì da circostanza: Mameli non cercava allora un “autore ufficiale”, ma un complice immediato dell’ardore politico; egli desiderava un canto che si propagasse rapido come grido di piazza, non come solenne manifesto da teatro d’opera. L’arte verdiana, sublime e vasta, sarebbe forse apparsa troppo monumentale, troppo “imperiale” per l’urgenza della chiamata in armi.

Non era ancora il tempo dell’inno istituzionale: era il tempo del canto di battaglia. Il popolo, non la platea, doveva essere il primo interprete. Il pentagramma di Novaro, pur semplice, aderì alla funzione originaria: marcia incalzante, ritmo quasi tambureggiante, vocazione coral-popolare più che lirico-scenica, come sarebbe stata una composizione verdiana.
Ma se davvero Verdi avesse posato il suo tocco adamantino su quelle parole “Stringiamci a coorte! Siam pronti alla morte!” possiamo immaginare un inno diverso, forse più ampio nella struttura, più drammatico nell’orchestrazione, una maestà sonora capace di rivaleggiare con gli inni romantici europei. La sua mano, che sapeva far vibrare l’orgoglio nazionale sul crinale tra tragedia e apoteosi, avrebbe costruito un monumento sinfonico degno dei fasti romani che Mameli evocava nei versi. La voce dell’Italia nascente sarebbe esplosa non come luminoso grido giovanile, ma come tuono orchestrale d’epopea: l’Inno avrebbe assunto il peso della Storia ancor prima che la Storia lo riconoscesse.
Tuttavia, forse, proprio la scelta di non affidarsi a Verdi salvò la natura originaria del canto: non arte nobile per pochi, ma fuoco sacro per molti. L’inno sorse dalla strada e alle strade tornò; non nacque aristocratico, ma popolare; non fu monumento, ma miccia. Verdi, essendo già allora monumento in fieri, avrebbe rischiato di mutarne la stoffa, sublimandolo ma, forse, raffreddandolo.
Così, oggi, possiamo soltanto indulgere nella fantasia storica: un Inno di Mameli musicato da Verdi sarebbe stato, con ogni probabilità, titanico e solenne, una partitura dal piglio drammatico e dalla melodia alta, dotata di una nobiltà sonora degna dell’Aida o del Nabucco. Avrebbe sollevato l’Italia come una colonna di luce, sì, ma forse non l’avrebbe incendiata come volle invece la breve vita del giovane poeta-martire, che cadde a ventun anni durante la difesa della Repubblica Romana.
E allora, nel gioco delle ipotesi, possiamo riconoscere la verità più sottile: l’inno d’Italia nacque non come si sarebbe dovuto secondo le regole dell’arte, ma come doveva secondo le leggi della Storia. Verdi venne poi, come garante dell’immortalità artistica della patria. Mameli e Novaro, in quell’alba di fervore, furono invece i veri autori della sua nascita. E, forse, è giusto che sia stato così.
di Ernesto Mastroianni