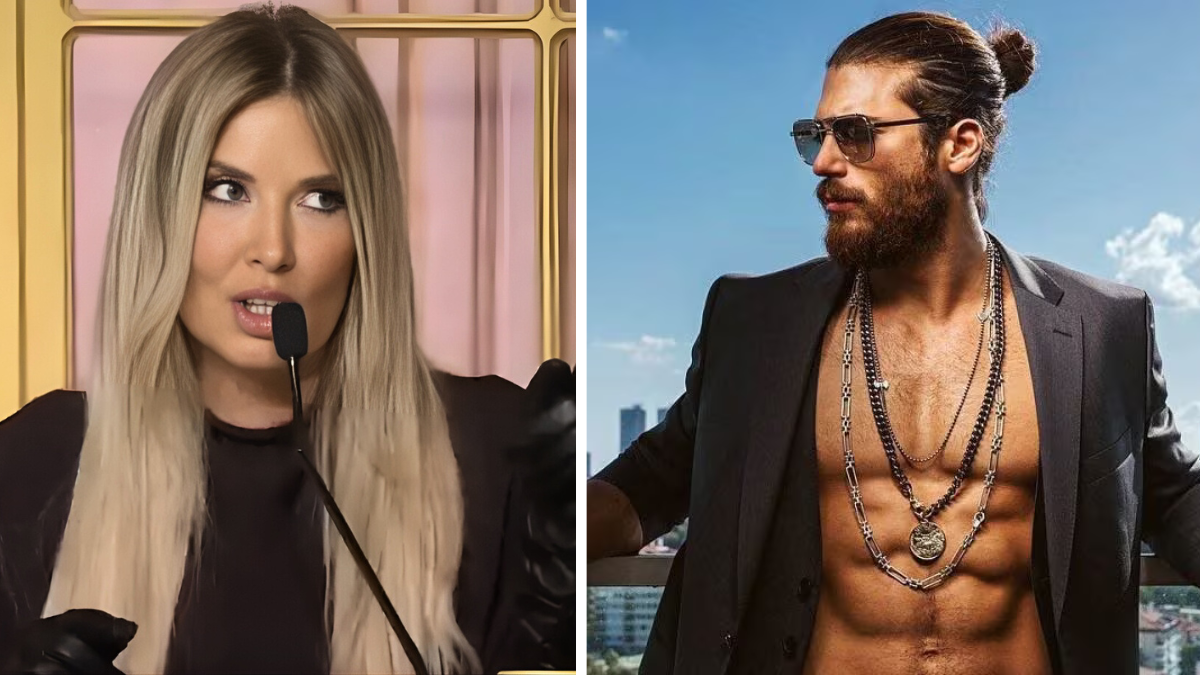In queste settimane (anzi, in questi lunghi mesi che sembrano anni spesi in un crepitio di guerra continuo), Gaza è diventata l’epicentro di un dolore che squarcia il cielo e prosciuga ogni speranza. Non è solo guerra: è un inno alla desolazione, alla carne spezzata, alle urla mute che si perdono nella polvere. Le testimonianze dirette sono tante e sono veramente troppo strazianti. Alcune ti lasciano un nodo di dolore in gola. Ti spezzano il fiato. Ti recidono il cuore e l’anima.
Mahmoud, sessantaquattro anni, padre di sette figli e tre figlie, residente nel campo profughi di Jabaliya, racconta che la sua casa, un anonimo edificio di cinque piani che avrebbe dovuto essere rifugio, è diventata una camera della morte. Ha perso i figli, il genero, i nipoti. Ha visto la sua famiglia dilaniata da un attacco. Ha visto i corpi smembrati, i frammenti di ossa e sogni. E poi l’ospedale: Al-Shifa, l’Ospedale Indonesiano. La violenza arrivava fino ai corridoi dove si suppone che la fragile dignità umana ancora sopravviva.
Altre testimonianze, raccolte da Amnesty International, parlano di fame deliberata, di fame come arma: bambini che deperiscono, uomini e donne che implorano acqua, medicine, un farmaco, un litro di latte. Di civili che muoiono non per ciò che hanno fatto, ma per ciò che non hanno. Perché la dignità è negata. Perché la sopravvivenza è resa impossibile.
Poi si affacciano testimoni sconcertanti: ufficiali che ammettono che la maggior parte di quelli che vengono dichiarati “terroristi” sono in realtà civili. Persone che forse non avrebbero mai varcato quella linea invisibile tracciata da qualcun altro, ma che vi sono incappate — nella casa sbagliata, nella via sbagliata, nell’ora sbagliata — e sono diventati vittime di una logica che non ha volto.
C’è chi è rimasto schiacciato tra le macerie della propria casa, chi è stato costretto a lasciare ogni cosa, chi vaga sotto polvere, chi giace ferito, chi aspetta senza pane, chi piange i morti e non osa sperare nei vivi. In tutta questa distruzione, si leva la voce della coscienza: la flottiglia.
La flottiglia per Gaza è partita come un atto di pura ostinazione umana contro l’indifferenza: imbarcazioni leggere, fragili, che hanno sfidato il mare e le minacce pur di consegnare aiuti e testimoniare la necessità di spezzare l’assedio. Quegli uomini e quelle donne, saliti a bordo senza alcuna garanzia di ritorno, hanno messo a rischio la propria incolumità non per eroismo sterile, ma per fedeltà alla vita altrui, per dire che il silenzio non può regnare sulle macerie. In loro c’era la consapevolezza che ogni onda e ogni pattugliatore potevano trasformarsi in condanna, eppure hanno proseguito, facendo del proprio corpo una fragile diga contro l’orrore.
Hobbes ci avvisa che l’uomo è in guerra permanente: “bellum omnium contra omnes”, ogni uomo contro ogni uomo. E Gaza è oggi la dimostrazione più tragica di quel princìpio. Non soltanto perché i bombardamenti sembrano privi di limiti; non solo perché la legge internazionale appare un guscio vuoto, un richiamo che non ferma le esplosioni o i carri armati. Ma perché la guerra, in se stessa, induce la dissoluzione dell’umano: il gesto, l’affetto, l’urlo, lo sguardo, il pianto diventano inconoscibili, o perduti, sepolti sotto cenere e disperazione.
Questa guerra è anche guerra contro il tempo, contro la memoria, contro la parola. Il tempo si dilata nei rifugi, nei tunnel, negli ospedali, nei cadaveri che restano nudi, nei corpi che vengono identificati, spesso, dopo giorni, dopo che l’aria ha già inghiottito il dolore più acuto.
La memoria ha bisogno di nomi, di volti, e spesso trova soltanto ombre. La parola, che dovrebbe denunciare, confortare, costruire, tace perché il grido è più forte, perché il pianto è più vero, perché l’orrore sfugge al linguaggio. La pace è un atto necessario. E allora Spinoza ammonisce: “la pace non è assenza di guerra, è virtù, stato d’animo, disposizione alla benevolenza, fiducia, giustizia.” La pace non è solo tregua di morti; è scelta morale. Spinoza ci dice che la pace è una costruzione interna, una disposizione dell’anima e dell’azione. In mancanza di pace interiore, ogni cessate il fuoco rischia di essere solo silenzio prima del nuovo boato.
Aristotele parlava dell’amicizia politica (philia polis): la comunità che cerca il bene comune, che riconosce l’altro non come nemico ma come compagno di destino. Quando questa amicizia è tradita o cancellata, la città si sfalda, la convivenza diventa ostile.
Kant, nella sua opera “Per la Pace Perpetua”, sostiene che la pace non sia oggetto di mera diplomazia o di equilibrio militare, ma di diritto, di istituzioni, di rispetto reciproco, di coscienza morale universale. Hannah Arendt ci ricorda la necessità del dialogo, della pluralità, del “dire no” quando la violenza diventa norma. Dissentire è un diritto e, a volte, un dovere.
E poi, fuori da Gaza, nel mondo civile che si crede distante, ma che non può più ignorare, si levano voci urlanti, proteste di dolore.
In Italia, sindacati, lavoratori, professionisti della salute, studenti si sono sollevati. Negli ultimi giorni migliaia di lavoratori e studentesse hanno partecipato a uno sciopero generale in segno di solidarietà con Gaza, coinvolgendo trasporti, scuole, servizi pubblici e porti. I portuali di Genova, Livorno, Venezia, Trieste hanno bloccato terminali e moli. Nelle città, blocchi stradali, traffico paralizzato, stazioni ferroviarie interrotte, la città ferma, come se stesse respingendo il veleno che le giunge da lontano.
Medici, infermieri, farmacisti: oltre 15.000 operatori della sanità hanno aderito a un digiuno nazionale. Hanno taciuto il corpo, ma urlato con l’altrettanto terribile silenzio della fame condivisa. Hanno detto: qui anche la salute è sotto assedio, come la vita stessa.
Unione Sindacale di Base (USB) ha proclamato uno sciopero nazionale per fermare ciò che accadrebbe se si continuasse a tollerare, a permearsi, a complicitarne il male. “Blocchiamo tutto.” Non è slogan: è desiderio disperato che il mondo non accetti questa strage come inevitabile.
Oltre la carne, oltre il sangue: la vita sociale distrutta, il senso di casa cancellato, il diritto al futuro estirpato. Bambini che non sanno cosa vuol dire giocare; genitori che non hanno forza per piangere; anziani traditi dalla loro stessa fragilità; corpi gettati dove si può, come resti inermi che nessuno reclama; vite interrotte senza domande, alcune senza nome.
Testimonianze che parlano di esecuzioni sul campo, di intimidazioni, di arresti arbitrari, del terrore che segue ogni notte, del suono lontano delle bombe come se fosse il battito di un cuore impazzito.
E poi la fame: perché non solo le bombe uccidono. La fame, la sete, la mancanza di cure, la malattia sono calamità che avanzano nel silenzio, invisibili agli occhi chiusi degli spettatori lontani. I documenti dicono che “l’insicurezza alimentare” non è semplice effetto collaterale: per molti è condizione voluta, pianificata.
Così Gaza non è soltanto una mappa, non è soltanto un titolo nei giornali: è un’agonia che chiede di essere vista, che non può più essere negata.
Ma quante volte possiamo sopportare il grido? Quante volte possiamo voltare lo sguardo? Il sangue di un bambino non si disperde uniformemente nel vento: resta, si coagula, opprime, accusa!
Chi scrive, chi protesta, chi digiuna, chi scende in piazza, chi raccoglie testimonianze: tutti sono chiamati a non lasciare che Gaza diventi un capitolo che “non si poteva evitare”. Perché evitare è scegliere. Tacere è scegliere.
E allora che la pace sia, più che un desiderio, resistenza. Resistenza alla brutalità, all’oblio, all’indifferenza. Che le mani che costruiscono ponti di solidarietà — scioperando, manifestando, denunciando — siano quelle che, un giorno, possano ricomporre il volto umano del mondo.
Non sappiamo quante gradinate restino per fermare questo orrore, ma ogni passo, ogni voce, ogni protesta è un mattone. E se Gaza ci chiede di scegliere — di essere pieni di benevolenza, fiducia, giustizia — allora scegliamo, ora, mentre il grido è ancora udibile, prima che nulla rimanga se non cenere di corpi morti e silenzio.
Ernesto Mastroianni