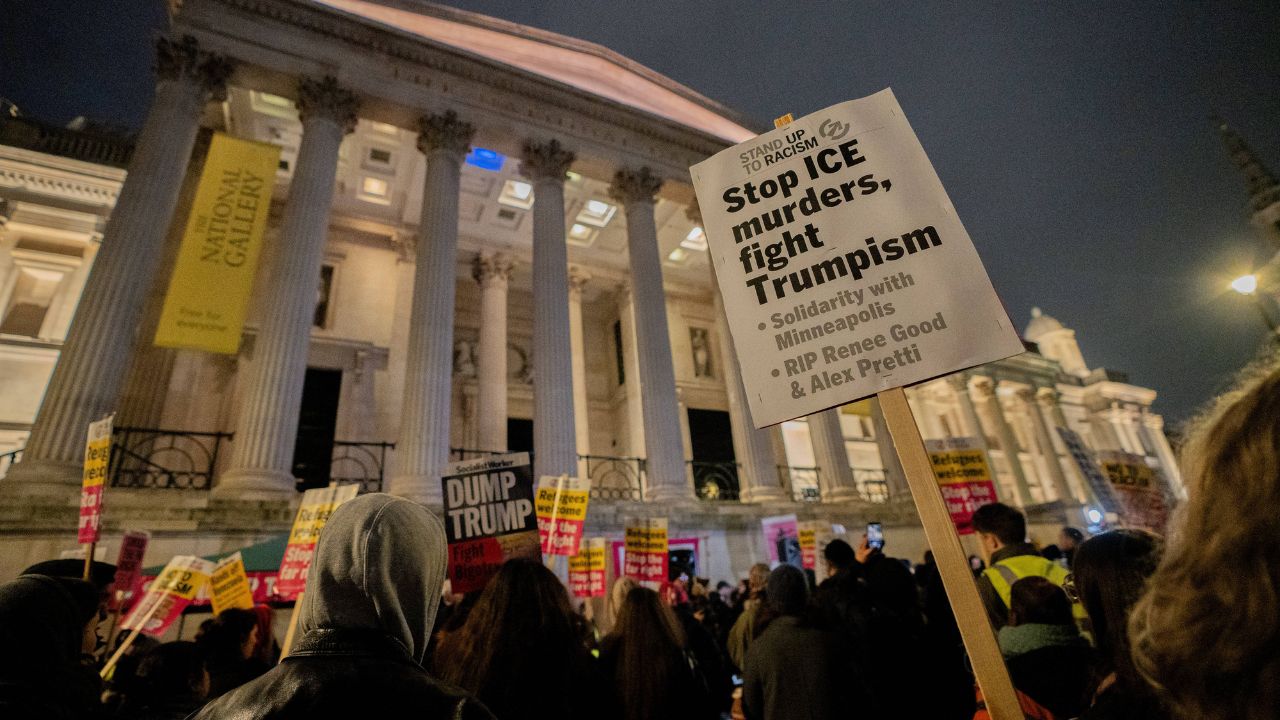Quando la giustizia entra nel perimetro del centrosinistra italiano, gli equilibri si incrinano. E il referendum sulla separazione delle carriere sta diventando la nuova faglia interna del Partito democratico. È una discussione carsica, che si alimenta di memorie, principi costituzionali, diffidenze antiche e una tensione politica evidente: opporsi compatto alla riforma voluta dal governo Meloni oppure rivendicare una cultura garantista che una parte della tradizione progressista considera propria.
La linea ufficiale del partito, che si muove in sintonia con il Movimento 5 Stelle e con l’Associazione nazionale magistrati, è nota: difesa del modello attuale, timore che la separazione delle carriere apra la strada a un indebolimento dell’autonomia del pubblico ministero e denuncia di un’impostazione considerata penalizzante per l’equilibrio dei poteri. Ma la disciplina interna vacilla. Non per timore, ma per convinzioni politiche profonde.
Goffredo Bettini, figura simbolica della storia democratica e memoria vivente del Pds-Dl-Pd, è stato il primo a rompere l’argine, annunciando l’intenzione di votare Sì. Un messaggio pesante, poi modulato dopo le reazioni: «Non si tratta di fare la guerra ai magistrati ma di rimettere al centro l’equilibrio della Costituzione». E ancora: «Se il referendum diventerà l’occasione della Meloni per sfondare su tutta la linea, all’ultimo valuterò con molta attenzione il mio voto». Segno che la tensione esiste e non riguarda solo tecnicismi giuridici, ma la postura del Pd in questa fase politica.
Accanto a Bettini, altri nomi di peso: Stefano Ceccanti, costituzionalista e già parlamentare dem, Giorgio Tonini, Enrico Morando, Claudia Mancina. Tutti pronti a sostenere il Sì in nome di una visione liberal-garantista, e per rivendicare una battaglia che, nella loro lettura, appartiene storicamente alla sinistra riformista. Claudio Petruccioli, ex dirigente Pci e poi presidente Rai, ha già annunciato il suo voto favorevole, seguito da figure come Cesare Salvi. A sostenere apertamente il fronte referendario anche figure come Paola Concia e Chicco Testa, che parlano di “battaglia di civiltà” e accusano parte della sinistra di “regalare al centrodestra un tema che in altre democrazie è dato per acquisito”.
Sul fronte istituzionale, a muoversi con prudenza ma in modo eloquente è Vincenzo De Luca. Il presidente della Campania ammette di essere «tormentato», ma aggiunge che «molto probabilmente voterò Sì». Parole che confermano come il dissenso non sia confinato a correnti marginali, ma attraversi il corpo vivo del partito e coinvolga amministratori di peso.
La segretaria Elly Schlein osserva e ascolta. La linea ufficiale resta quella dell’opposizione, ma i riformisti chiedono una Direzione per discutere. Vogliono che il Pd non si appiattisca sulla posizione dei magistrati e dei Cinque Stelle, denunciando il rischio di un’immagine “corporativa” e poco riformista. Una sensibilità condivisa, in parte, anche da chi, come Michele Emiliano, pur non annunciando il Sì, invita l’Anm a «darsi una calmata» e a non trasformare la propria posizione in una barricata politica.
La questione, per il Pd, è più ampia del quesito referendario. È un bivio identitario: riproporre la postura del fronte contro il governo, o mostrare una visione autonoma su giustizia e garanzie? Nelle prossime settimane la discussione entrerà nel vivo. Per ora, la sensazione è che la frattura sia aperta e che il voto referendario rischi di lasciare segni profondi. La leadership Schlein si trova davanti a una scelta delicata: mediare e tenere insieme le diverse anime, o accettare una spaccatura che potrebbe ridefinire, ancora una volta, la geografia interna del centrosinistra. Il test non è solo di merito. È di identità e di futuro.